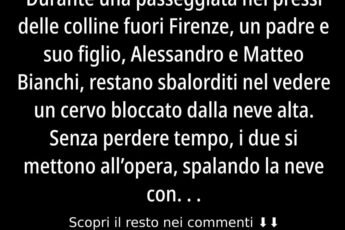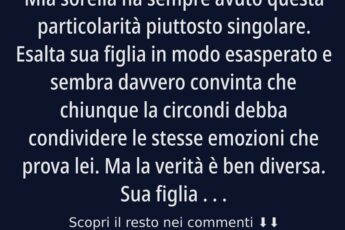Avevo solo quindici anni quando mia madre annunciò che si sarebbe risposata. A me, la sua unica figlia, mi mandò senza rimpianti a vivere con la nonna. Ero d’intralcio alla sua “nuova vita”. Né lettere, né telefonate, né un centesimo di aiuto. Lei aveva tutto: un uomo, una nuova famiglia, mentre io avevo solo il vecchio bilocale della nonna e la sua pensione, che bastava appena per il necessario. Ma la nonna mi amava incondizionatamente, nonostante la modestia. Non mi divideva in “sua” e “non sua”. Condivideva con me tutto: calore, gioia, dolore. Sono cresciuta con lei, con la sua cura, e le sono stata grata per ogni abbraccio, per ogni fazzoletto che asciugava le mie lacrime.
Quando la nonna morì, ero al secondo anno dell’università. Funerali, shock, vuoto. Ma una cosa mi consolava: rimanevo nel suo appartamento. Un’eredità lasciata non per diritto, ma per amore. Io, unica parente, diventai la legittima proprietaria di quel posto dove per la prima volta avevo sentito di essere amata.
Passarono alcuni anni. Quasi mi ero dimenticata di mia madre, come di un brutto capitolo della mia vita. E poi, all’improvviso, un colpo alla porta. Era lì. Non un “ciao”, non un “come stai”. Solo una richiesta.
“Stiamo stretti nel nostro bilocale. Tu hai un trilocale. Facciamo cambio. Sono tua madre!”
La guardai, e dentro di me bruciavano dolore e rabbia.
“Non ti sono servita allora,” dissi. “Perché dovrei servirti adesso?”
“Perché sono tua madre!” strillò. “E vivrò nel tuo appartamento! Come puoi essere così ingrata?”
Chiusi la porta. Pensai fosse finita. Ma non era così.
Passarono altri sette anni. Ero sposata, crescevo mio figlio. Io e mio marito lavoravamo, pagavamo il mutuo per la macchina nuova, facevamo lavori in casa nei weekend, godendoci ogni sera insieme. E poi, di nuovo, un colpo alla porta.
Apro, e la vedo lì. Invecchiata, smarrita. Ancora nessun “ciao”, solo una richiesta:
“Mi fai stare da te per un po’?”
Mio figlio corse nel corridoio e chiese: “Mamma, chi è?”
“Sono tua nonna,” sbottò lei.
“Mamma, è vero?” chiese il bambino con diffidenza.
“Va’ in camera, piccolo,” sospirai. “Te lo spiego dopo.”
Quando rimanemmo sole, scoprii che suo marito era un truffatore. L’aveva convinta a vendere la casa, promettendole una più grande, poi era sparito con i soldi. Lei era rimasta con niente. Era venuta da me, la figlia che una volta aveva cacciato via senza esitazione.
“So che non mi lascerai per strada. Sono tua madre! Ti ho cresciuta io!”
“Tu? Cresciuta?” Stavo per ridere dal dolore. “Mi ha cresciuta la nonna. Tu mi hai abbandonata per un uomo. E ora vuoi vivere nella mia casa?”
Rimase da noi un paio di giorni. L’ho sfamata, le ho dato un letto. Poi chiamai sua cugina, che viveva in campagna. Cercavano aiuto in cucina in un agriturismo locale. La zia accettò. Mia madre partì. Ma non in silenzio. Urlò nel corridoio come se fossi una straniera:
“Sei una figlia indegna! Pagherai per questo!”
Io restai sulla soglia, muta. Perché non volevo più urlare. Perché avevo già perdonato. Ma riaccendeMa riaprire la porta della mia vita non era più possibile, perché certe ferite, anche se guarite, lasciano cicatrici che non si cancellano.