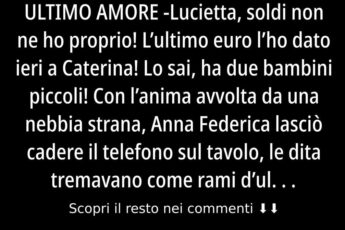Si dice che con l’età ognuno raccoglie ciò che ha seminato. C’è chi si ritrova circondato dall’affetto dei cari e chi, invece, si becca solo la porta in faccia. Mia suocera, Enrica Rossi, non è mai stata una donna dolce. Si è sempre comportata con un’aria di superiorità, come se tutti le dovessero qualcosa—specialmente suo figlio unico. E io, ovviamente, ero “quella sciagurata che gli ha rubato il figlio”.
Anni fa, quando ero incinta del secondo figlio e mio marito aveva perso il lavoro, non riuscivamo più a pagare il mutuo. Chiedemmo asilo a Enrica, nella sua spaziosa trilocale a Bergamo, ereditata da suo padre. All’epoca ci vivevano già lei, il figlio minore Lorenzo e ora anche noi con i due bambini. Speravamo fosse una sistemazione temporanea, ma presto diventò un inferno.
Enrica non perdeva occasione per criticare. I bambini la disturbavano, puzzavano, i loro giocattoli sul divano la mandavano su tutte le furie. Il cibo per il piccolo lo chiamava “quella pappa schifosa” che le occupava il frigo. Io stavo zitta, ingoiavo tutto per evitare guai. Ma un giorno ci disse chiaramente:
“Avete rotto. Prendete le vostre cose e andatevene. Non ce la faccio più a vivere in questo bordello.”
Ci sentimmo umiliati. Avevamo pochi soldi dopo aver venduto il vecchio appartamento e pagato i debiti. Con fatica comprammo una casetta a Lodi—senza acqua, senza bagno. Il gabinetto era in fondo al giardino e l’acqua si prendeva dal pozzo.
Piano piano, mattone dopo mattone, ricostruimmo la nostra vita. Usammo il bonus bebè, poi un altro prestito. Dieci anni dopo, finalmente, ci trasferimmo in una casa vera—non un palazzo, ma con doccia, riscaldamento e una cucina nuova. Proprio quando sembrava finito il peggio, e stavamo pensando a un terzo figlio, il destino bussò alla porta. O meglio, era Enrica.
Sentii il cancello aprirsi. Sulla soglia c’era lei, col cappotto, una valigia e gli occhi gonfi di pianto. Quando mio marito aprì, si buttò tra le sue braccia singhiozzando come se la nostra casa fosse l’ultimo rifugio al mondo.
La facemmo entrare, le offrimmo un caffè. Mio marito chiamò Lorenzo—niente da fare. Solo verso sera si riprese.
Scoprimmo che, dopo la nostra cacciata, aveva provato a “rieducare” il figlio minore. Gli sussurrava che il fratello era un traditore e che io avevo rovinato la famiglia. Alla fine, Lorenzo si sposò e se ne andò. Ma non per sempre. La prese a vivere con la moglie. All’inizio era tranquillo, poi nacque un bambino. Enrica ricominciò: odori, rumori, minestre sbagliate. Solo che stavolta la nuora non era paziente come me.
Presto la trasferirono dalla stanza al divano. Poi neanche lì. La camera divenne una cameretta, il suo posto a tavola fu occupato da altri, e alle lamentele rispondevano: “Se non ti piace, prendi e vai.”
“Perché non provi da Matteo?” le disse una sera Lorenzo—lo stesso che anni prima l’aveva aiutata a cacciarci.
Così, in men che non si dica, le misero in mano la valigia, le pagarono il taxi per la stazione e il biglietto. All’uscita, Lorenzo aggiunse:
“Non ti cancelliamo dalla residenza. Goditi pure la pensione di Milano. Vivi dove vuoi, ma non qui.”
Non potevamo lasciarla per strada. A casa nostra c’è posto. Per ora sta zitta. Nessun rimprovero, nessuna lamentela. Ci guarda, soprattutto i bambini, con uno sguardo spento e pentito.
Forse la vecchiaia ammorbidisce il cuore. O forse è solo la paura di restare soli. Non so. Per ora taccio. Ma una cosa è certa: io non caccio nessuno. Neanche lei. Neanche chi un tempo ci cancellò dalla sua vita.