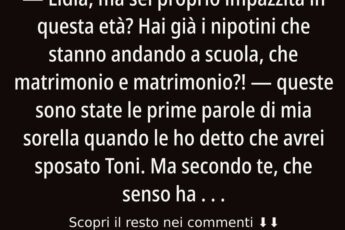Tutto era normale nel crescere i nostri tre gemelli finché uno di loro non cominciò a dire cose inspiegabili.
Li abbiamo cresciuti nello stesso modo, ma un giorno, uno dei tre iniziò a parlare di cose che nessun bambino di sette anni dovrebbe conoscere.
Fin dallinizio, la gente scherzava dicendo che non li avremmo mai distinti. Per questo gli regalammo dei papillon: uno blu, uno rosso e uno verde acqua. Tre gemelli identici, con le stesse lentiggini, un linguaggio segreto tra loro e labitudine di finirsi le frasi a vicenda. Era come crescere ununica anima divisa in tre corpi.
Poi, un giorno, Elio quello con il papillon verde acqua cominciò a svegliarsi in lacrime. Non per gli incubi, ma per quello che lui chiamava “ricordi”.
“Vi ricordate la vecchia casa con la porta rossa?”, chiese una mattina.
Noi non la ricordavamo. La nostra casa non aveva mai avuto una porta rossa.
“Perché non vediamo più la signora Langella? A me dava sempre caramelle alla menta.”
Non conoscevamo nessuno con quel nome.
Poi arrivò la notte in cui sussurrò: “Mi manca la Fiat verde di papà, quella con il parabrezza ammaccato.”
Non avevamo mai avuto una Fiat.
Allinizio ridevamo, pensando fosse fantasia. Ma il tono di Elio non era giocoso. Parlava con una calma certezza, come se ricordasse davvero il suo passato.
Presto cominciò a disegnare. Pagine e pagine dello stesso posto: una casa con la porta rossa, tulipani in giardino e edera che saliva lungo il camino. I suoi fratelli lo trovavano “figo”. Lui, invece, sembrava triste, come se avesse perso qualcosa di prezioso.
Un giorno, mentre frugavo in garage, mi chiese del suo vecchio guanto da baseball.
“Tu non giochi a baseball, piccolo”, gli dissi.
“Invece sì”, rispose piano. “Prima della caduta.” Si toccò la nuca.
Allora lo portammo da un medico. Il pediatra ci indirizzò a uno psicologo. La dottoressa Berger lo ascoltò attentamente e disse che i suoi ricordi non erano semplici fantasie. “Alcuni li chiamano ricordi di vite passate”, spiegò. “Controversi, sì, ma reali per il bambino.”
Non volevo crederci. Ma poi la dottoressa Riva, una ricercatrice, chiese a Elio durante una videochiamata:
“Come ti chiamavi prima?”
“Daniele”, rispose. “Daniele Conti o Forlani. Vivevo in Emilia-Romagna. In una casa con la porta rossa.”
Raccontò di essere caduto da una scala mentre sistemava una bandiera. Un trauma alla testa. Dolore. Buio.
Qualche giorno dopo, la dottoressa Riva ci chiamò. Aveva trovato un articolo: Daniele Forlani, Parma. Morto nel 1987 a sette anni per una frattura al cranio dopo una caduta.
La foto che ci mandò mi gelò il sangue. Quel bambino somigliava a Elio. Gli stessi riccioli, gli stessi occhi.
Dopo, Elio sembrò più tranquillo, come se avesse chiuso un capitolo. Smise di disegnare. I ricordi strani svanirono. Tornò a giocare con i fratelli, ridendo come prima.
Ma poi arrivò una lettera. Senza mittente. Dentro, una foto di una casa con la porta rossa, un giardino di tulipani, un camino avvolto dalledera. Sotto, una firma tremante: “Pensavo vi sarebbe piaciuta. Signora Langella”
Non avevamo mai parlato di lei con nessuno. Tranne che con Elio. E con la dottoressa Riva, che poi sparì senza lasciare traccia.
Anni dopo, a quindici anni, trovai una scatola da scarpe sotto il letto di Elio. Dentro, una sola biglia, blu con spirali verdi. Sul fondo, un biglietto scritto a matita: “Per Elio da Daniele. Tu lhai trovata.”
Quando gli chiesi da dove venisse, Elio sorrise.
“Alcune cose non hanno bisogno di spiegazioni, papà.”
Ancora oggi non so se credo nelle vite passate. Ma credo in Elio. Nella pace che ha dentro, nella saggezza che non dovrebbe avere alla sua età, e nel modo in cui a volte guarda il cielo come se si ricordasse di qualcosa di lontano.
I bambini arrivano con le loro storie. A volte, quelle storie non sono nostre per essere capite. Solo per essere abbracciate.