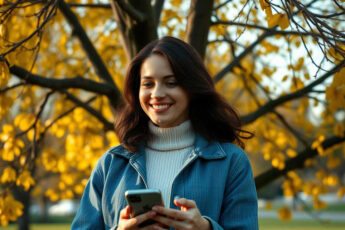La chiave in mano
La pioggia batteva ritmicamente contro il vetro della vecchia finestra, come se la città intera avesse deciso di suonare il proprio requiem. Marcello sedeva sul bordo del letto sfondato, tutto curvo, come se desiderasse diventare trasparente, invisibile al destino che si appesantiva sulle sue spalle.
Le sue mani grandi, un tempo abituate a comandare le macchine nella fabbrica di auto di Torino, ora riposavano sulle ginocchia, gonfie e confuse, le dita che ogni tanto si chiudevano come a voler afferrare un fantasma. I suoi occhi scrutavano le pareti ricoperte dalle vecchie tappezzerie, dove le macchie dumidità disegnavano la mappa dei suoi viaggi inutili: dalla USL del quartiere al privato studio di via Po. Lo sguardo era opaco, impolverato come una vecchia pellicola dimenticata in soffitta.
Un altro dottore, unaltra voce compassata: Eh, signor Cattaneo, ormai letà fa la sua parte. Nessuna rabbia. La rabbia serve energia, e la sua era evaporata. Rimaneva solo una stanchezza di fondo, simile alla ruggine.
Il dolore nella schiena per Marcello era ormai diventato uno scenario fisso, il sottofondo stonato di ogni azione, il mormorio noioso dellimpotenza che copriva tutto il resto.
Ha seguito le istruzioni dei medici: prendeva le pillole, si spalmava le pomate puzzolenti, disteso freddo sulla brandina dellambulatorio di fisioterapia, come un ingranaggio scartato.
E intanto aspettava. Lento, più per abitudine che per fede, sperando in un miracolo: lo Stato, un grande specialista, la soluzione geniale della scienza. Qualcuno che lo tirasse fuori dal suo pantano, lui che si lasciava andare piano, con la dignità delle vecchie statue.
Guardava lorizzonte della propria vita, ma vedeva solo la cortina grigia della pioggia oltre il balcone. La sua volontà, la stessa che un tempo spostava pesi nei reparti e aggiustava tutto a casa, ora serviva solo a tollerare e sperare in qualcosa di esterno.
La famiglia Era stata la sua ancora, eppure si era sciolta come zucchero nel caffè. Il tempo era passato veloce, senza avvertire. Prima era partita la figlia: la cara Azzurra, tutta dritta verso Milano, in cerca di luce. La lasciò andare senza rimpianti; si vuole sempre il meglio per quella che resta lunica figlia. Papà, ti aiuterò, appena mi sistemo, diceva al telefono. Ma non era importante.
Poi anche la moglie se nè andata. Non al mercato, ma altrove. Renata si è consumata in fretta: un tumore spietato, troppo tardi scoperto. Marcello rimase, non solo con la schiena dolente, ma anche col peso sordo della colpa dessere rimasto in piedi, vivo a metà, mentre la sua forza, il suo motore, la sua Renata sfumava nel giro di tre mesi. Fino allultimo, la assistette come poteva, stringendole la mano finché i suoi occhi non brillarono di quelladdio sottile. Lultima cosa che disse fu: Tieniti forte, Marce E lui si ruppe, sentì il cuore spezzarsi senza ritorno.
Azzurra telefonava, lo voleva da lei, nel piccolo bilocale in affitto vicino ai Navigli. Ma che ci stava a fare là? Ospite, ingombro. Non voleva importunare. E lei non pensava più a tornare indietro.
Ora, lunica che gli faceva visita era Maria, la sorella minore di Renata. Una volta a settimana, come da liturgia, portava una vaschetta di minestrone, riso o pasta col ragù, e un nuovo blister di antidolorifici.
“Come va, Marcello?” chiedeva togliendosi il soprabito. Lui annuiva. “Tutto bene.” Restavano a fissarsi in silenzio, mentre Maria riordinava la sua tana, come se mettere ordine nei cassetti potesse rimettere in sesto anche lui. Poi se ne andava, lasciando nellaria il profumo di un altro destino e un senso tangibile di dovere, compiuto e mai scelto.
Grato era, eppure infinitamente solo. La solitudine aveva la forma di una cella, fatta di incapacità, rimorsi e una rabbia muta per il mondo storto.
Una sera, più malinconica del solito, lo sguardo gli cadde sul tappeto sfilacciato. A terra, semi nascosta dalla polvere, una chiave: quella di casa, sfuggita dalla tasca durante lultima, faticosa passeggiata dal medico.
Solo una chiave. Niente di strano. Ma Marcello la fissò come se fosse la reliquia di un miracolo, o una porta segreta. Immobile, silenziosa. Aspettava.
Gli venne in mente il nonno. Di botto, come un lampo dentro una notte elettrica. Il nonno Carlo, senza un braccio, infilava il moncherino nella cintura e con la mano rimasta si legava le scarpe usando una forchetta piegata, con pazienza da scultore. “Vedi, Marcello,” diceva, e negli occhi brillava la voglia della mente di piegare la realtà, “lattrezzo è sempre lì. A volte ti sembra spazzatura, ma ti salva la vita se la sai vedere.”
Da ragazzino, Marcello pensava che fosse solo una favoletta per nonni, una storia da bar. Ma ora, guardando quella chiave, la scena diventava un richiamo sottile, non una lezione ma una sfida. Il nonno non stava lì ad aspettare. Prendeva quello che cera: una forchetta, una scarpa, e vinceva. Non la malattia, non il lutto: vinceva limpotenza.
E invece lui, Marcello? Solo attese, amare come un digestivo dopo cena, poggiate sulluscio dellaltrui carità. Sentì rabbia. Ma questa rabbia scatenò qualcosa.
Quella chiave, ora, sembrava ordinare. Si alzò: con un gemito, timoroso anche davanti alla stanza vuota.
Fece due passi strascicati, sentì le ossa schioccare come bicchieri difettosi. Raccolse la chiave. Cercò dirrigidirsi in piedi, e il solito coltello di dolore gli tagliò la schiena. Restò fermo, mascella serrata, a lasciar passare londa. E invece di tornare a sedere, a restare schiavo del letto, avanzò piano verso il muro.
Non pensò troppo. Seguì solo quellistinto minuto: girò la schiena alla parete, premette il dorso della chiave, dove più lo pungeva il dolore.
Piano, con cautela da vetraio, si appoggiò con tutto il peso. Non era fisioterapia, non era medicina. Era scontro. Pressione cieca di realtà contro realtà, dolore su dolore.
Trovò un punto dove la sfida si tramutava in una tregua: una strana, sorda leggerezza, come se qualcosa dentro avesse mollato un poco la presa. Spostò la chiave più in alto, poi più in basso. E ancora premette, e ripeté.
Ogni movimento, lentissimo, era un dialogo col proprio corpo. Non era una cura. Era come trattare. Lo strumento, una chiave da portone.
Stupido? Forse. Ma la sera dopo, quando il dolore tornò, ripeté. E ancora. Scoprì i punti dove la pressione alleviava invece di aumentare quel fuoco dentro, quasi stesse aprendo le sue tenaglie dallinterno.
Poi cominciò a sfruttare anche lo stipite del portone, per stirarsi piano. Vide il bicchiere sul comodino e si ricordò di bere acqua. Solo acqua. Gratis.
Marcello smise di aspettare. Usò quello che cera: la chiave, il battente della porta, il pavimento per allungarsi, la propria testardaggine. Iniziò un quaderno, non sul dolore, ma su piccole “vittorie della chiave”: Stamattina sono rimasto ai fornelli cinque minuti in più.
Sul davanzale mise tre vecchie scatolette di tonno, avanzate da mesi. Le riempì con terra del giardinetto. In ciascuna piantò qualche spicchio di cipollotto. Non era un orto. Erano tre barattoli di vita, ora suoi.
Dopo un mese, dal dottore, mentre questi fissava incredulo le lastre nuove, Marcello sorrise.
Ci sono miglioramenti. Ha fatto qualcosa? chiese il medico.
Sì rispose Marcello, asciutto. Ho usato quello che avevo.
Non parlò della chiave: il dottore non avrebbe capito. Ma Marcello, sì, sapeva bene. La salvezza non arrivò su una nave. Era a terra, silenziosa, mentre lui fissava il muro. Bastava chinarsi a prenderla.
Un mercoledì, quando Maria venne col minestrone, restò immobile sulla porta. Sul davanzale, nei barattoli di latta, il cipollotto era una macchia di verde. La stanza odorava di qualcosa di fresco e di speranza.
Ma cosa sono? balbettò lei guardandolo, con lui che stava dritto e sicuro accanto alla finestra.
Marcello, mentre annaffiava con calma dal suo mug sbeccato, si voltò.
Lorto, disse semplicemente. Ne vuoi un po’ per la zuppa? Fresco, appena tagliato.
Quella sera si fermò più a lungo del solito. Bevettero tè; lui, senza lamentarsi della salute, raccontò della scala nel palazzo, e di come ora saliva ogni giorno un piano in più.
La salvezza non era arrivata sotto forma di Mago Merlino o del Dottor Avventura. Si era mascherata da chiave, da stipite consumato, da scatola di tonno e da scalini di cemento.
Non aveva cancellato il dolore, né la perdita, né gli anni. Aveva solo dato a Marcello strumenti non per vincere una guerra, ma per combattere quotidiane, minuscole battaglie.
E così, smettendo di sognare scale doro dal cielo e iniziando a vedere quella di cemento sotto ai piedi, si accorse che salire lento, attaccato alla ringhiera, gradino dopo gradino era già la vita.
E sul davanzale, in tre lattine scassate, il cipollotto cresceva fiero. Era lorto più bellissimo del mondo.