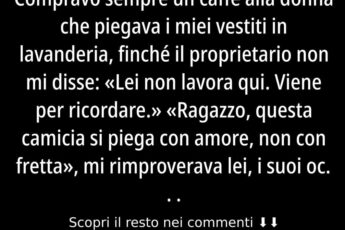Quella mattina tornai a casa dal lavoro prima del solito. Di regola arrivavo alle sette, sentivo il fritto della padella in cucina e lodore del pranzo mescolato al profumo delicato del profumo di mia moglie. Oggi, però, mi liberarono dalla riunione con largo anticipo: il capo era ammalato. Così, a quattordici, mi trovai davanti alla mia porta, sentendomi come un attore che sale sul palco fuori tempo.
Inserii la chiave nella serratura; il meccanismo fece uno scatto più forte del previsto. Nella hall, appeso a una gruccia, cera un elegante cappotto maschile di velluto, costoso, che occupava il mio posto.
Dal salotto si levò una risata femminile, bassa e vellutata, quella che avevo sempre considerato mio tesoro personale. Poi una voce maschile, appena udibile, ma dal tono sicuro e domestico.
Rimasi immobile. I miei piedi sembravano incollati al parquet che avevo scelto con Ginevra, discutendo del tono del rovere. Nel grande specchio dellingresso vidi il mio volto pallido, il completo stropicciato dal lavoro dufficio. Ero lì, ma ero estraneo.
Mi avvicinai al suono senza togliere le scarpe, violazione assoluta delle regole di casa nostra. Ogni passo riecheggiava nella testa. La porta del soggiorno era socchiusa.
Sul divano erano seduti. Ginevra, la mia Ginevra, avvolta in un accappatoio turchese che le avevo regalato per il suo ultimo compleanno. Le gambe raccolte sotto di sé, comode, casalinghe. Accanto a lei: un uomo di circa quarantanni, con mocassini di camoscio costosi, senza calzini quel dettaglio mi colpì più di ogni altro e una camicia impeccabile con il colletto aperto, che teneva un bicchiere di vino rosso.
Sul tavolino da caffè riposava la solita vasellina di cristallo, cimelio di famiglia di Ginevra, colma di pistacchi. I gusci erano sparsi sul piano.
Era la scena di unintimità domestica assoluta, non di passione né di impulso, ma di un tradimento quotidiano, più disgustoso di tutti.
Entrambi ci notammo contemporaneamente. Ginevra trasalì, il vino nel suo bicchiere schizzò, lasciando una macchia scarlatta sul suo accappatoio. I suoi occhi spalancati non esprimevano terrore, ma una confusione panica, come quella di un bambino colto in flagrante.
Lo sconosciuto posò il bicchiere sul tavolo con un gesto lento, quasi pigro. Sul suo viso non cera né paura né imbarazzo, solo una leggera irritazione, come di chi è interrotto al momento clou.
«Marco» iniziò Ginevra, ma la voce le si incrinò.
Lui non ascoltò. Il suo sguardo scivolò dai mocassini delluomo, che poteva semplicemente calzare e passare nel salotto, alle mie scarpe impolverate. Due paia di scarpe nello stesso spazio. Due mondi che non avrebbero dovuto incontrarsi.
«Credo che me ne vada», disse luomo, alzandosi con una lentezza indecorosa per la situazione. Si avvicinò a me, mi guardò non dallalto, ma con curiosità, come si osserva unesposizione al museo, annuì e si diresse verso lingresso.
Io rimasi immobile. Udii il fruscio della giacca che si allacciava, il clic della serratura. La porta si chiuse.
Rimasi solo con Ginevra nella silenziosa risonanza, interrotta solo dal ticchettio dellorologio. Laria puzzava di vino, di profumo maschile costoso e di tradimento.
Ginevra si stringeva le spalle, parlava. Parole come «non capisci», «non è quello che pensi», «stavamo solo chiacchierando» mi arrivavano come attraverso un vetro spesso. Non avevano peso.
Mi avvicinai al tavolino, presi il bicchiere delluomo. Ne proveniva un odore estraneo. Guardai la macchia rossa sullaccappatoio di Ginevra, i gusci di pistacchio, la bottiglia di vino quasi vuota.
Non urlai. Non dissi nulla. Sentii solo una sola emozione travolgente: una repulsione totale, fisica, verso tutto questa casa, quel divano, quellaccappatoio, quel profumo, me stesso.
Riposai il bicchiere al suo posto, mi girai e tornai verso lingresso.
«Dove vai?» la voce di Ginevra tremò, carica di paura.
Mi fermai davanti allo specchio. Guardai il mio riflesso, luomo che appena non esisteva più.
«Non voglio più stare qui», dissi, quasi a me stesso, «finché non si sia completamente dissipato».
Uscì dallappartamento e scesi le scale. Mi sedetti sulla panchina di fronte al portone del mio condominio. Tirai fuori il cellulare e scoprii che la batteria era quasi scarica.
Rimasi a fissare le finestre del mio appartamento, quella luce accogliente che tanto amavo, in attesa che gli odori di profumi estranei, di mocassini e di una vita che non era più la mia, si disperdessero. Non sapevo cosa sarebbe successo, ma sapevo che non cera più via di ritorno a quella versione della realtà delle quattro del pomeriggio.
Così rimasi sulla panchina fredda, il tempo scorrendo in modo diverso. Ogni secondo era una chiarezza bruciante. Vidi unombra alla mia finestra: era Ginevra, curiosa di guardarmi. Mi voltai via.
Dopo un po, forse mezzora o unora, la porta del portone si aprì. Ginevra uscì, senza accappatoio, in jeans semplici e una felpa, stringendo una coperta.
Attraversò lentamente la strada e si sedette accanto a me, lasciando tra noi un vuoto di mezzo uomo. Mi porse la coperta.
«Tienila, ti scalderebbe.»
«No, grazie», risposi senza guardarla.
«Si chiama Arturo», disse Ginevra a bassa voce, fissando lasfalto. «Ci conosciamo da tre mesi. Possiede la caffetteria accanto al mio centro fitness.»
Io ascoltavo, senza girare la testa. Il nome, il lavoro, nulla importava. Era solo decorazione al punto centrale: il mio mondo era crollato non per unesplosione rumorosa, ma per un click silenzioso, quotidiano.
«Non mi giustifico», la sua voce tremò. «Ma tu sei stato assente per un anno intero. Venivi, cenavi, guardavi il telegiornale e ti addormentavi. Hai smesso di vedermi. E lui lui ti ha visto.»
«Mi ha visto?», dissi, la voce rauca per il silenzio. «Mi ha visto bere il vino dai miei bicchieri? Mi ha visto spargere i gusci dei pistacchi sul tavolo? È quello che ha «visto»?»
Ginevra serrò i denti, gli occhi si riempirono di lacrime, ma non le lasciò scorrere.
«Non chiedo scuse. E non ti chiedo di dimenticare subito. Solo non sapevo più come raggiungerti. Forse solo trasformandomi in un mostro, sono tornata per te, luomo che hai notato.»
«Io sono qui», cominciai lentamente, «e mi disgustano questi profumi estranei nella nostra casa, i suoi mocassini. Ma più di tutto, mi disgustano i pensieri che tu possa avermi trattato così.»
Scrollai le spalle. Il freddo e limmobilità mi intorsero la schiena.
«Non andrò lì oggi», dissi. «Non riesco a entrare in quellappartamento dove ogni cosa ricorda questo giorno, a respirare quellaria.»
«Dove andrai?», la sua voce tradiva una paura animale, di perdita definitiva.
«In hotel. Devo trovare un posto dove dormire.»
Annuiò.
«Vuoi che vada da unamica? Ti lascio solo in casa?»
Scosso la testa.
«Non cambierà quello che è successo dentro. Dobbiamo aprire le finestre, Ginevra. Forse dobbiamo vendere la casa.»
Lei sussultò, come colta da un colpo. Quella casa era il nostro sogno condiviso, la nostra fortezza.
Mi alzai dalla panchina, i movimenti lenti e stanchi.
«Domani», dissi, «non parleremo. Dopodomani neanche. Dobbiamo stare in silenzio, separati. Poi vedremo se resta qualcosa di cui parlare.»
Mi voltai e camminai lungo la via, senza guardare indietro. Non sapevo dove andassi, né se sarei tornato. Sapevo solo una cosa: la vita che avevo prima di quella sera era finita. E, per la prima volta in anni, dovevo fare il passo verso lincognito, non come marito, non come parte di una coppia, ma come uomo esausto e ferito. E in quel dolore, paradossalmente, mi sentii di nuovo vivo.
Continuai a camminare, la città mi appariva straniera. I lampioni gettavano ombre nette sul selciato, facili da perdersi. Svoltai in un ostello qualunque non per risparmiare, ma per scomparire, dissolversi in una stanza senza nome, dove lodore era di candeggina e di vite altrui.
La stanza ricordava una stanza dospedale: pareti bianche, letto stretto, sedia di plastica. Mi sedetti sul bordo, il silenzio mi colpì alle orecchie. Niente scricchiolio del parquet, né rumore del frigo, né il respiro di mia moglie alle spalle. Solo il ronzio nella testa e il peso sul petto.
Misi il cellulare in carica, disponibile al banco della reception. Lo schermo si animò, notifiche di colleghi, chat di lavoro, pubblicità. Una serata normale di una persona qualunque. Come se nulla fosse accaduto. Quella normalità era insopportabile.
Mandai un SMS al capo: «Malato. Non esco per due giorni». Non mentii. Mi sentivo avvelenato.
Feci una doccia, lacqua quasi bollente, ma non percepii la temperatura. Stavo lì, testa sotto il getto, a guardare lacqua che spazzava via la polvere di quel giorno. Alzai lo sguardo e vidi nel riflesso incrinato del lavabo il mio volto stanco, stropicciato, estraneo. È così che mi vedeva Ginevra oggi? È così che sono stato per tutti questi mesi?
Mi sdraiai, spensi la luce. Loscurità non portò sollievo. Davanti ai miei occhi scorrevano immagini come diapositive maledette: il cappotto sulla gruccia, la macchia di vino sullaccappatoio, i mocassini senza calzini. E la frase più amara: «Hai smesso di vedermi».
Mi rigirai, cercando una posizione comoda, ma non cera. Tutto era brutto e fuori posto. Una voce dentro di me, che allinizio ignorai, tornava incessantemente: e se fossi stato io, con la mia indifferenza, la mia pigrizia emotiva, a spingerla tra le braccia di quelluomo con i mocassini? Non per scusarla, né per scaricare colpe su di lei, ma per capire.
Ginevra non dormiva. Vagava per lappartamento come un fantasma, le mani incrociate dietro la schiena. Si fermò davanti al divano. La macchia di vino sullaccappatoio si era seccata, diventata un segno bruno, orribile. La stracciò e la gettò nel bidone.
Poi, al tavolo, afferrò il bicchiere che Arturo aveva usato. Lo guardò a lungo, lo portò in cucina e lo scaraventò contro il lavandino. Il cristallo si frantumò in mille schegge, con un tintinnio. Si sentì più leggera. Un po.
Raccolse tutti i segni dellaltro: buttò i pistacchi, svuotò il vino rimasto, pulì il tavolo, raccolse i frammenti. Ma il profumo del suo profumo maschile rimaneva nellaria, impregnato di tende, di tappezzeria. Era ovunque. Come il senso di vergogna, e uno strano, contorto sollievo. La bugia era divenuta verità. Il dolore, tangibile.
Si sedette sul pavimento del soggiorno, avvolse le ginocchia e, finalmente, si permise di piangere. Silenziosamente, senza singhiozzi. Lacrime salate e amare scivolavano da sole. Piangeva più per il crollo dellillusione di un matrimonio felice che per il dolore che le aveva inflitto Marco.
Al mattino mi svegliai a pezzi. Ordinai un caffè al bar sotto casa e mi sedetti alla finestra, osservando la città che si svegliava. Il cellulare vibra. Un messaggio di Ginevra.
«Non chiamare, scrivi solo se stai bene».
Legsi il messaggio. Era semplice, umano. Non cerano urla, né pretese. Cera solo cura. Quella stessa cura che forse avevo smesso di notare.
Non risposi. Avevo promesso di stare zitto. Ma per la prima volta in quel giorno, la rabbia e il disgusto dentro di me si fecero spazio a un piccolo territorio di qualcosa di diverso. Vago, incerto. Non speranza. Più curiosità.
E se, dietro questo incubo, dietro questo dolore, potessimo riscoprire lun laltro? Non come nemici, ma come due persone stanche e sole, che un tempo si amavano e forse si erano perse?
Finii il caffè, posai la tazza sul tavolo. Davanti a noi cerano giorni di silenzio. Poi una conversazione. E pensai che forse la paura non era quella di parlare, ma quella di non cambiare nulla.
Non credono più alle favole. Il loro amore non è perfetto, è ferito e logorato. Ma nel momento in cui tutto crollò, videro nei frammenti non solo odio, ma anche una possibilità. Una possibilità di ricostruirsi non come erano, ma come potrebbero diventare. Perché il vero amore non è quello che non conosce cadute, ma quello che trova la forza di rialzarsi dalle ceneri.