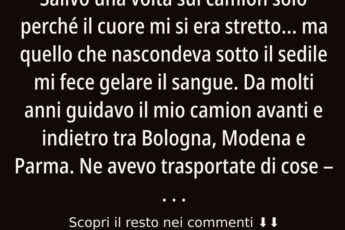Casa di Nessuno
Sergio si svegliò senza bisogno della sveglia, come sempre, alle sei e mezza. In casa regnava il silenzio, solo il leggero ronzio del frigorifero si percepiva dalla cucina. Rimase un momento sdraiato, ad ascoltare quel suono familiare, poi si allungò verso il davanzale per prendere gli occhiali. Fuori lalba stava lottando con la notte, e qualche rara auto scivolava sullasfalto umido.
Un tempo, a quellora, si preparava per andare in ufficio. Si alzava, andava in bagno, ascoltava il vicino che accendeva la radiolina dietro il muro. Ora il vicino continuava a mettere la radio, ma lui rimaneva a fissare il soffitto pensando a cosa avrebbe occupato la sua giornata. Tecnicamente era in pensione da tre anni, ma la vecchia abitudine del ritmo scandito gli era rimasta attaccata addosso.
Si alzò, indossò i pantaloni della tuta, e raggiunse la cucina. Mise a bollire lacqua per il tè, prese da una dispensa un pezzo del pane rimasto dalla sera prima. Mentre lacqua scaldava, si avvicinò alla finestra. Settimo piano, palazzo di cemento, cortile con struttura per i giochi dei bambini. Giù, sotto le finestre, la sua vecchia Fiat Panda, ormai coperta da uno strato di polvere. Pensò, quasi senza volerlo, che sarebbe ora di passare dal box, controllare se il soffitto perdeva.
Il box era al parcheggio cooperativo, tre fermate di autobus più avanti. Una volta ci passava mezza domenica: a trafficare sulla macchina, cambiare lolio, chiacchierare con gli altri dei prezzi della benzina e del campionato. Poi tutto cambiò: meccanico, gommista, negozio online. Ma il box non lo aveva mai abbandonato. Là aveva gli attrezzi, le gomme vecchie, scatole piene di cavi, tavole, roba da bricolage, come diceva lui.
E poi la casetta fuori città. Un piccolo rifugio in una cooperativa orti vicino Pavia. Casa in legno, veranda stretta, due stanze, una cucina minuscola. Quando chiudeva gli occhi, vedeva ancora quelle assi, le fessure nel pavimento, sentiva la pioggia tamburellare sul tetto. La casetta laveva avuta in eredità dalla famiglia di sua moglie. Ventanni abbondanti prima ci andavano quasi ogni weekend con i figli. Zappavano lorto, friggevano le patate, mettevano la radio su uno sgabello e vivevano senza pensieri.
Sua moglie se ne era andata già da quattro anni. I figli erano cresciuti, ognuno con la sua casa, la sua famiglia. Rimanevano la casetta e il box, come ancore in un mondo che mutava. E poi cera lappartamento di Milano. Ecco: la casa, la casetta, il box. Tutto al proprio posto, tutto chiaro.
Il bollitore fischiò. Sergio versò il tè, si sedette al tavolo. Sulla sedia di fronte, un maglione piegato dalla sera prima. Mentre addentava la fetta di pane, il pensiero correva alla sera precedente.
Ieri erano venuti i figli. Il figlio maggiore con la moglie e il nipotino, la figlia con il marito. Tè, biscotti, discorsi sulla prossima estate, su chi va in vacanza. Poi, come ormai spesso accadeva, la conversazione prese la solita piega: i soldi.
Il figlio raccontava della rata del mutuo che cresce, che soffocava. La figlia si lamentava del costo dellasilo nido, dei corsi per bambini, dei vestiti. Sergio annuiva, ricordando come lui stesso aveva contato gli spiccioli a fine mese. Ma allepoca niente box, niente casetta: solo una camera in affitto e tanta speranza.
Poi il figlio, abbassando gli occhi, aveva detto:
Papà, abbiamo pensato un po con Anna Anche con Chiara ne abbiamo parlato. Forse potresti vendere qualcosa. La casetta, magari. O il box. Tanto, non ci vai quasi mai…
Sergio aveva scherzato, aveva sviato il discorso. Ma la notte fu lunga, la frase tanto non ci vai continuava a girargli in testa.
Finito il pane, svuotò la tazza, mise a posto. Otto in punto. Decise che sarebbe andato davvero, quel giorno, alla casetta: controllare come aveva resistito linverno. E, forse, dimostrare a sé stesso qualcosa.
Si vestì pesante, prese dallingresso i mazzi di chiavi, li mise in tasca. Davanti allo specchio vecchio del corridoio si fermò a guardarsi. Nel riflesso vide un uomo dagli occhi stanchi, ma ancora solido. Non ancora vecchio. Sistemò il colletto e uscì.
Al box passò prima, a prendere qualche attrezzo. La serratura stridette, la porta cedette con lo sforzo abituale. Dentro odorava di polvere, benzina, stracci vecchi. Sugli scaffali, barattoli con viti, scatole di cavi, una cassetta con su scritto radio a pennarello. Una ragnatela pendeva dal soffitto.
Sergio scrutò le mensole. Ecco il cric della prima macchina. Ecco le tavole che avrebbe dovuto trasformare in una panca per la casetta. Mai fatta, ma stavano lì, ad aspettare.
Prese la cassetta degli attrezzi, alcune taniche vuote, chiuse il box e partì.
Unora di strada fuori Milano, tra i resti di neve sporca e terra nera. Nella cooperativa orti il silenzio era quasi irreale. Troppo presto per le invasioni primaverili. La portinaia, Teresa, avvolta nel piumino, gli fece un cenno dal casotto.
La casetta lo accolse con la stessa immobilità di sempre tra le stagioni. Recinzione di legno, cancello appeso precario. Aprì, avanzò sul sentiero stretto. Sotto i piedi scricchiolavano le ultime foglie.
Dentro sapeva di chiuso, di legno. Sergio spalancò le finestre. Tolse la vecchia coperta dal letto, la scosse fuori. In cucina, sulla tavola, una pentola smaltata, dove un tempo la moglie preparava la composta di frutta. Al chiodo vicino alla porta, la mazzetta di chiavi: tra quelle anche per il ripostiglio degli attrezzi.
Girò le stanze, accarezzò i muri, le maniglie. Nella stanzetta dei figli ancora un letto a castello; sul ripiano in alto un orsetto abbandonato, con un orecchio cucito alla meglio. Ricordava le lacrime del figlio per quellorecchio strappato e lui, impossibilitato a trovare la colla, lo aveva riattaccato col nastro isolante.
Sullorto la neve era quasi scomparsa, le zolle nere e fradice. In un angolo il barbecue arrugginito. Gli tornò in mente il fumo delle grigliate, lui e la moglie seduti sulla veranda col tè nei bicchieri di vetro, le risa degli amici sul terreno vicino.
Sergio sospirò e si mise al lavoro. Pulì il vialetto, fissò una tavola traballante, controllò il tetto del ripostiglio. Trovò una vecchia sedia di plastica, la sistemò in giardino, si sedette. Il sole era alto, laria più tiepida.
Guardò il cellulare. Il figlio lo aveva chiamato la sera prima. La figlia aveva scritto: bisogna parlarne con calma. Non siamo contrari alla casetta, papà, ma ragiona con noi, diceva il messaggio.
Ragionare. Da mesi questa parola martellava nelle conversazioni. Ragionare voleva dire non lasciare i soldi fermi. Ragionare era che un pensionato non doveva faticare con orto e box. Ragionare voleva dire aiutare i giovani, finché era in vita.
Li capiva, questo sì. Ma lì, seduto sulla sedia, col sole, i rumori lontani di una campagna che riprendeva fiato, ogni ragionamento sembrava lontanissimo. Qui non era questione di calcolo.
Fece un altro giro dellorto, chiuse bene la casa, mise il grosso lucchetto alla porta. Poi via verso Milano, tra le prime rondini.
Dopo due ore era di nuovo nel suo appartamento. Lasciò la giacca, gli attrezzi in ingresso. Solo allora notò il biglietto sul tavolo: Papà, passiamo stasera a parlarne. C.
Si sedette, mani appoggiate sul tavolo. Oggi sarebbe stato il giorno della verità. Senza battute, senza vie di fuga.
Quando arrivarono erano in tre: il figlio con la moglie e la figlia. Il nipotino era rimasto coi nonni materni. Sergio aprì, li salutò, li fece entrare. Il figlio tolse le scarpe, appese la giacca come mille volte da ragazzino.
Si sedettero in cucina. Sergio servì tè, biscotti, cioccolatini. Nessuno li toccava. Per qualche minuto parlarono di poco o nulla: il lavoro, le notizie, il traffico in città.
Poi la figlia guardò il fratello, e lui le fece cenno.
Papà, parliamone sul serio. Non vogliamo pressarti, ma dobbiamo trovare una soluzione.
Sergio sentì un nodo stringersi dentro. Annuì.
Ditelo.
Il figlio prese la parola.
Hai questo appartamento, la casetta e il box. Lappartamento non si tocca, quello è sacro. Ma la casetta Tu stesso dici che è faticoso. I lavori, il tetto, il giardino. Ogni anno si spendono soldi.
Oggi ci sono stato, disse piano Sergio. È tutto a posto.
Ora sì, si intromise la nuora, ma tra cinque o dieci anni? Non vivrai in eterno. Scusa, ma dobbiamo pensarci.
Sergio abbassò lo sguardo. Parole dure, forse non dette per ferire, ma taglienti.
La figlia intervenne più dolcemente.
Non diciamo che devi mollare tutto. Potresti vendere casetta e box, dividere i soldi. Una parte per te, una a noi. Potremmo estinguere un pezzo di mutuo. Tu stesso hai sempre detto che avresti voluto aiutarci.
Lui laveva detto, anni prima. Quando era fresco di pensione e aveva ancora contratti di collaborazione. Gli pareva di essere robusto allinfinito, di poter lavorare ancora, dare una mano.
Vi aiuto già, rispose. Porto il nipote a scuola, vi faccio la spesa.
Il figlio sorrise, tirando su le spalle:
Non basta. Adesso serve una cifra, papà. Tu stesso hai visto i tassi dinteresse. Non ti chiediamo di darci tutto. Ma hai beni che restano inutilizzati.
In cucina la parola beni risuonò estranea. Un pilastro invisibile li separava: fatto di numeri, tabelle, bonifici.
Sergio si strinse attorno alla tazza, sorseggiò il tè ormai freddo.
Per voi sono beni, disse piano. Per me sono
Tacque. Cercò il termine.
sono pezzi di vita. Il box lho costruito insieme a mio padre, con le nostre mani, mattoni su mattoni. E la casetta lì sono cresciuti i miei figli. Voi.
La figlia abbassò gli occhi, il figlio restò in silenzio. Poi riprese con voce meno tesa:
Lo capiamo, davvero. Ma non ci vai quasi più, papà. Sta lì, fermo. Non ce la farai da solo ancora a lungo.
Oggi ci sono stato, ripeté Sergio. Va tutto bene.
Oggi, disse il figlio. Ma prima di oggi? In autunno? Papà, per favore.
Silenzio. Dal soggiorno arrivava il ticchettio dellorologio. Improvvisamente vedeva chiarissimo: erano riuniti lì per discutere la sua vecchiaia come un fascicolo da ottimizzare. Ottimizzare spese, redistribuire immobili.
Va bene. Cosa proponete, allora?
Il figlio si animò: avevano già organizzato tutto.
Abbiamo contattato unagenzia. Si può ricavare qualcosa di buono dalla casetta. Il box lo vendiamo anche. Facciamo tutto noi: visite, documenti, pratiche. A te basta delegare.
E lappartamento? domandò Sergio.
Quello resta tuo, rispose pronta la figlia. È casa tua.
Annunciata così, la parola casa pesava. Era solo questo appartamento, la casa? O anche la casetta? Anche il box, dove si sentiva ancora utile?
Sergio si alzò, raggiunse la finestra. In cortile già accendevano i lampioni. Era uguale a ventanni prima, ma le auto erano cambiate, i bambini avevano il cellulare.
E se io non volessi vendere? chiese senza voltarsi.
Ancora più silenzio. Poi la figlia disse sottovoce:
Papà, è tuo. Decidi tu. Solo ci preoccupiamo. Tu stesso hai detto che hai meno forze.
Ne ho meno, sì. Ma posso ancora decidere come occupare le giornate.
Il figlio sospirò.
Papà, non è voglia di litigare. Ma a volte sembra che tu ti attacchi alle cose e noi restiamo bloccati. Anche mentalmente, oltre che economicamente. Pensiamo spesso a quando non ce la farai più. Chi va alla casetta, chi sistema tutto?
Sergio provò un senso di colpa. Ci aveva pensato spesso anche lui. Se fosse mancato dun tratto, i figli avrebbero dovuto districarsi tra pratiche, eredità, divisioni. Sarebbe stato pesante.
Rientrò e si sedette.
Se volle dire ma si fermò. Se intestassi la casetta a voi, ma ci andassi finché ce la faccio?
Figlio e figlia si guardarono. La nuora si rabbuiò.
Ma papà, resta comunque un impegno. Noi non riusciremo mai a venire spesso. Lavoro, figli
Non chiedo di venire. Solo lasciatemela fino a che posso.
Era un compromesso, lo sapeva. Per sé, la possibilità di restare nel luogo che era la sua vita. Per loro, la certezza di aver già sbrigato le future beghe.
La figlia ci pensò su.
Si può fare Ma voglio essere sincera, papà. Noi difficilmente ci vivremo. Anzi, forse ci trasferiamo. Con Gianluca pensiamo a Piacenza, è più economico, cè lavoro.
Sergio trasalì: questo non lo sapeva. Il figlio stesso si irrigidì.
Non me lavevi detto
Stiamo solo valutando, tagliò corto lei. La casetta per noi non è essenziale.
La parola futuro risaltò. Per loro era altrove: altre città, altri progetti. Per lui, il futuro si restringeva a pochi luoghi: lappartamento, il box, la casetta.
Il tira-e-molla durò ancora venti minuti: loro offrivano numeri, lui ricordi. Loro parlavano di salute, lui del vuoto senza impegni manuali. A un certo punto il figlio, stanco, tagliò corto:
Papà, capiscilo, non ti vedo a zappare lorto per sempre. Prima o poi non ti reggerai più in piedi. E allora, che facciamo? Tutto marcisce?
Sergio sentì la rabbia salire.
Per te è solo roba marcia? Tu ci hai corso, in quellorto.
Da bambino! Ora sono grande, ho altro da pensare!
Le parole rimasero a mezzaria. La figlia tentò di mediare:
Gianluca, dai
Ma ormai era chiaro: parlavano lingue diverse. Per lui, la casetta era la vita vissuta; per loro, un passato dolce, ma già chiuso.
Sergio si alzò.
Daccordo. Fatemi pensare. Non oggi, non domani. Serve tempo.
Anche noi non possiamo rimandare Fra poco tocca pagare le rate
Ho capito, lo anticipò. Ma non è come vendere una sedia.
Ci fu silenzio. Poi si prepararono per uscire. In corridoio si persero tra scarpe e giacche. La figlia lo abbracciò, si strinse a lui.
Non è la casetta il problema, sussurrò. Temiamo solo per te.
Lui annuì, la voce strozzata.
Quando uscì la porta, la casa fu piena di una nuova, densa solitudine. Sergio andò in cucina, si sedette. Tazze a metà, biscotti avanzati. Le guardò a lungo, sentendo la stanchezza pesargli sulle spalle.
Restò a lungo così, nella penombra. Fuori cadeva il buio, i palazzi di fronte si illuminavano. Poi si alzò, andò a prendere dal cassetto la cartella coi documenti. Carta didentità, atti della casetta, del box. Sfilò il piano del terreno: un rettangolo con le aiuole disegnate. Passò il dito sulle linee come se scorresse i sentieri veri.
Il giorno dopo scese al box. Aveva bisogno di muovere le mani. Lì dentro faceva freddo. Aprì le porte per far entrare la luce. Sistemò gli attrezzi, svuotò scatole. Buttò via parte del ciarpame: pezzi rotti, viti arrugginite, cavi da tenere per sicurezza.
Il vicino del box, Mario, di qualche anno più vecchio, passò.
Sistemi la roba vecchia?
Eh, pulizia di primavera, rispose Sergio. Sto pensando a cosa tenere.
Hai ragione, annuì Mario. Io il box lho venduto. Mio figlio aveva bisogno per prendere la macchina. Ora non ce lho più, ma lui è contento.
Sergio non rispose. Mario tornò nelle sue cose, lui rimase fra le scatole, pensieroso. Venduto: semplice, come dare via un cappotto.
Prese in mano una chiave inglese, la maneggiò. Si ricordò di quando il figlio, piccolo, voleva sempre aiutare. Allora pensava che sarebbero sempre rimasti vicini. Box, casetta, macchina un modo di dialogare.
Ora, quel linguaggio era diventato estraneo al figlio.
La sera risfogliò i documenti, poi telefonò alla figlia.
Ho deciso, disse. Intestate la casetta a te e a Gianluca. In parti uguali. Ma non vendetela per ora. Quando non ce la farò più, fate voi.
Dallaltra parte silenzio.
Sei sicuro? domandò lei.
Sì, disse, anche se dentro di sé la sicurezza era poca. Sentiva solo che tagliava un pezzo importante, ma non cera altra via.
Bene, disse lei. Vediamoci domani, sistemiamo le pratiche.
Chiuse la chiamata e si rimise a sedere. La casa pareva piena di quiete. Si sentiva sì stanco, ma anche stranamente sollevato. Come se avesse fatto quello che doveva, anche se non lo voleva.
Una settimana dopo andarono dal notaio. Fecero il passaggio. Sergio firmò con la mano che tremava. Il notaio spiegava tranquillo, i figli lo ringraziavano.
Grazie, papà. Ci aiuti tanto, gli disse il figlio.
Lui annuiva; sapeva che a fondo era anche per sé: non doveva più pensare al dopo. Il dopo era scritto, il peso spartito.
Il box lo tenne. I figli accennarono a venderlo, lui fu fermo: ancora no. Ne aveva bisogno, per non vivere attaccato al divano. Questo almeno glielo concessero.
La vita proseguì uguale. Rimasto a Milano, la casetta fuori, ogni tanto ci andava, ormai da ospite formale. Ma le chiavi le aveva lui, nessuno lo fermava.
La prima volta tornò da solo, in un giorno di pieno aprile. In viaggio pensava: non è più mia. È di altri. Ma appena aprì il cancello, ne sentì ancora la familiarità.
Entrò, posò la giacca sul vecchio chiodo. Le stanze come sempre: letto sfatto, tavolo, orsetto sullarmadio.
Si sedette vicino alla finestra. Un raggio di sole puntava sul davanzale impolverato. Passò la mano sul legno, ne sentì ogni nodo.
Pensò ai figli. A loro, presi dalla quotidianità, bollette, piani futuri. A sé stesso, con i piani ridotti alle stagioni: arrivare alla prossima primavera, ancora una zappata allorto, unaltra estate in veranda.
Ormai sapeva: prima o poi lavrebbero venduta la casetta. Un anno, cinque, quando non ce lavrebbe fatta. E avevano ragione anche loro: tenere vuota una casa non aveva senso.
Ma ora la casa era ancora in piedi. Il tetto solido. Gli attrezzi in ripostiglio. Nellorto già spuntava il verde. Lui ancora poteva camminare sullerba, chinarsi, scavare.
Uscì fuori, fece il giro della proprietà. Guardò i vicini: su un orto qualcuno già piantava, su un altro stendevano i panni. La vita andava avanti.
Capì che la vera paura non era la casetta o il box: era diventare inutile. Escluso non solo dai figli, ma da sé stesso. Questi posti provavano che esisteva ancora. Che poteva ancora far qualcosa.
Ora questa prova era fragile. Le carte da notaio dicevano una verità, le abitudini unaltra. Ma, seduto sul gradino, comprese che non tutto era definito dalle proprietà.
Prese il thermos, versò il tè. Bevette, ascoltandosi. Un po damaro restava, ma meno che quella sera in cucina. Aveva scelto. Conosceva il prezzo. Aveva dato ai figli un pezzo di sé, ma aveva ottenuto altro: il diritto di stare lì, non per i documenti, ma per la memoria.
Guardò la chiave, la ruotò tra le dita. Vecchia, consumata. Già sapeva: prima o poi passerà a Gianluca, a Chiara, o a chi comprerà la casa. La infileranno nella serratura senza immaginare il peso di quel movimento.
Da questa idea sentì tristezza, ma anche una specie di pace. Il mondo ruota, le cose cambiano proprietario. Limportante è vivere nei propri posti, finché sono davvero nostri, a prescindere dalla carta.
Finito il tè, si alzò. Andò al ripostiglio a prendere la zappa. Tempo di smuovere almeno una fila nellorto. Per sé. Non per i futuri padroni, non per i figli magari già pronti a contarne il valore. Per se stesso, per sentire la terra sotto i piedi e sulle mani.
Affondò la zappa nella terra. Girò la prima zolla, annusò lodore fresco. Si chinò ancora una volta.
Lavorava adagio; la schiena doleva, le mani pesanti, ma ogni colpo lo alleggeriva un poco. Era come smuovere, insieme alla terra, anche le paure.
A sera si sedette sulla scala del portico. Davanti a lui lorto, i solchi neri, il cielo si era fatto rosa. Una voce di uccello si alzò tra gli alberi.
Guardò la casa, le sue orme, lattrezzo poggiato al muro. Pensò a cosa sarebbe successo domani, tra un anno, tra cinque. Nessuna risposta. Solo la certezza che, per ora, era al suo posto.
Si alzò, entrò, spense le luci, chiuse le porte. Sul portico si fermò un momento, ascoltando la quiete. Poi girò la chiave nella serratura: il suono del metallo risuonò netto.
Sergio infilò la chiave in tasca e si incamminò verso la sua Panda, percorrendo piano il sentiero, facendo attenzione a non calpestare la terra appena lavorata.