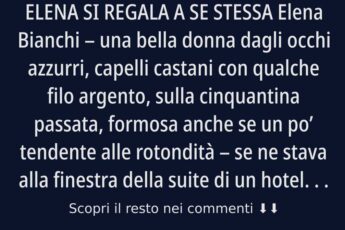Ciao, ti raccontò quello che è successo dopo la sepoltura di Giuseppe, mio marito. Il figlio, Andrea, mi ha portata su una strada di campagna e mi ha detto: «Qui è il tuo posto».
Non ho pianto al funerale. Non perché non amassi Giuseppe abbiamo vissuto insieme quarantadue anni, tra povertà, malattie e qualche raro momento di gioia ma perché le lacrime erano rimaste intrappolate dentro, come un sasso in gola. Non le ho lasciate uscire né al cimitero né quando la vicina, la signora Bianchi, è venuta con una zuppa e mi ha detto: «Stia forte, Valentina». Ho annuito, ho sorriso educatamente e ho chiuso la porta.
Andrea, alto e distinto, era in un elegante completo nero che doveva costare più della mia pensione semestrale. Mi ha sostenuta al gomito, come si fa in una famiglia rispettabile, ma la sua mano era gelida, non per il freddo, ma perché mi stringeva più come un dovere che come un affetto.
Al pranzo funebre ha fatto discorsi, alti e pomposi, con pause e gesti. Tutti lo applaudivano: «Che figlio! Che bravo! Che intelligente!». Io, in disparte, lo guardavo: il volto era familiare e allo stesso tempo estraneo. Occhi di me, naso di papà, sorriso di uno sconosciuto, di quelluomo che non era più mio figlio.
Il terzo giorno, dopo la sepoltura, è venuto a casa mia. Stavo preparando il caffè, forte come quello che Giuseppe amava, con latte e senza zucchero unabitudine che è rimasta. Andrea si è seduto al tavolo, ha messo davanti a me le chiavi della macchina e il passaporto.
«Mamma, ho pensato a tutto», ha detto. «Ti conviene trasferirti in una casa di riposo, in campagna. È tranquilla, accogliente, laria è più pulita e ci sono altri pensionati. Così non dovrai più stare sola in quellappartamento. Tu sai comera il papà quando era malato»
Non ha finito la frase, ma ho capito il senso: «Anche tu potresti morire», o meglio ancora, «È meglio se te ne vai, così non ostacoli più».
Sono rimasta in silenzio, continuando a bere il caffè bollente, bruciandomi le labbra, solo per non tremare, non urlare, non lanciare la tazza contro di lui.
Mi aveva già tolto lappartamento e lattività, ora erano tutte mie. Papà aveva firmato tutto a mio nome lanno prima, sempre preoccupato di non farmi arrabbiare, di evitare litigi.
Sapevo che, poco prima di morire, Giuseppe aveva trasferito tutto al figlio senza chiedermi nulla. Non mi sono opposta, pensavo: «Che importa, limportante è che il figlio sia vicino e si prenda cura di me». Stupida, davvero.
«Capisci, mamma, che lì da sola non farai, ha continuato, sei stanca, sei vecchia. Lultima frase lha detta con dolcezza, quasi con compassione, come se stesse diagnosticando una malattia.
«Quando?», gli ho chiesto.
Probabilmente aspettava lacrime, urla, minacce. Io ho chiesto semplicemente: «Quando?».
«Domani, alla mattina. Verrò a prenderti. È già tutto pronto, non devi neanche imballare le cose, tutto è lì. Prendi solo lessenziale. E non ti preoccupare, ti farò visita, lo prometto».
Mi ha mentito, lo sapevo bene, non sarebbe venuto più. Mai.
Il mattino dopo è arrivato a bordo del suo Ferrari. Sono uscita con la valigia: foto di Giuseppe, passaporto, qualche soldo che avevo messo da parte per anni, e un taccuino di ricette, le sue preferite. Andrea ha aperto il bagagliaio, ha lanciato la valigia dentro come se fosse un sacco di patate, poi mi ha aperto la portiera. Mi sono seduta sul sedile posteriore senza neanche un andiamo. Ha messo in moto e via, dal cortile.
Guidavamo in silenzio. La città dietro, poi la periferia, poi la campagna. La strada si è trasformata in sterrata piena di buche. Guardavo fuori: alberi, silenzio, uccelli, bellezza e paura.
«Andrea, dove è questo posto di riposo?», ho chiesto.
Non ha risposto subito, poi ha lanciato: «Vedrai».
Vent minuti più tardi ha svoltato su una stretta strada di bosco. Lauto saltellava su dossi. Mi aggrappavo alla maniglia della porta, il cuore batteva forte, non per le vibrazioni ma per la prescienza.
Si è fermata, è uscito, mi ha aperto la porta. Sono uscita. Intorno nessuno, nessuna casa, solo foresta fitta, scura e silenziosa.
«Ecco, il tuo posto», ha detto.
Lho guardato, il suo viso era sereno, quasi soddisfatto.
«Che significa il mio posto?», ho chiesto.
«Come è», ha risposto. «Capisci da sola. Qui sarai al sicuro, tranquilla, nessuno ti disturberà».
Ha posato una borsa accanto a me: cibo per due giorni. «Sei una donna intelligente, ti arrangierai».
Sono rimasta immobile, con nella testa un ronzio bianco, come se avessero spento il suono del mondo.
«Mi lasci qui? In questa foresta?», ho implorato.
Ha scrollato le spalle.
«Non ti lascio, ti rilascio. Presto te ne andrai lo stesso. Perché non vuoi più lappartamento? Perché la città? Tu mi ostacoli. Onestamente, sei solo un ricordo di quello che dovevo provare».
Lha detto con la stessa leggerezza con cui si fa la spesa.
«Andrea», ho sussurrato, «sono tua madre».
«Allora sei un peso», ha corretto. «Scusa, ma così è meglio per tutti».
È tornato allauto, ha acceso il motore. Io ho cercato di afferrare la porta, ho urlato: «Aspetta! Ti do tutto! Lappartamento, i soldi, tutto! Non lasciarmi qui!».
Ha premuto lacceleratore, lauto è balzata in avanti, io sono caduta, mi sono scontrata il ginocchio contro una pietra, ho urlato, ho cercato di inseguire lauto, ma non si è voltato.
Sono rimasta a terra, il ginocchio sanguinante sotto i collant. Il dolore non era solo fisico, ma dentro, dove una volta batteva il cuore.
Ho aperto la borsa, ho tirato fuori una bottiglia dacqua, dei panini, una tavoletta di cioccolato. Forse Andrea voleva che morissi lentamente, così la coscienza non lo perseguitava. Ho mangiato il cioccolato, bevuto lacqua, mi sono alzata e ho guardato intorno.
Solo foresta, nessuna strada, né sentieri umani, solo tracciati di animali e un silenzio opprimente. Ho camminato, senza meta, forse verso un ruscello, forse verso la morte, non mi importava più.
Dopo unora ho trovato un ruscello sottile, lacqua era limpida. Lho bevuta con le mani, mi sono lavata, ho osservato il mio riflesso: capelli bianchi, rughe, occhi vuoti, come se dentro non ci fosse più nessuno.
«Sei vecchia», ha detto la voce nella mia testa.
Sì, vecchia, ma non morta.
La notte lho trascorsa sotto un pino, avvolta nel mio cappotto, tremante non per il freddo ma per la rabbia e il dolore. Ho pensato a Giuseppe, al suo sorriso, al tè alla menta che mi preparava quando ero malata, alle sue mani che mi stringevano nei momenti di paura, alle sue parole: «Sei la mia roccia». Ora sono solo un oggetto gettato via, spazzatura.
Ma non volevo morire qui, così.
Il mattino dopo ho continuato a camminare, tutto il giorno, senza una meta, solo per non impazzire.
Il terzo giorno ho trovato una strada di terra battuta. Cerano persone, un camion si è fermato. Il conducente, un uomo di circa cinquantanni, dal volto gentile, mi ha chiesto: «Signora, dove sta andando?».
Non sapevo cosa rispondere, ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente: «Al centro, a mio figlio».
Ha annuito, ha aperto la portiera: «Sali, ti porto».
Sono salita, ho tenuto il silenzio per tutto il tragitto. Ha acceso la radio, una vecchia canzone italiana, ho chiuso gli occhi, ho pianto, quelle lacrime che non uscivano da tre giorni finalmente scorrevano come un fiume.
Si è fermato alla stazione degli autobus. Mi ha dato una bottiglia dacqua e un panino, e mi ha detto: «Non si preoccupi, tutto si sistemerà».
Ho annuito, ringraziato e sono scesa.
In città ho corso alla stazione di polizia, ho raccontato tutto così comè, senza addolcirlo, senza pianti, solo i fatti. Lufficiale ha ascoltato, ha scritto, ha scrollato la testa: «Capisce che senza prove non possiamo fare nulla? Non lha picchiata, non lha minacciata, lha solo abbandonata in una foresta. È un caso triste, ma legalmente non è un crimine».
Guardavo le sue spalline, i suoi occhi indifferenti.
«Allora può farlo di nuovo, con qualcun altro? E non avrà conseguenze?».
«Senza prove, sì», ha risposto. «Le consiglio di parlare con un avvocato o con i servizi sociali, forse le possono dare una sistemazione».
Sono uscita, cominciava a piovere leggermente, la gente correva, nessuno guardava una vecchia con una valigia.
Sono andata in biblioteca, ho usato internet gratuito, ho scritto lettere al pubblico ministero, alla commissione per i diritti umani, ai giornalisti.
Una settimana dopo una giovane giornalista del quotidiano locale mi ha telefonato: «Valentina, vogliamo pubblicare la sua storia, la gente deve sapere».
Ho raccontato tutto, senza abbellimenti. Larticolo è uscito tre giorni dopo, titolo: «Figlio abbandona la madre nella foresta: Il tuo posto è qui».
La foto mostrava me al funerale, vestita di grigio, gli occhi vuoti. In poche ore centinaia di commenti, migliaia di condivisioni. La gente era indignata, piangeva, chiedeva giustizia.
Il giorno dopo ho ricevuto una chiamata da Andrea. «Mamma, che cosa hai fatto?!».
«Sono viva», ho risposto.
«Mi stai uccidendo! Mi hanno licenziato! La moglie se nè andata! I figli hanno vergogna a scuola! Capisci cosa hai combinato?!».
«Capisco», ho detto. «Mi hai lasciata nella foresta, ho raccontato tutto al mondo. Giusto».
«Verrò, prenderò indietro tutto: lappartamento, i soldi, tutto!».
«Troppo tardi», ho replicato. «Non voglio il tuo appartamento. Voglio solo che tu capisca che una madre non è spazzatura, che linvecchiamento non è una condanna, che una persona non è un oggetto».
Lui è rimasto in silenzio, poi ha iniziato a piangere, davvero, per la prima volta nella sua vita.
«Scusa», ha sussurrato. «Scusami».
«Ti perdono», gli ho detto. «Quando verrai, porta dei fiori, non soldi o case. E dimmi: Mamma, ti voglio bene, e creerò un ponte se è sincero».
Una settimana dopo è tornato con dei tulipani gialli, i miei preferiti. Si è inginocchiato, ha pianto, ha baciato le mie mani.
Lho guardato, le sue lacrime, il suo terrore, il suo rimorso.
«Alzati», gli ho detto. «Non sono un dio, sono tua madre e ti perdono».
Ora non vivo più in una casa di riposo né in un appartamento. Ho affittato una piccola stanza vicino al mare, con balcone, gabbiani, sole.
Andrea mi visita ogni settimana, porta cibo, fiori, mi racconta dei figli, del lavoro, della vita. È cambiato, o forse finge, non lo so. Vedo ancora nei suoi occhi la paura di perdermi di nuovo, la paura di non essere più perdonato.
Non sono tornata a vivere con lui, non ho condiviso lo stesso tetto, ma non lho allontanato, perché credo che tutti meritino una possibilità di redenzione, anche il figlio che ti ha abbandonata nella foresta.
La sera mi siedo sul balcone, guardo il mare, penso a Giuseppe, a come sarebbe stato fiero di me, non per il fatto che sono sopravvissuta, ma perché non mi sono indurita, non mi sono spezzata, non sono diventata la donna docile che lui immaginava.
Sono viva, sono forte, sono madre.
E il mio posto non è nella foresta, né in una casa di riposo, ma dove decido io.
Oggi sono al mare, domani forse in montagna, o forse in un nuovo appartamento con i nipoti, con i tulipani sul davanzale.
Perché non sono un peso, non sono vecchia. Sono una persona, con il diritto di vivere, di amare, di essere rispettata.
Anche se mi hanno gettata nella foresta, anche se mi hanno detto: «Il tuo posto è qui».
Ho scelto un altro posto.
Ed è il mio diritto.