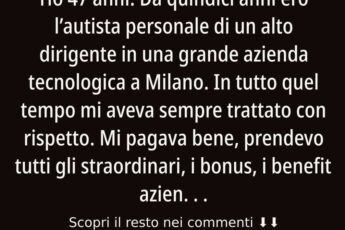Caro diario,
È stato il giorno del matrimonio di Ginevra, la nostra postina. Oh, che matrimonio non era proprio una festa, ma un amaro lutto. Il villaggio di San Martino di Valle si radunò davanti al municipio non per gioire, ma per giudicare. Lì cera Ginevra, sottile come una filigrana, in un semplice abito bianco cucito da lei stessa. Il viso pallido, gli occhi enormi, spaventati ma testardi. Accanto a lei, lo sposo, Stefano. Da sempre lo chiamavano il Carcerato. Era tornato un anno prima da terre non così lontane. Nessuno sapeva davvero per cosa fosse stato incarcerato, ma i pettegolezzi erano più spaventosi luno dellaltro. Alto, cupo, poco loquace, con una cicatrice che attraversava tutta la guancia. Gli uomini lo salutavano con il filo dei denti, le donne tenevano i figli lontani da lui, e persino i cani, appena lo vedevano, abbassavano la coda. Si era sistemato in una casupola ai margini del paese, in una vecchia dimora di suo nonno, e lavorava come boscaiolo, accettando i lavori più duri che nessuno voleva.
E fu proprio per questo che la tranquilla Ginevra, orfana cresciuta dalla zia Margherita, lo sposò. Quando il sindaco li fece passare davanti al tavolo e annunciò: «Potete congratularvi con gli sposi», nella folla non si mosse nemmeno un dito. Un silenzio tombale calò, si sentiva persino il graffio di un corvo su un pioppo. In quel silenzio avanzò il cugino di Ginevra, Pasquale, che laveva considerata una sorella minore dopo la morte dei genitori. Si avvicinò, la fissò con uno sguardo gelido e sussurrò a gran voce, affinché tutti ascollassero:
Non sei più mia sorella. Da oggi non ho più una sorella. Hai macchiato il nostro sangue. Che i tuoi passi non entrino più nella mia casa!
Lui sputò ai piedi di Stefano e si allontanò, fendendo la gente come una rotta di ghiaccio. Anche la zia lo seguì, con le labbra serrate. Ginevra rimase immobile, una sola lacrima scivolò lentamente sulla guancia, senza che la asciugasse. Stefano guardò Pasquale come un lupo, i denti stretti, i pugni serrati. Pensai che potesse scattare. Ma non lo fece; al contrario, pose delicatamente la mano sulla sua, guardò Ginevra con timore di romperla e sussurrò:
Andiamo a casa, Ginevra.
E se ne andarono, solo loro due, contro lintero villaggio. Lui alto e cupo, lei fragile nel suo vestito bianco. Alle loro spalle volava un sussurro velenoso e sguardi di disprezzo. Il mio cuore si strinse, il respiro si fece pesante. Li osservavo, giovani, e pensavo: «Signore mio, quanta forza servirà loro per resistere a tutti»
Il tutto era iniziato, come sempre, dal nulla. Ginevra portava la posta, una ragazza silenziosa, invisibile. Un autunno, in una pioggia torbida, una randaglia di cani randagi la assalì ai margini del sentiero. Lei urlò, lasciò cadere la borsa pesante, le lettere si sparpagliarono nel fango. Allora comparve Stefano, senza urlare, senza brandire un bastone. Si avvicinò al capo del branco, un grosso cane arruffato, e gli sussurrò qualcosa. Il cane, credetemi, abbassò la coda e si ritirò, seguito dal resto della cricca.
Stefano raccolse in silenzio le buste bagnate, le scrollò via la melma e le porse a Ginevra. Lei alzò gli occhi pieni di lacrime e sussurrò: «Grazie». Lui solo sbuffò, si voltò e proseguì per la sua strada.
Da quel momento lei lo guardò diversamente. Non con paura, come tutti, ma con curiosità. Iniziò a notare gesti che gli altri non vedevano: come aiutò la vecchia Maria, la nonna del villaggio, a riparare una recinzione caduta, senza chiedere nulla; come salvò un vitellino caduto in un ruscello per stoltezza; come, di soppiatto, prese un gattino infreddolito e lo portò a casa. Lo faceva in modo riservato, come se avesse vergogna della sua bontà. Ginevra lo osservava e il suo cuore solitario si avvicinò a quello di lui, anchesso ferito e solo.
Iniziarono a incontrarsi al pozzo più distante, al calar del crepuscolo. Stefano parlava poco, lei gli raccontava le sue novità semplici. Lui ascoltava e il suo volto duro si scaldava. Un giorno le portò un fiore unorchidea selvatica dei pantani, luogo temuto da tutti. Fu allora che capì di essere caduta.
Quando annunciò alla famiglia che avrebbe sposato Stefano, le lamentele furono tante: la zia pianse, il fratello Pasquale minacciò di ferirlo. Ma lei rimase ferma, come un soldatino di latta. «È un buon uomo diceva è solo che non lo conoscete.»
Così cominciarono a vivere, con difficoltà e fame. Nessuno voleva averci a che fare, nessuno li assunse stabilmente. Si arrangiavano con lavoretti occasionali. Ginevra guadagnava pochi centesimi al volo dalla posta. Ma nella loro vecchia casupola regnava comunque pulizia e, stranamente, un certo calore. Stefano le costruì scaffali per i libri, riparò il portico, sistemò un piccolo angolino di fiori sotto la finestra. Le sere, quando tornava dal lavoro, stanco e con le mani nere, si sedeva sulla panchina e lei gli porgeva una ciotola di zuppa calda. In quel silenzio cera più amore e comprensione di mille parole accese.
Il villaggio li rifiutava. Nei negozi la gente «accidentalmente» ne dava il peso sbagliato o vendeva pane indurito. I bambini lanciavano sassi contro le loro finestre. Pasquale, vedendoli per strada, li evitava deliberatamente.
Passò quasi un anno, poi avvenne lincendio. Una notte buia e ventosa, il fienile di Pasquale prese fuoco e il vento trasmise le fiamme alla casa. Scoppiò in un attimo. Il villaggio accorse con secchi e pale, ma il fuoco era una bestia che si alzava verso il cielo. La moglie di Pasquale, con il neonato in braccio, gridò con voce straziata:
Maria! Cè la bambina in casa! Sta dormendo nella sua stanza!
Pasquale cercò di aprire la porta, ma le fiamme gli sbarravano il cammino. Gli uomini lo trattennero, «ti brucerai, pazzo!». Lui lottava, urlava, impotente. In quel momento, quando tutti erano immobili, guardando il fuoco divorare la casa e la piccola, Stefano emerse dalla folla. Era uno degli ultimi ad arrivare, senza volto, ma con gli occhi fissi sulla casa. Si bagnò la testa con lacqua del barile e si lanciò nel fuoco.
Il popolo rimase a bocca aperta. Gli assi crepitavano, il tetto crollava con un fragore. Nessuno credeva più che potesse uscire vivo. La moglie di Pasquale cadde in ginocchio nella polvere. Allora, dal fumo e dalle fiamme, comparve una figura nera, traballante: era Stefano, i capelli bruciati, i vestiti anneriti. Con le mani portò in braccio la bambina avvolta in una coperta bagnata. Fece un paio di passi e crollò a terra, affidando il piccolo tesoro alle donne che correvano verso di lui.
La bambina era viva, solo un po soffocata dal fumo. Stefano, però, era unorribile visione: bruciature su mani, schiena, tutto il corpo. Io correi da lui, gli somministrai i primi soccorsi, ma lui, in delirio, mormorava solo un nome:
Ginevra Ginevra
Quando riprese conoscenza, nella nostra piccola infermeria, la prima cosa che vide fu Pasquale in ginocchio davanti a lui. Non scherzo, in ginocchio. Pasquale rimaneva immobile, le spalle tremanti, le rughe del viso bagnate da lacrime maschili. Stringeva la mano di Stefano e la premeva al suo capo. Quel silenzioso inchino parlava più di mille scuse.
Da quel giorno lincendio fu come una diga che si è rotta. Prima un ruscellino, poi un fiume in piena di calore umano verso Stefano e Ginevra. Lui si curò a lungo, le cicatrici rimarrono, ma erano nuove, non più segni di un carcerato, ma medaglie di coraggio. Il villaggio li guardò non più con timore, ma con rispetto. Gli uomini sistemarono la casa. Pasquale, cugino di Ginevra, divenne più vicino a Stefano, come un fratello. Ogni volta che serviva, era lì: riparava il portico, portava la paglia per la capra. Sua moglie, Elena, scendeva a portare a Ginevra panna fresca o a cuocere una torta.
E così, dopo un anno o due, nacque una figlia, Martina, quasi identica a Ginevra: chiara, con occhi azzurri. Poi, qualche anno dopo, un figlio, Vincenzo, un vero ritratto di Stefano, ma senza la cicatrice. Un bambinone serio, sempre accigliato.
Quella casa, restaurata da tutta la comunità, si riempì delle loro risate. E lo scoprii: Stefano, luomo cupo, era il padre più dolce del mondo. Lo vedevo tornare dal lavoro, le mani nere, stanco, e i bambini gli correvano addosso, si aggrappavano al collo. Lui li sollevava con le sue mani robuste, li lanciava verso il soffitto, e il loro riso riempiva tutta la casa. La sera, quando Ginevra metteva a letto il più piccolo, lui sedeva accanto alla grande, Martina, e intagliava piccoli giocattoli di legno: cavalli, uccellini, buffi personaggi. Le sue dita grosse creavano figure vivide, quasi animate.
Ricordo una visita per misurare la pressione di Ginevra. Nel cortile cera un dipinto ad olio: Stefano, enorme, accucciato, riparava la bicicletta di Vincenzo, mentre Pasquale teneva la ruota. I due ragazzi, vicini, giocavano nella sabbiera, costruendo castelli. Un silenzio pacifico avvolgeva la scena, rotto solo dal ticchettio di un martello e dal ronzio delle api tra i fiori di Ginevra.
Guardo loro, gli occhi ancora lucidi, e vedo Pasquale, colui che aveva maledetto la sorella e si era allontanato, al fianco del suo carcerato. Nessuna rabbia, nessun ricordo di vendetta. Solo lavoro, bambini che giocano insieme. Come se il muro di paura e giudizio non fosse mai esistito, sciolto come neve di primavera al sole.
Ginevra uscì sul portico, portò loro due bicchieri di acqua fresca di limonata. Mi guardò, sorrise con quel suo sorriso tranquillo e luminoso. In quel sorriso, nel modo in cui guardava il marito, il fratello e i bambini, cera tutta la felicità conquistata a fatica, e il mio cuore si fermò. Non si era sbagliata. Aveva seguito il suo cuore contro il mondo intero e aveva trovato tutto ciò che cercava.
Ora guardo la loro strada. La casa è avvolta da gerani e petunie. Stefano, ormai con i capelli brizzolati, ma ancora robusto, insegna a Vincenzo a tagliare la legna. Martina, ormai una giovane donna, aiuta Ginevra a stendere il bucato che profuma di sole e di vento. Ridono tra loro, condividendo un piccolo segreto femminile.