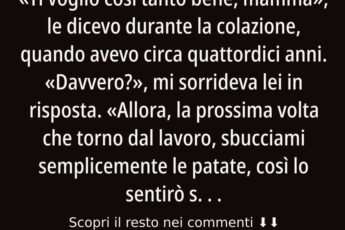Mele sulla neve…
A vivere alla periferia di Rocca Azzurra, proprio al confine con la foresta antica dove gli abeti sembrano sorreggere il cielo e persino di giorno è buio per via degli aghi, cera Giovanni Luigi Zaccaria. Un uomo di quelli temprati dalla vita.
Da sempre lavorava nella forestale, conosceva ogni albero della zona, ogni burrone, ogni tana di volpe, ogni sentiero che i cinghiali calpestavano. Aveva mani enormi come pale, piene di calli e segnate dal lavoro, nere per la resina che era ormai entrata nella pelle per sempre, e il cuore il cuore pareva scolpito da una quercia antica: forte, affidabile, ma duro, che mai si piegava.
Con la moglie Antonina viveva in perfetta armonia da trentanni. Erano una bella coppia, gente che colpiva al passaggio. Se ti capitava di passare davanti a casa loro di sera, li vedevi seduti sul portico: Giovanni con la fisarmonica, le dita che si muovevano lente, e Antonina che gli cantava accanto con una voce limpida. Una melodia talmente dolce che restavi ad ascoltare a occhi chiusi. E la loro casa era proprio un gioiello: persiane intagliate, dazzurro come gli occhi di Antonina, un giardino di flòx e lorto curato, nemmeno un filo derba fuori posto.
Ricordo quando piantarono il loro meleto. Giovanni scavava le buche nella terra nera e grassa, mentre Antonina teneva i piccoli alberi, sistemando le radici come fossero capelli di un bimbo, sussurrando: Crescete, dolci miei, fate frutti buoni per i nostri figli. E Giovanni la guardava, si asciugava il sudore dalla fronte e sorrideva con una luce che non gli ho più visto negli occhi. Quel frutteto è cresciuto meravigliosamente, ogni primavera si copre di fiori bianchi, e a settembre laria si riempie di profumo di mele croccanti, succose.
Ma Antonina se lè portata via la malattia quando era ancora giovane. Si è spenta in tre mesi, come un ramo essiccato al sole, e se nè andata in silenzio, stringendo la mano di Giovanni nel sonno. Da quel giorno lui si è fatto cupo, la disperazione ha annerito i suoi occhi, ma lacrime non ne ha mai versate un uomo, si sa, non può piangere. Stringeva i denti così forte che pareva si spezzasse la mascella e in una notte sola i capelli gli sono diventati bianchi.
Rimase solo, con la figlia nata tardi, Annetta. Lei era la sua luce, lunica ragione per cui restava aggrappato alla vita in quella solitudine di boschi. Stravedeva per lei, la proteggeva in modo goffo, da orso: era severo, non concedeva mai nulla, la teneva lontana da tutto, persino dal vento primaverile. Aveva una paura folle, viscerale, che anche lei lo avrebbe lasciato, proprio come la madre. E questo timore lo fece diventare ancora più oppressivo. Non le permetteva di fare un passo fuori dal suo controllo.
Annetta, sei la mia speranza, le diceva mentre le carezzava la testa con la sua mano grossa. Crescerai, diventerai padrona di casa, tutto qui resterà a te. Non ti lascerò mai andare. Qui stiamo bene. A cosa ti serve quel mondo fuori? Lì ti ingannano, ti fanno del male, ci sono lupi con il volto umano.
La ragazza cresceva ed era uno splendore: una treccia bionda, densa, lunga fino alla vita, occhi blu come il cielo di aprile, proprio come quelli del padre. E la voce! Quando usciva fuori dal paese e intonava una canzone, tutti rimanevano in silenzio: persino gli uccelli tacevano e i contadini abbandonavano la falce per ascoltarla a bocca aperta.
Le donne piangevano con le sue melodie dicevano che aveva preso il talento dalla madre, ma il suo canto era ancora più puro. Era un dono del Cielo, un talento raro. Annetta sognava di fare la cantante, di andare a Firenze, studiare in conservatorio. Leggeva libri di musica, imparava le note, consumava i vecchi dischi del padre sul giradischi a forza di ascoltarli.
Giovanni però ragionava a modo suo, da uomo di campagna, con la diffidenza antica: Dove nasci, lì servi. Temendo la città come il fuoco che divora i boschi, pensava che avrebbe inghiottito e cambiato tutto, perdendo i valori di una volta. Credeva che la città fosse come una bestia insaziabile.
Non ti ci mando! tuonava, con voce che faceva tremare i bicchieri nella credenza. Lavorerai in stalla, sposerai Pietro il trattorista, un ragazzo serio e lavoratore, costruisce la sua casa, avrai figli come tutte le donne! Vuoi fare la cantante? Vergogna!
In un umido pomeriggio di ottobre, la diga si ruppe. Annetta, sempre calma e obbediente, si ribellò allimprovviso. Fece la valigia, prese il coraggio e aprì la porta. Giovanni uscì di testa, urlava, batteva i piedi, la malediva.
Se vai non sei più mia figlia! gridava. E questa casa non è più la tua! Non ti farò più entrare!
Quando lei scomparve tra la pioggia senza voltarsi, lui prese laccetta e la piantò di colpo nello scalino del portico. Le schegge volarono come sangue.
Non ho più una figlia! sussurrò nel vuoto. Per me è morta!
Passarono dodici anni. Uneternità, una vita intera. Gli inverni si alternavano alle primavere, i ragazzi del paese crescevano, alcuni partivano per la leva militare, altri si sposavano; cerano già nipoti che correvano nei cortili. Ma la casa di Giovanni ormai sembrava un monumento al dolore. Il suo meleto era inselvatichito, ingombro di rovi, i rami intrecciati come dita in preghiera. La vernice delle persiane scrostata, il portico storto, e quellaccetta, ormai marcita dentro il legno, aveva lasciato una cicatrice di ruggine.
Poi, lo scorso novembre, il freddo arrivò presto e fu duro. Ancora niente neve, la terra nuda, nera, gelata come marmo, il termometro già a meno venticinque. Tornando da una visita medica, notai che dal camino di Giovanni non usciva fumo. A quellora, col gelo, era davvero un brutto segnale.
Mi si strinse il cuore. Spalancai il cancello: era aperto. Ulisse, il vecchio cane, neanche uscì dalla cuccia scodinzolò appena e si mise a guaire piano.
Entrai: dentro era più freddo che fuori, un gelo da tomba. Lacqua nel secchio ghiacciata spesso. Un odore pesante: corpo non lavato, medicine stantie e rassegnazione.
Giovanni era steso a letto, tremava sotto il pastrano, il letto che ballava da quanto spasmiava, i denti a battere come un tamburo.
Giovanni! urlai. Che stai facendo?!
Lui aprì gli occhi, torbidi, rossi, infiammati. Non mi riconosceva.
Tonina sussurrava, chiamando la moglie. Tonina, fa freddo Dovè Annetta? Perché non canta più? Dille che canti Alla luna
Sta delirando, pensai. Polmonite. Si consuma.
Quella notte rimasi con lui. Accesi la stufa, portai un po di calore, anche se il fumo allinizio bruciava gli occhi. Gli feci una flebo. Giovanni si agitava in sogno, schiacciava il cuscino, chiamava la figlia nel delirio:
Annetta, torna non andare nel bosco, ci sono i lupi Non ti lascio Perdonami Ti ho voluto bene
Io ero lì seduta, lavoravo a maglia e ascoltavo il suo delirio, piangendo piano. Quanta tenerezza non spesa in quelluomo indurito, e quanto dolore si era procurato con quellamore che era diventato una prigione.
Arrivò lalba e il peggio era passato. Sudava come se avesse versato sette sudari, la febbre scesa.
Quando riaprì gli occhi, li aveva lucidi, ma stanchi, tristi come quelli di un cane randagio.
Valeria sussurrò, appena udibile. Io lho sempre aspettata. Ogni giorno, aspettavo. La mattina guardavo alla finestra. Alla sera stavo a sentire se si apriva il cancello.
Lo so, gli dissi, rimboccandogli la coperta. E lei scriveva. Me lo diceva la postina Vera.
Scriveva? si sollevò sul cuscino, occhi sbarrati. Dove sono le lettere?! Il postino non me ne ha mai portata una pensavo che mi avesse dimenticato, che mi avesse cancellato!
Le ha tenute Vera. Non le ha buttate. Ha preso il peccato, ma le ha conservate.
Allalba corsi allufficio postale. Vera, ancora assonnata, mi diede una scatola piena di lettere. Gliela portai a casa.
Come le leggeva quelle mani grandi e ruvide tremavano, lacrime che cadevano sulla carta, sciogliendo linchiostro. Baciava le fotografie dei nipoti, le stringeva al petto, ne sfiorava i volti con le dita screpolate.
Due nipoti, Valeria Ho due
In una delle lettere trovammo un pezzetto di numero di telefono. Era strappata e poi riattaccata, ma mancavano le ultime quattro cifre.
Che guaio, dissi. Lindirizzo cè, ma è Firenze, una città grande. Scrivere ci metterebbe troppo tempo, a ricevere risposta Tu ti consumi.
Vado io! si accese Giovanni, buttando le coperte. Vado anche strisciando! La trovo io!
Calmati, eroe! lo rimisi a letto. Dove vuoi andare che ti reggi a malapena? Cè un modo più veloce. Siamo nel ventunesimo secolo.
Andai da Paolo, il figlio della vicina. Lui è bravo coi computer, lavora a Siena e nei fine settimana torna dalla madre a sistemare le faccende.
Gli spiegai la situazione: Cerca tu su Internet, dai. Paolo abbassò gli occhiali, raddrizzò il maglione:
Zia Vale, non è una cosa semplice. Ma ci proviamo. Facebook, Instagram Qual è il cognome del marito? Ferri? Ecco
La trovarono! Una foto, stato: Mi manca casa. Paolo inviò: Annetta, sono Paolo di Rocca Azzurra. Tuo padre sta male, ti cerca. È urgente. Rispondi!
Aspettammo. Unora, due. Internet in paese è una presa in giro, il modem lampeggia, gracchia, si blocca. Il vento fuori ulula, la connessione salta.
Giovanni era lì accanto, bianco come la cera, beveva Corvalolo come acqua. Laria pesava.
Non risponderà mormorava fissando il vuoto. Non perdona Io non avrei perdonato. Lho maledetta.
Poi pling! uno squillo elettronico, improvviso.
Ha risposto! esultò Paolo. Ha scritto il numero del marito.
Chiamiamo. Gli squilli sono lunghi, lenti, sembrano non finire mai. Il cuore in gola.
Risponde un uomo, voce burbera.
Pronto? Chi è?
Giovanni balbetta, rimane senza fiato. Gli do una gomitata.
Sono Giovanni balbetta. Il padre di Annetta
Silenzio. Un silenzio denso, pesante. Dallaltra parte si sente solo respirare. Poi una risposta, secca:
Il padre, eh? Vi ricordate? Sono passati dieci anni.
Paolo, passami il telefono! La voce di una donna, ansiosa.
Pronto? La voce di Annetta, tesa, fredda.
Annetta gracchiò Giovanni. Figlia mia sei viva
Ancora silenzio. Dieci secondi che sembrano eterni. Solo un fruscio.
Perché chiamate? chiede lei piano. La voce trema, ma è ferma. Cosa volete?
Sto morendo, figlia, dice Giovanni con onestà. Ho sbagliato con te. Sbagliato su tutto. Volevo sentire la tua voce unultima volta. Perdonami, se puoi.
Lei piangeva. Non a dirotto, ma con quella pena trattenuta che strappa lanima.
Non so, papà sussurrava tra le lacrime. Ho aspettato tanti anni. Ho scritto lettere che non hanno mai avuto risposta. Non so se posso perdonare
Non chiedo subito, mormora lui. Volevo solo che sapessi Ti ho voluto bene. Come potevo. Sono stato uno sciocco.
Verremo, disse lei a un tratto, decisa ma fredda. Non posso lasciarti morire da solo. Verremo. Aspettaci.
Giovanni riattaccò. Non aveva in volto la felicità, ma un senso di sollievo misto a paura.
Verrà, dice. Per dovere, verrà. Ma perdonare? Solo Dio lo sa.
Vale! esclama. Ma dove li faccio venire? In questa porcilaia? Ragnatele sugli angoli, piatti rotti! Che vergogna davanti al genero, ai nipoti!
Tranquillo! metto ordine con tono deciso. Ce la facciamo!
Mobilitai la contrada, facemmo luccicare la casa dallalto in basso. Giovanni girava spaesato: Non mi riconoscerà, mi guarderà e mi caccerà.
Arrivò il giorno. Si fermò una Fiat Panda davanti allingresso. Scese Annetta. Elegante, una signora di città, bellissima e austera. I nipoti e il marito anche. Giovanni li aspettava sulla soglia, la cappelliera in mano che non finiva di stropicciare.
Annetta si fermò davanti al cancello. Lo fissava, guardava la casa, lo scalino del portico, là dove era rimasta la cicatrice dellaccetta. Lottava con se stessa, si capiva. Vecchi dolori, vecchie rabbie che ribollivano.
Giovanni scese i gradini, gli si avvicinò goffamente.
Ciao, Annetta.
Lei era ferma, lo guardava negli occhi.
Ciao, papà, sussurrò.
Poi si avvicinò e lo abbracciò. Piano, come se abbracciasse uno sconosciuto. Lui restò immobile, senza fiato, poi la strinse forte, affondando il volto nel cappotto di lei e tremava senza rumore.
Lei teneva le braccia abbassate: le lacrime le sgorgavano sulle guance. Niente gioia urlata, solo un grande dolore per tutto quel tempo perso.
Entrarono in casa. Laria era tesa, si sarebbe potuta tagliare con il coltello. I nipoti timidi, si stringevano al padre. Il marito, Sergio, squadra Giovanni con occhio severo.
Si sedettero a tavola. Silenzio. Solo il rumore dei cucchiai.
Giovanni non regge, versa un po di grappa, si alza in piedi. La mano trema, versa un po fuori.
Grazie di essere venuti, mormora, fissandosi le scarpe. Non ci speravo anzi, sì, ma non ci credevo. Sergio, Annetta Io ho maledetto la mia vita senza di voi.
Il genero lo scruta, poi guarda Annetta che dondola. Un sospiro, prende il bicchiere.
Va bene, Giovanni Luigi dice a voce piena Non ha senso parlare del passato. Siamo qui perché Annetta stava male senza tornare. È buona vostra figlia. Troppo buona. Brindiamo allincontro.
E allora il piccolo Paolo, il nipote, chiede di colpo:
Nonno, perché non cè più laccetta nello scalino? La mamma diceva che lavevi piantata lì
Annetta si gira, pallida:
Paolo! Mangia!
Nonno sorride amareggiato:
È marcita, nipote. E con lei la mia rabbia. Resta solo la cicatrice. Domani ti porto a vedere il bosco vero. Vivo.
Il gelo scioglieva piano. Tre giorni vissero, imparando a conoscersi dal principio. Giovanni tentava di compiacere, ma parlava poco, temendo di sbagliare.
La terza sera, Annetta venne da me in ambulatorio. Gli occhi rossi, stanchi.
Zia Vale, dice, datemi qualcosa per il cuore. Non ce la faccio più.
Le preparai un tè alla menta.
Allora, non ti lascia andare il rancore?
Non mi lascia, confessò stringendo la tazza. Lo guardo: anziano, malinconico, si dà da fare Mi fa una pena tremenda. Ma quando penso a quella sera di pioggia, e a come gridava Ti maledico! mi si stringe tutto dentro. Sai, zia Vale, venendo qui pensavo: gli dirò tutto! Tutto quello che ho sofferto, come ho pianto quandè nata Varenza e non cera nessuno a festeggiare
E allora? domando. Hai detto tutto?
Non ce lho fatta, sospira. Ho visto la sua schiena, quelle mani che tremano si è punito da solo più di quanto avrei potuto io. Ha vissuto per dodici anni nella prigione che si è costruito. Perché infierire ancora?
Questa è saggezza, Annette, le dico. Perdonare non vuol dire dimenticare. Significa avere compassione. Capire che non ha fatto per cattiveria, ma per stoltezza e paura. Ti ha voluto bene, con un amore malato, ma ti ha voluto bene.
Annetta rimase in silenzio, finì il tè.
Stamattina ha scaldato gli stivaletti a Varenza sulla stufa. Li ha tastati dentro con la mano, per vedere se erano caldi, proprio come faceva con me da bambina. Lho visto e quella stretta dentro si è alleggerita. Di poco, ma si è sciolta. Proveremo a vivere, zia Vale. Per i figli. Poi, magari, anche la ferita guarirà.
Partirono dopo una settimana ma promisero di tornare in estate. E tornarono.
Destate Giovanni era cambiato. Più uomo che vecchio, di nuovo padrone di casa. Aveva sistemato il meleto, e avvenne il miracolo: i vecchi meli, che sembravano secchi, fiorirono di nuovo. Un manto bianco copriva il giardino.
Passando di lì, li vidi seduti sul portico: Giovanni e Annetta, fianco a fianco. Non parlavano, solo guardavano il tramonto. Varenza correva nellorto, intrecciando una ghirlanda.
Giovanni mi vide, mi salutò con la mano, sereno. Annetta mi sorrise: in quel sorriso cera malinconia ma nessuna rabbia.
Vale! grida il nonno. Vieni per il tè con la marmellata di mele! Lha fatta Annetta è trasparente come lambra!
Entrai. Bevevamo tè in veranda e la casa profumava di mele renette, destate e di pace.
Si dice che si possa incollare una tazza rotta. La crepa resta, certo. Ma il tè, in quella tazza, è ancora più buono: la si custodisce più di una nuova.
La vita è breve, come un giorno dinverno. In un battito fa buio, è notte. Pensiamo sempre: Farò in tempo, poi lo perdono, poi telefono, poi vado a trovarli. Ma quel poi potrebbe non arrivare mai. La casa può gelarsi, il telefono tacere per sempre, e la cassetta della posta restare vuotaQuando lestate finì, la prima neve cadde lieve una notte di ottobre. Nessuno la aspettava così presto: si posarono fiocchi silenziosi sulle persiane azzurre, sulle mele ancora appese, sulle impronte fresche di Varenza e Paolo che avevano saltato nel prato fino al crepuscolo.
Quella mattina, Giovanni uscì presto col cesto sotto il braccio, come un tempo, e vide che le mele rosse, mature, stavano scivolando appena tra i rami carichi, ognuna incappucciata da un berretto di neve. Si fermò: il respiro fumava nellaria fredda, il cuore gli batteva ancora, lento ma tenace.
Dietro di lui, Annetta uscì in silenzio, avvolta nello scialle di lana della madre. Si fermò accanto, posò la mano sulla spalla larga di suo padre. Per un attimo restarono così, a guardare il giardino: il tempo passato, quello perduto e quello ancora da vivere si stavano mescolando in quellalba lieve.
Allora, papà raccogliamo?
Giovanni non rispose subito. Poi si chinò, raccolse una mela, la porse ad Annetta. Lei la fissò, ancora tiepida di sole sotto la buccia gelida. Ne addentò un morso: era dolce, fredda, perfetta. Sorrise a suo padre, e lui sentì come qualcosa gli si scioglieva piano nel petto, come una diga che finalmente lascia andare lacqua.
Lo vedi? disse piano. Anche sotto la neve, le mele sanno di casa.
E in quel momento breve come un lampo, eterno come un ricordo ognuno sentì di essere tornato davvero a casa, dove il perdono non cancella il passato, ma lo rende più forte e dolce, come una mela matura raccolta fra la neve.