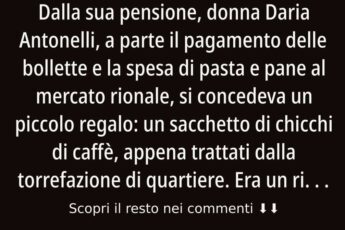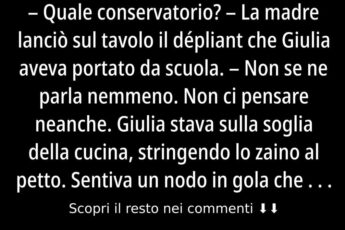Dopo il funerale di Giovanni, il mio unico figlio, Andrea, mi caricò sulla sua auto e mi portò su una stradina di campagna, fermandosi tra gli olivi e sussurrandomi: «Qui è il tuo posto».
Non piansi al funerale. Non fu per mancanza damore; noi avevamo condiviso quarantadue anni, attraversato povertà, malattie e le poche gioie che la vita ci concedeva. Le lacrime rimanevano intrappolate in un nodo profondo, come pietre nella gola. Non sgorgarono né accanto alla tomba né poi, quando la vicina, la signora Rosa, venne a portare la cialda e mi disse: «Forza, Signora Valentina, tieniti forte». Annuii, sorrisi cortesemente e chiusi la porta.
Andrea, alto e elegante, con un completo nero che doveva costare più della mia pensione semestrale, mi teneva per il gomito come si fa nelle famiglie rispettabili. La sua mano, però, era gelida, non per il freddo esterno, ma per una freddezza di dovere, come se mi stringesse una catena.
Al memoriale, il ragazzo pronunciava discorsi lunghi e pomposi, con pause teatrali e gesti ampi. Tutti lo acclamavano: «Che figlio! Che bel ragazzo! Che intelligenza!». Io rimanevo in un angolo, osservandolo. Il suo volto era familiare e al contempo estraneo: gli occhi miei, il naso da padre, un sorriso che non più apparteneva a noi.
Il terzo giorno dopo il funerale, Andrea entrò in cucina mentre io preparavo il caffè forte che Giovanni amava, con latte ma senza zucchero, abitudine rimasta. Si sedette al tavolo, mi porse le chiavi dellauto e il passaporto.
«Mamma», iniziò, «ho riflettuto. Sarebbe meglio per te andare in una casa di riposo in montagna, in un posto tranquillo dove laria è più pulita e i compagni sono tutti pensionati. Non dovrai più stare da sola nellappartamento. Sai bene quanto era debole papà quando si ammalò».
Non terminò la frase, ma io colsi il suo pensiero: «Che tu possa morire», o più precisamente, «Che la tua fine sia veloce, così non sarai più un peso».
Rimasi in silenzio, sorseggiando il caffè che bruciava le labbra, ma lo facevo per non tremare, per non urlare, per non scagliargli la tazza.
«Lappartamento era mio, ora è tuo», continuò, «Papà aveva già trasferito tutto a me lanno prima, senza chiedermi nulla. Lho fatto per proteggerti, per non creare litigi». Soffermandomi, ricordai che Giovanni aveva scritto tutto a nome di Andrea un anno prima della sua morte, senza chiedermi il permesso. Pensai, ingenuamente: «Va bene, finché mio figlio è qui a prendersi cura di me».
«Capisci, mamma», proseguì, «che qui non hai spazio. Non potrai farcela da sola, sei stanca, sei vecchia». Lultima parola la pronunciò con una dolcezza quasi compassionevole, come se diagnosticasse una malattia.
«Quando?», chiesi, senza lacrime, senza urla, solo curiosità.
«Domani, al mattino», rispose. «Ti porto tutto, non devi nemmeno fare le valigie, cè già tutto pronto. Ti porterò a fare visita, lo giuro».
Mentì; lo sapevo, perché non avrei più sentito la sua voce.
Al mattino, arrivò con la sua Alfa Romeo. Presi il mio bagaglio: una foto di Giovanni, il passaporto, qualche euro risparmiati di nascosto per anni, e il ricettario con le ricette più amate, quelle che Giovanni sgranocchiava con piacere.
Andrea caricò la valigia nella stiva come se fosse un sacco di patate, aprì la portiera e mi fece sedere sul sedile posteriore senza nemmeno salutare. Partì subito.
Il viaggio fu in silenzio. La città di Milano rimase alle spalle, poi la periferia, poi la campagna. La strada divenne sterrata, piena di buche. Guardavo fuori: alberi, silenzio, uccelli, bellezza e un tremore dentro di me.
«Andrea, dove è questo rifugio?», chiesi.
Non rispose subito, poi, lanciò con spavalderia: «Lo vedrai presto».
Dopo venti minuti girò su una stretta via di montagna; lauto saltellava sui sassi. Mi aggrappai al bracciolo, il cuore batteva forte, non per il sobbalzo, ma per il presentimento.
Il veicolo si fermò. Scese, aprì la portiera. Uscii in un luogo desolato: nessuna casa, nessun recinto, solo una foresta fitta e silenziosa.
«Il tuo posto», disse con voce calma, quasi soddisfatta.
Gli occhi mi scrutarono, il suo volto era sereno, persino compiaciuto.
«Che cosa intendi per posto?», chiesi.
«Così è», replicò. «Capirai da sola. Qui sarà più tranquillo, nessuno ti disturberà».
Posò accanto a me una borsa con provviste per due giorni, dicendo: «Sei una donna astuta, troverai il resto».
Rimasi immobile, il pensiero di un silenzio assoluto mi avvolse.
«Mi lasci qui?», chiesi, quasi a me stessa.
«Non ti lascio, ti lascio andare», rispose, «Presto te ne andrai da sola. Lappartamento, la città, tutto è un peso per me. Non vuoi più una presenza che ti ricordi cosa dovrei provare».
Disse tutto con la leggerezza di chi elenca la spesa.
«Andrea», sussurrai, «Io sono tua madre».
«Era», corresse, «Ora sei solo un peso. Scusa».
Salì di nuovo in auto, accese il motore. Io corsi verso la porta, afferrai il maniglione.
«Andrea! Aspetta! Ti ridarò tutto! Lappartamento, i soldi, tutto! Non lasciarmi qui!».
Premette lacceleratore; la macchina scattò in avanti, io caddi, colpendo il ginocchio su una pietra. Il dolore era più dentro, non nella carne.
Aprii la borsa, trovai una bottiglia dacqua e dei panini, anche una barretta di cioccolato, forse per darmi un ultimo respiro di dignità. Mangiai il cioccolato, bevvi lacqua, mi rialzai e guardai intorno.
Era solo foresta, nessuna traccia di sentiero, solo tracce di animali. Il silenzio era talmente denso da rimbombare nelle orecchie.
Camminai senza meta, forse verso una strada, forse verso un fiume, forse verso la fine. Dopo unora trovai un ruscello cristallino, mi dissetai con le mani, mi lavai il viso, osservai il riflesso: capelli bianchi, rughe profonde, occhi vuoti, come se dentro non ci fosse più niente.
«Sei vecchia», disse una voce, era la sua.
Sì, vecchia, ma non morta.
Passai la notte sotto un pino, avvolta in un vecchio cappotto, tremando non per il freddo ma per la rabbia, per il tradimento. Pensai al marito, al suo sorriso, al tè alla menta che mi preparava quando ero malata, alle sue parole: «Sei la mia roccia». Ora mi sentivo un oggetto scartato, spazzatura.
Non volevo morire lì, né così.
Il mattino seguente proseguii, camminai unintera giornata senza scopo, solo per non restare ferma.
Al terzo giorno, trovai una strada di ghiaia. Qualcuno doveva usarla. Camminai su di essa.
Dopo unora, si fermò un camion. Il conducente, un uomo di cinquantanni dal volto gentile, mi chiese: «Signora, dove sta andando?».
Non sapevo cosa rispondere; balbettai: «Verso la città, verso mio figlio».
Lui annuì, aprì la porta del camion:
«Salti, la porto».
Mi sedetti, silenziosa, mentre il camion si allontanava. Accese la radio, una vecchia canzone di Lucio Dalla riempì labitacolo. Chiusi gli occhi, le lacrime finalmente fluivano.
Fermarono alla stazione degli autobus.
«Ecco, signora», disse, porgendomi una bottiglia dacqua e un panino. «Non si preoccupi, tutto si sistemerà».
Ringraziai, scesi.
Nella città mi recai alla stazione di polizia, raccontai tutto senza drammi, senza pianti, solo i fatti. Lufficiale ascoltò, scrisse, scrollò le spalle.
«Capisce che senza prove non possiamo fare nulla? Non è stato un omicidio, né una minaccia, è stato un abbandono. Lei è sopravvissuta, è una buona notizia, ma per legge non è un reato».
Guardai le sue divise, i suoi occhi indifferenti.
«Quindi potrebbe farlo di nuovo, con qualcun altro, senza conseguenze?».
«Senza prove, sì», rispose. «Le consiglierei un avvocato o i servizi sociali, forse aiuti per un alloggio».
Uscendo, iniziò a piovere leggermente. La gente correva indaffarata, nessuno si voltò verso una vecchia con una borsa.
Andai in biblioteca, dove cera internet gratuito. Cercai, lessi, scrissi lettere al tribunale, alla commissione per i diritti umani, ai giornalisti.
Una settimana dopo ricevetti una chiamata da una giovane giornalista del «Corriere della Sera». I suoi occhi brillavano di curiosità.
«Signora Valentina, raccontaci tutto. Il pubblico deve sapere».
Raccontai i fatti, senza abbellimenti.
Tre giorni dopo larticolo uscì con il titolo: «Figlio abbandona madre in montagna: Il suo posto è qui».
La mia foto ai funerali, vestita di grigio, occhi vuoti, ricevette centinaia di commenti, migliaia di condivisioni, gente che piangeva, chiedeva giustizia.
Il giorno seguente, il telefono squillò: era Andrea.
«Mamma, che cosa hai combinato?!».
«Vivo», risposi.
«Mi uccidi! Mi hanno licenziato! Mia moglie è andata via! I figli hanno vergogna a venire a scuola! Capisci quello che hai provocato?!».
«Capisco», dissi. «Hai lasciato una madre in una foresta. Ho detto al mondo la verità. È giusto».
«Verrò, prenderò tutto indietro: lappartamento, i soldi, tutto!»
«Troppo tardi», gli dissi. «Non voglio più il tuo appartamento. Voglio che capisca che una madre non è spazzatura, che letà non è una condanna, che un uomo non è un oggetto».
Rimase in silenzio, poi un pianto vero, il primo della sua vita.
«Scusa», sussurrò. «Perdonami».
«Ti perdono», risposi. «Quando tornerai, portami solo fiori, non soldi, non immobili. Dì: Mamma, ti voglio bene e ti crederò, se è sincero».
Una settimana dopo arrivò con un mazzo di tulipani gialli, i miei preferiti. Cadde in ginocchio, piangeva, baciava le mie mani.
Lo guardai, le sue lacrime, la sua paura, il suo rimorso.
«Alzati», dissi. «Io non sono un dio, sono tua madre, e ti perdono».
Ora vivo non in una casa di riposo, non più in un appartamento di città. Affitto una piccola stanza sul mare, con balcone, gabbiani, sole.
Andrea mi visita ogni settimana, porta cibo, fiori, racconta dei figli, del lavoro, della vita. È cambiato, o forse finge. Lo osservo, nei suoi occhi vedo ancora la paura di perdermi di nuovo, la paura di restare senza perdono.
Non ho ricominciato a vivere sotto lo stesso tetto, ma non lho respinto, perché credo che tutti meritino una possibilità di redenzione, anche un figlio che ha gettato sua madre nella foresta.
Di sera, sul balcone, guardo il mare, penso a Giovanni, a come sarebbe stato fiero di me, non per la sopravvivenza, ma per non essermi indurita, per non essermi spezzata, per non essere diventata la donna sottomessa che lui temeva.
Sono viva, sono forte, sono madre.
Il mio posto non è nella foresta, né in una casa di riposo, ma dove decido io.
Oggi sono al mare; domani forse sulle colline, forse in un nuovo appartamento con i nipoti, con i tulipani sul davanzale.
Perché non sono un peso, non una «vecchia». Sono una persona, con diritto alla vita, allamore, al rispetto.
Anche se mi hanno gettato nella foresta. Anche se mi hanno detto: «Il tuo posto è qui».
Ho scelto un altro posto.
E questo è il mio diritto.