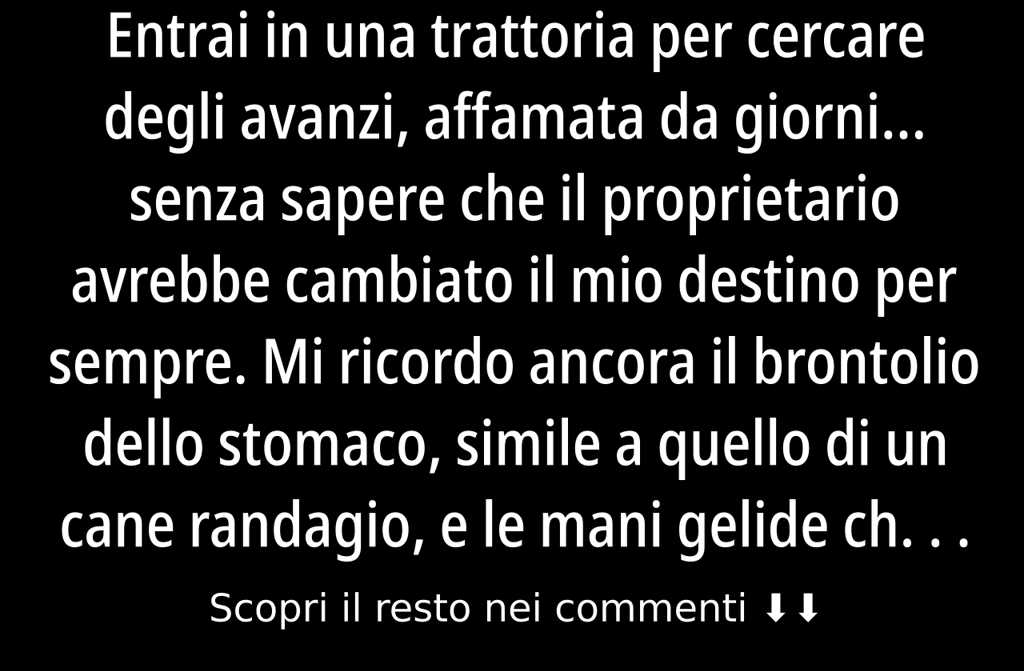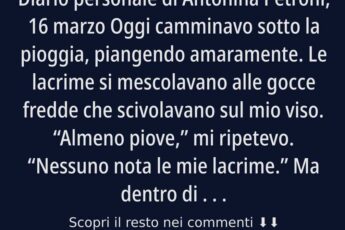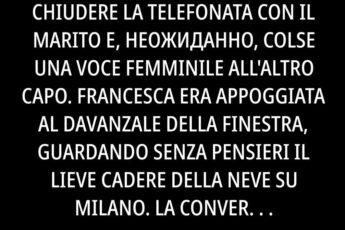Entrai in una trattoria per cercare degli avanzi, affamata da giorni senza sapere che il proprietario avrebbe cambiato il mio destino per sempre.
Mi ricordo ancora il brontolio dello stomaco, simile a quello di un cane randagio, e le mani gelide che non riuscivo più a sentire. Passeggiavo sui marciapiedi di Firenze, guardando le vetrine calde e illuminate dei ristoranti, mentre il profumo del pane appena sfornato e dei sughi densi mi faceva quasi più male del freddo. Non avevo neanche una lira in tasca.
La città era avvolta da un gelo tagliente, di quelli che non si cancellano con una sciarpa o le mani ficcate nelle tasche. Era quel freddo che si infila nelle ossa e ti ricorda quanto sei sola, senza tetto, senza cibo, senza nessuno.
Non era la fame di chi salta una merenda, ma quella che si insinua per giorni. Quella che fa suonare lo stomaco come un tamburo e ti fa girare la testa solo a chinarti. Fame vera, di quella che fa male.
Ero a digiuno da più di due giorni. Solo un po’ d’acqua presa a una fontanella pubblica e un boccone di pane secco che una vecchia signora mi aveva lasciato per strada. I miei stivali erano bucati, i vestiti infangati, e i capelli intrecciati come se li avesse pettinati il vento.
Camminavo lungo via Tornabuoni, tra ristoranti eleganti. Luci calde, musica appena sussurrata, risate di famiglie tutto mi sembrava un altro mondo. Dietro le vetrate, genitori brindavano, bambini giocavano con le forchette, le coppie ridevano senza pensieri.
E io io morivo per una fetta di pane.
Dopo aver perso tempo a fissare zone proibite, presi coraggio ed entrai in una trattoria che profumava di stufato e burro fuso. Le tavole erano tutte occupate, ma nessuno mi fece caso. Scorsi un tavolo appena lasciato libero, ancora con qualche avanzo, e il cuore mi fece un balzo.
Mi avvicinai piano, sperando di passare inosservata. Mi sedetti fingendo di essere una cliente qualsiasi, come se avessi diritto anchio a quel calore. Presi un pezzo di pane duro dal cestino e lo portai alla bocca. Era freddo e vecchio, ma per me era meglio di qualsiasi altra cosa.
Misi in bocca qualche patata ormai gelida, con le mani tremanti, cercando di non piangere. Poi, con cautela, addentai un piccolo avanzo di arrosto. Lo gustai lentamente, come se fosse lultimo boccone sulla terra. Ma proprio mentre mi stavo rilassando, una voce profonda mi riscosse:
Ehi, non si può fare.
Mi paralizzai. Abbassai lo sguardo, con la vergogna che mi bruciava le guance.
Era un uomo alto, elegante, il vestito scuro ben stirato, le scarpe che luccicavano come specchi. La cravatta posata alla perfezione sopra la camicia candida. Non sembrava né cameriere né cliente.
Mi mi scusi, signore balbettai a fatica . Avevo solo fame
Provai a infilare ancora qualche pezzo di patata in tasca, in un impeto di vergogna infantile. Lui non disse nulla, ma mi guardava, indecifrabile.
Vieni con me disse, infine, calmo.
Mi ritrassi distinto.
Non voglio rubare niente supplicai . Lasci che finisca e me ne vado, glielo giuro. Non farò confusione.
Mi sentivo insignificante, trasparente, fuori posto come unombra.
Ma invece di cacciarmi, lui sollevò una mano, fece un cenno a un cameriere, poi si sedette a un tavolo in fondo.
Restai ferma, incapace di capire. Dopo poco, il cameriere arrivò e davanti a me pose un piatto fumante: risotto morbido, arrosto succoso, verdure al vapore, una fetta di pane caldo e un grande bicchiere di latte.
È per me? chiesi a voce bassissima.
Sì, certo mi sorrise il cameriere.
Alzai lo sguardo e vidi luomo osservarmi dalla sua tavola. Nessun sarcasmo nella sua espressione, solo una strana serenità.
Mi avvicinai a lui, con le ginocchia molli.
Perché mi ha dato da mangiare? sussurrai.
Si tolse la giacca e la posò sulla sedia, come a liberarsi da una corazza invisibile.
Nessuno dovrebbe cercare tra gli avanzi per sopravvivere disse serio . Mangia in pace. Sono io il proprietario di questo posto. E da oggi, qui troverai sempre un piatto che ti aspetta.
Restai zitta, con le lacrime che pungevano gli occhi. Piangevo, sì, ma non solo per la fame. Per la vergogna, la stanchezza, quellumiliazione di sentirsi meno di niente, e per il sollievo di essere finalmente vista.
Tornai anche il giorno dopo.
E poi quello dopo ancora.
Ogni volta, il cameriere mi accoglieva con un sorriso, come se fossi una vera cliente. Mi sedevo sempre allo stesso tavolo, mangiavo in silenzio, sistemavo con cura i tovaglioli quando finivo.
Una sera, tornò il signore elegante. Mi invitò a sedermi con lui. Esitai allinizio, ma qualcosa nel suo tono mi fece sentire sicura.
Hai un nome? mi chiese.
Giulia risposi con un filo di voce.
E quanti anni hai?
Diciassette.
Annuii piano. Non chiese altro.
Dopo un po, aggiunse:
Hai fame, sì. Ma non solo di cibo.
Lo fissai perplessa.
Hai fame di rispetto. Di essere guardata negli occhi. Di qualcuno che chieda come stai invece di evitarti come fossi spazzatura.
Non sapevo dare risposta. Ma aveva ragione.
E la famiglia?
La mamma è morta per una malattia. Il babbo se nè andato con unaltra e non è più tornato. Mi hanno buttato fuori da dove vivevo. Ero sola, senza nessuno.
E la scuola?
Ho lasciato la seconda media. Mi vergognavo di andare sporca. Le maestre mi trattavano come un caso perso. I compagni ridevano di me.
Lui annuì di nuovo.
Non hai bisogno di compassione. Hai bisogno di possibilità.
Prese un biglietto da visita dalla giacca e me lo porse.
Vai domani a questo indirizzo. È un centro per giovani come te. Ti aiutiamo con pasti caldi, vestiti, scuola, e soprattutto, strumenti per ripartire. Voglio che tu ci provi.
Perché fa tutto questo? chiesi piangendo.
Perché anche io, quando ero bambino, ho mangiato tra gli avanzi. E qualcuno mi ha teso la mano. Ora tocca a me.
Passarono gli anni. Andai in quel centro come mi aveva detto. Imparai a cucinare, a leggere bene, a usare il computer. Mi diedero un letto pulito, lezioni per avere fiducia in me stessa, e uno psicologo che mi insegnò che non valevo meno degli altri.
Oggi ho ventitré anni.
Gestisco la cucina di quella stessa trattoria dove tutto è iniziato. Ho i capelli ordinati, la divisa stirata, le scarpe forti. Mi assicuro che non manchi mai un piatto a chi ne ha bisogno. Ogni tanto arrivano bambini, anziani, donne in attesa tutti assetati di pane e di uno sguardo che li riconosca.
E a loro, ogni volta, servo il pasto con un sorriso e dico:
Mangia tranquillo. Qui non si giudica. Qui si nutre.
Il signore elegante passa ancora di tanto in tanto. Ora si permette una cravatta meno stretta. Mi saluta con un cenno del capo e, a volte, ci concediamo un caffè insieme a fine turno.
Sapevo che saresti arrivata lontano mi ha detto una sera.
Lei mi ha aiutata a cominciare gli ho risposto , ma il resto lho fatto con la fame.
È scoppiato a ridere.
La gente non capisce il potere della fame. Non solo distrugge. Sa anche spingerti lontano.
E io lo so bene.
Perché la mia storia è nata tra gli avanzi. Ma ora ora cucino speranza.