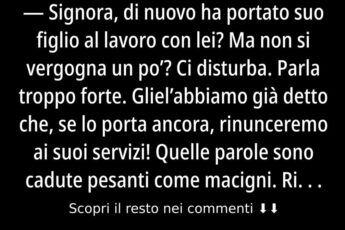Aspettai un lampo di luce su un binario ghiacciato, a mezzanotte, quando un debolissimo gemito spezzò il silenzio della stazione di Bologna. Il vento di febbraio mi sferzava il volto, portando con sé un pianto flebile, quasi soffocato dal frastuono della tempesta.
Mi fermai di colpo, a metà del tragitto verso la piattaforma, e mi girai verso il piccolo capanno di guardia dei binari, quasi sepolto dalla neve. Ai lati dei binari cera un ciuffo scuro, avvolto in una coperta logora.
Con passo cauteloso mi avvicinai. Sotto quella coperta sporca si intravedeva una piccola sagoma, un manino con le mani rosse per il freddo.
«Madonna santa», sussurrai, il cuore che batteva allimpazzata.
Caddi in ginocchio e la sollevai. Era una neonata, non più di un anno, forse anche meno. Le labbra erano di un azzurro pallido, il pianto flebile come se non avesse ancora la forza di temere.
La strinsi al petto, aprii il mio cappotto per proteggerla dal gelo e corsi, senza fiatare, verso il villaggio. Giulia Bianchi, la nostra unica infermiera, era lunica speranza.
«Marco, che diavolo?», esclamò Giulia, vedendo il fasciolo fra le braccia.
«Lho trovata sul binario. Era quasi congelata».
Giulia la prese delicatamente, la controllò. «È ipotermica ma è viva. Grazie a Dio».
«Dobbiamo chiamare la polizia», aggiunse, afferrando il telefono.
Io la trattenni. «Loro la manderebbero in un orfanotrofio, non sopravviverà al viaggio».
Dopo un attimo di esitazione, Giulia aprì un armadio. «Ho ancora della pappa per neonati dalla visita alla nipote. Ci basterà per ora. Ma Marco, cosa farai?».
Guardai il volto di quella piccola, il respiro caldo contro la mia pelle. Il pianto era cessato.
«La crescerò», dissi a bassa voce. «Non ho altra scelta».
Il villaggio iniziò subito a mormorare.
«Ha trentacinque anni, è single, vive da sola e ora raccoglie bambini abbandonati?».
Le chiacchiere non mi interessavano mai. Con laiuto di qualche amico al Comune sistemai i documenti. Non cerano parenti, nessuno aveva denunciato un bambino scomparso.
La chiamai Ginevra.
Il primo anno fu il più duro: notti insonni, febbri, denti che spuntavano. La cullai, la consolai, cantai le ninnananne che avevo imparato da bambino.
«Mamma!», esclamò a dieci mesi, allungando le braccia verso di me.
Le lacrime scivolarono sulle mie guance. Dopo anni di solitudine, in quella casa piccola ero diventata madre.
A due anni era un turbine. Inseguiva il gatto, strappava le tende, voleva sapere tutto. A tre riconosceva ogni lettera dei suoi libri illustrati. A quattro raccontava storie intere.
«È prodigiosa», disse la vicina Maria, scuotendo la testa. «Non so come tu faccia».
«Non sono io», risposi, sorridendo. «Lei deve semplicemente brillare».
A cinque organizzai passaggi in auto per portarla allasilo del paese vicino. Gli educatori rimasero senza parole.
«Legge meglio di molti bambini di sette anni», mi dissero.
Quando entrò alla scuola elementare, sfoggiava trecce castane con nastri abbinati, che intrecciavo ogni mattina con amore. Nessun incontro genitoriinsegnanti passava senza la mia presenza. I professori la elogiavano senza sosta.
«Signora Bergmann», disse una volta la maestra, «Ginevra è il tipo di alunna che sogniamo. Andrà lontano».
Il mio cuore si gonfiò di orgoglio.
Divenne una giovane donna aggraziata, snella, sicura di sé, con occhi azzurri come il mare di Sardegna, pieni di determinazione. Vinse concorsi di ortografia, olimpadi di matematica, esposizioni scientifiche regionali. Ogni abitante del villaggio conosceva il suo nome.
Una sera, al termine del decimo anno di scuola, mi guardò e disse: «Mamma, voglio diventare dottoressa».
Io rimasi senza parole. «È fantastico, tesoro. Ma come faremo a pagare luniversità? Laffitto a Firenze, il cibo?».
«Ho una borsa di studio», rispose, gli occhi che scintillavano. «Troverò un modo. Promesso».
E lo trovò.
Quando arrivò la lettera di ammissione alla Scuola di Medicina di Pisa, piansi per due giorni interi, una pioggia di lacrime di gioia e paura. Era la prima volta che mi lasciava.
«Non piangere, mamma», mi disse alla stazione, stringendo la mia mano. «Ti verrò a trovare ogni fine settimana».
E così fece, almeno per un po. La città la inghiottì: lezioni, laboratori, esami. Allinizio veniva una volta al mese, poi ogni due, tre settimane. Ma ogni sera mi chiamava, senza mai mancare.
«Mamma! Ho superato lanatomia alla grande!».
«Mamma! Oggi in clinica abbiamo fatto nascere un bambino!».
Io ascoltavo, sorridendo.
Nel terzo anno, la sua voce tremò di eccitazione.
«Ho conosciuto qualcuno», ammise timidamente.
Si chiamava Lorenzo, un collega di corso. Arrivò a Natale, alto, educato, occhi gentili, voce calma. Ringraziò per il pasto e pulì il tavolo senza che glielo chiedessimo.
«Buona presa», sussurrai a Ginevra mentre lavava i piatti.
«O forse no?», ridacchiò, E continuo a prendere 30 e lode.
Dopo la laurea iniziò la specializzazione in pediatria.
«Mi hai salvata una volta», disse, «ora voglio salvare altri bambini».
Le sue visite diventavano più rare, ma capivo. Aveva una vita tutta sua. Conservavo ogni foto, ogni piccola storia di paziente.
Una giovedì sera il telefono squillò.
«Mamma posso venire domani?», la sua voce era bassa, nervosa. «Devo parlarti».
Il mio cuore accelerò. «Certo, tesoro. Va tutto bene?».
Il pomeriggio successivo arrivò senza sorriso, senza luce negli occhi.
«Che succede?», le chiesi, avvolgendola in un abbraccio.
Si sedette, le mani intrecciate. «Due persone sono venute in ospedale, un uomo e una donna. Hanno chiesto di me».
«Che cosa vuoi dire?».
«Dicono di essere mio zio e mia zia. Dicono che la mia cugina è scomparsa 25 anni fa».
Mi girò la testa, stordito. «E allora?».
«Hanno foto, test del DNA. È vero».
Il silenzio calò pesante.
«Ti hanno abbandonato», sussurrai. «Ti hanno lasciata nella neve».
«Dicono che non erano loro, che i miei genitori fuggirono da una violenza, che si persero alla stazione e che lhanno cercata per anni».
Il respiro si bloccò. «E i tuoi genitori?».
«Morti. Un incidente stradale dieci anni fa».
Non trovai parole.
Ginevra prese la mia mano. «Vogliono solo la verità. Non voglio più niente da loro».
Le stringei la mano più forte, e le dissi con voce rotta: «Qualunque dica il passato, tu sei e sarai sempre la mia figlia».