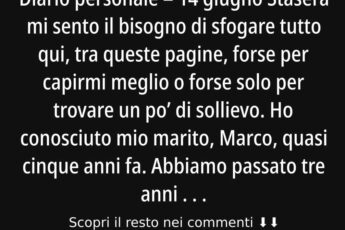Un anno fa avrei riso se mi avessero detto che avrei lasciato Antonio. Mio marito, con cui ho passato dodici anni, che adoravo. L’uomo di cui tutte le mie amiche dicevano: «Sei stata incredibilmente fortunata». Era davvero tutto per me. Affettuoso, affidabile, gentile, un padre premuroso. Vivevamo come in una favola. Ora invece abito con mia sorella nella periferia di Milano, con due bambini e la consapevolezza che è stata l’unica via di salvezza.
Quando ci siamo sposati, tutto era normale: siamo partiti dal nulla, comprando un bilocale, poi Antonio l’ha venduto e abbiamo preso un mutuo per un ampio trilocale. L’abbiamo ristrutturato, comprato i mobili, sistemandoci comodamente. Due figli, di nove e quattro anni. Io lavoravo alla scuola d’arte, tenevo corsi per bambini—non per soldi, ma per passione. Antonio portava a casa uno stipendio fisso, era l’anima della famiglia. Viaggiavamo, organizzavamo feste per i bambini, eravamo felici davvero.
Poi tutto è cambiato in un istante.
Una mattina mi hanno chiamato dal suo lavoro: Antonio è svenuto in ufficio. L’ambulanza, l’ospedale, gli esami… La diagnosi: un tumore al cervello benigno. Ma trascurato, cresciuto troppo, ormai avanzato. I medici non hanno potuto operarlo in modo semplice, hanno dovuto eseguire un intervento neurochirurgico complesso.
È sopravvissuto. I dottori dicevano che era fortunato. Ma il mio Antonio era sparito. Dopo l’operazione, era diventato un altro. Il volto deformato da una paralisi facciale, l’udito compromesso. Ma peggio ancora erano i cambiamenti dentro di lui. Tornato a casa, è cominciato l’inferno.
Si è licenziato. Senza motivo.
«Ho lavorato abbastanza,» ha detto. «Adesso ci pensi tu.»
Ho preso un altro lavoro, ero distrutta dalla fatica. E lui? Passava le giornate sul divano, a scrollare il telefono, guardare la tv. Nessun aiuto, nessun gesto. Solo critiche. E urla. Urla su urla.
Sfogava la rabbia su tutti: su di me, sui bambini. Persino sul piccolo di quattro anni. Ci accusava di averlo portato alla malattia. Diceva che eravamo noi ad averlo «rovinato», che per colpa nostra si era «spezzato».
Poi sono iniziate le stranezze. Guardava per ore programmi sulla fine del mondo, si preparava a «grandi catastrofi», accumulava sale, fiammiferi e scatolette. Rifiutava le medicine, rifiutava di farsi visitare. Lo supplicavo—lui gridava che volevo «rinchiuderlo in manicomio», che avevo «gli amanti» e «tutta Milano piangeva per me».
Vivevo come in un incubo. La casa era un campo di battaglia, i bambini avevano paura del loro stesso padre. Non potevo lasciarli in quell’atmosfera. Così me ne sono andata. Li ho presi e siamo scappati da mia sorella.
Il divorzio era inevitabile. Non potevo più vivere con quell’uomo. Non perché fosse malato. Ma perché si era rifiutato di curarsi, di lottare, di essere ancora un marito, un padre, una persona.
Adesso la sua famiglia mi accusa di egoismo. Dicono che l’ho abbandonato quando aveva «bisogno». Che l’ho lasciato nella disgrazia. Che me ne sono andata quando le cose si sono fatte difficili. Mi fa male sentirlo. Perché nessuno c’era quando passavo le notti in bianco per la stanchezza. Nessuno vedeva le mie mani tremare mentre lui urlava contro i bambini. Nessuno mi ha aiutata quando portavo il peso di due lavori.
Non l’avrei lasciato se avesse accettato uno psichiatra. Se avesse accettato l’aiuto. Se fosse rimasto sé stesso. Ma non potevo costringere i bambini a vivere nella paura e nella tossicità. Il mio dovere era proteggerli.
A volte ripenso a quell’Antonio di prima. Con il sorriso, la pazienza, gli occhi pieni di affetto. E il cuore mi si spezza. Ma poi guardo i miei bambini e so di aver fatto la cosa giusta. Li ho salvati. E me stessa. Anche a costo di un matrimonio finito e di un cuore in pezzi.