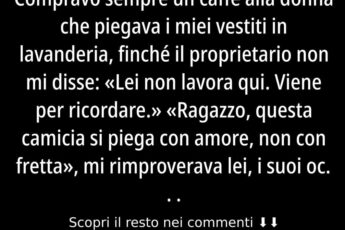Provai a cercare mio figlio tre anni fa, e ancora oggi mi ricordo lamaro di quella decisione, come se avessi dovuto inghiottire il mio stesso orgoglio pur di non soffocare nel dolore.
Per mesi fui quel padre che rincorre. Gli scrivevo messaggi, che rimanevano col pallino blu. Chiamavo, e il telefono squillava fino a quando la batteria non si esauriva. Lasciavo messaggi vocali con la voce spezzata, supplicandolo per cinque minuti solo cinque per capire quando e perché mi aveva cancellato dalla sua vita. Mi addormentavo tardi, ripassando i miei vecchi errori: quando da bambino la mia mano era stata troppo severa, quando tornavo stanco dallofficina e non volevo ascoltarlo, quando promettevo che ci sarei stato e invece mancavo. Mi chiedevo, con una vergogna che non confidavo a nessuno, se non fossi stato proprio io a rompere ciò che più desideravo proteggere.
E in quella insistenza mi ero perso. Non era solo il suo silenzio era che io stavo perdendo dignità. Senza accorgermene, gli insegnavo che il mio affetto aveva poco valore, qualcosa su cui si può passare sopra senza curarsene.
Un pomeriggio, seduto in cucina, lessi una frase lasciata su un foglio, al centro civico dove lui a volte aiutava:
«Il vero amore non si impone; si mostra. A volte il silenzio è il modo più forte di amare.»
Non era una minaccia, né una lezione amara. Era una verità semplice di quelle che scuotono piano, senza gridare.
Fu allora che smisi.
Non lo bloccai. Non scrissi frasi allusive. Non parlai in piazza dei figli ingrati. Non andai dai vicini a piangere per cercare conforto. Lasciai andare.
Non lo feci per orgoglio. Lo feci per rispetto verso di lui e verso di me.
Mi dissi: ho compiuto il mio dovere. Lho cresciuto con ciò che avevo, non con ciò che sognavo. Per mille mattine mi sono alzato allalba per accompagnarlo a scuola. Gli compravo i quaderni, quando i soldi bastavano appena, e quando non bastavano, un modo lo trovavo. Lavoravo doppi turni alla fabbrica di ricambi per auto e poi in officina, con le mani che profumavano sempre di olio, per non soffocarlo nei debiti. Andavo alle sue partite nei campetti polverosi, urlavo dalle tribune, anche quando dentro ero solo stanchezza. Gli insegnavo a chiedere scusa, a dire grazie, a guardare le persone negli occhi. Gli ho dato valori come si semina su terra dura con pazienza, con fede.
E accettai una cosa che mi bruciava: se il seme è stato piantato bene, prima o poi germoglierà. E se non fosse così le mie lacrime non sarebbero servite ad annaffiarlo.
Così ricominciai a vivere.
Riparai la veranda di casa quella che cadeva a pezzi da quando sua madre se ne era andata. Cambiai assi, pitturai con calma, senza fretta; quasi mettendo ordine dentro di me, ad ogni pennellata. Ricominciai a cucinare qualcosa solo per me fagioli, riso, un semplice stufato. Presi labitudine di mangiare senza aspettare passi. Iniziai ad aiutare alla mensa parrocchiale, distribuendo pasti caldi a persone che portavano silenzi simili al mio, e capii che accompagnare il dolore degli altri alleggerisce il proprio.
Domenica mattina presto andavo a messa non per chiedere miracoli, ma per imparare a respirare. Poi mi sedevo su una panchina con un caffè nel bicchierino e guardavo la vita scorrere. La signora del vicolo mi salutava. Il panettiere scherzava con me. Il quartiere viveva. E io, poco a poco, mi rialzavo.
Desideravo, se un giorno lui si fosse voltato allindietro, che vedesse non un uomo spezzato ad aspettare il telefono come un cane fedele. Volevo vedesse suo padre con la schiena dritta, lanima pulita, una pace quieta. Avevo capito che anche la calma educa, pure da lontano.
Passarono tre Natali. Tre sedie vuote. Tre volte mettevo un piatto per caso e poi lo riponevo senza scena. E piano la colpa cadde dalle mie spalle. Lui non scomparve davvero, solo smise di scrivere.
La vita, imparai, ha un modo strano di dirti che cosa conta proprio mentre tu credi di controllare tutto.
Un martedì qualsiasi nessuna festa, nessun compleanno, niente sentii una macchina fermarsi davanti casa.
Guardai fuori dalla finestra, il cuore mi batteva come fossi ragazzo prima di una finale. Vidi mio figlio scendere. Era invecchiato. Più stanco. Come se in tre anni gli fossero passate addosso cose che non si raccontano al telefono. Portava una culla tra le braccia.
Rimase fermo un attimo, guardando la veranda riparata da me. Guardando la casa che resisteva. Guardando me, come a chiedersi se fossi lo stesso.
Salì piano i gradini. Si fermò alla porta. La bocca gli tremò, prima che riuscisse a parlare, come se portasse un peso troppo grande.
«Non sapevo se mi avresti voluto vedere» disse, con la voce incrinata. «Io sono appena diventato padre. E quando lho tenuto tra le braccia ho capito. Ho capito quanto è difficile. Non lo sapevo.»
In quellistante lo vidi chiaramente: non era un uomo tornato per sfidare. Era un figlio tornato impaurito. E nei suoi occhi cera quella maturità che arriva tardi, ma arriva. Non era tornato con scuse eleganti. Ma sinceramente.
Avrei potuto chiedere dovera stata lei. Avrei potuto reclamare i giorni che mi rosicchiavano dentro. Avrei potuto tirare fuori quel te lavevo detto che i genitori portano in canna come un colpo mai sparato.
Ma lamore, quando è vero, non cerca rivincita. Cerca pace.
Aprii la porta.
Non gli chiesi di inginocchiarsi. Non pretesi spiegazioni. Semplicemente allungai la mano e spostai la zanzariera, come si sposta una nuvola davanti al sole.
Qui cè sempre un piatto per te gli dissi, e sentii le parole uscire pulite, senza veleno. Entra. Questa è casa tua.
Abbassò il capo, e una lacrima gli scappò senza permesso. Entrò, col bambino stretto sul petto. Il piccolo dormiva, ignaro che in quel momento si aggiustava qualcosa di vecchio e rotto. E io, per la prima volta da anni, sentii un altro respiro in casa e non faceva male. Mi curava.
Se insegui un figlio che scappa fermati.
Respira.
Non puoi pretendere un legame come fosse un debito.
Non puoi forzare un abbraccio come fosse un dovere.
A volte il gesto più forte è lasciar andare senza rancore, vivere con dignità, fidarti di quello che hai seminato, e andare avanti.
E se un giorno dovessero tornare perché a volte succede non aprire la porta con una sentenza in mano.
Aprila con grazia.
Perché, alla fine, lamore non è insistere fino a spezzare.
Lamore è lasciare la serratura senza chiave
per quando il cuore ritroverà la via di casa.
Ho smesso di cercare mio figlio tre anni fa, e ancora sento il sapore amaro di quella scelta, come s…