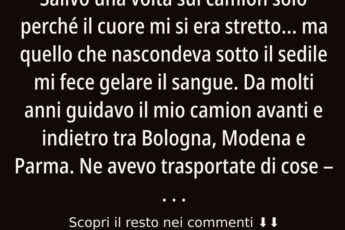La chiave in mano
La pioggia tamburella monotona contro i vetri dellappartamento, come un metronomo che segna il tempo che passa. Michele è seduto sul bordo del vecchio letto consunto, incurvato su se stesso, come se volesse diventare più piccolo, sparire agli occhi del suo stesso destino.
Le sue mani grandi, un tempo forti e abituate a lavorare in officina, ora riposano inerti sulle ginocchia. Ogni tanto le dita si stringono, come a voler afferrare qualcosa che non cè più. Non guarda il muro, ma vede sulla tappezzeria logora una mappa dei percorsi senza speranza: dalla ASL comunale al centro diagnostico a pagamento. Il suo sguardo è scolorito come una vecchia pellicola ferma sullo stesso fotogramma.
Un altro specialista. Unaltra occhiata compassionevole, un altro Signor Michele, ormai anche letà conta, che suona come una sentenza. Non si arrabbia, non ne ha più la forza. Rimane solo la stanchezza.
Il mal di schiena non è più solo un sintomo: è diventato il suo paesaggio privato, lo sfondo invisibile di ogni gesto, di ogni pensiero, un rumore bianco di impotenza che copre tutto il resto.
Segue ogni prescrizione: prende medicinali, si spalma le creme, si sdraia sulla branda fredda della fisioterapia, sentendosi come un pezzo rotto lasciato in un magazzino.
E nel frattempo aspetta. Passivo, quasi con fede cieca, quel salvagente che qualcuno lo Stato, un geniale dottore, un luminare un giorno lancerà per salvarlo, mentre lui affonda piano nel fango.
Scruta il proprio orizzonte, ma vede solo la pioggia grigia oltre la finestra. La volontà, quella che gli permetteva di risolvere ogni problema in officina e a casa, ora si è ridotta a ununica funzione: resistere e sperare in un miracolo dallesterno.
La famiglia Cera, un tempo, ma si è sciolta in fretta, come neve sulla strada. Gli anni sono volati senza accorgersene. Prima è andata via la figlia la sua brava Caterina a Milano per una vita migliore. Non si era opposto alla sua scelta, voleva il meglio per lei. Papà, appena mi sistemo ti aiuto io, gli diceva al telefono. Ma ormai non importava più.
Poi è andata via anche la moglie. Non al supermercato sotto casa, ma per sempre. Rosa se nè andata in fretta un tumore spietato, scoperto troppo tardi. Michele è rimasto da solo: schiena a pezzi e il silenzioso rimorso di essere ancora vivo, mentre lei, la sua forza, il suo motore, la sua Rosina, si spegneva in tre mesi. Lha accudita fino allultimo, finché la tosse non è diventata roca e nei suoi occhi non è apparso quel lampo sfuggente. Le ultime parole, in ospedale, stringendogli la mano: Resisti, Michè Lui non ha resistito. Si è rotto per sempre dentro.
Caterina lo chiama, gli propone di andare a stare da lei nella sua piccola casa in affitto, cerca di convincerlo. Ma a cosa servirebbe? In una casa estranea. Non vuole essere un peso. E tanto lei non tornerà indietro.
Adesso lo viene a trovare solo la sorella minore di Rosa, Valeria. Una volta a settimana, come da programma, gli porta la minestra nel barattolo, del riso o della pasta con le polpette e una scatola nuova di antidolorifici.
Allora, Michè? domanda, togliendosi il cappotto. Lui annuisce: Niente di nuovo. Stanno in silenzio, mentre Valeria rassetta la sua stanza, come se mettere a posto le cose potesse mettere a posto anche la sua vita. Poi se ne va, lasciando dietro sé il profumo del suo dopobarba e una sensazione fisica di dovere.
È grato. E infinitamente solo. La sua solitudine non è solo fisica: è una cella costruita dalla propria impotenza, dal dolore e da una rabbia tranquilla verso un mondo ingiusto.
Una sera, quando si sente più vuoto del solito, lo sguardo vaga sul tappeto stinto e si ferma su una chiave lasciata a terra. Forse gli è caduta quando, con fatica, era rientrato dalla ASL.
Solo una chiave, nulla di speciale. Un pezzo di metallo. Eppure la osserva come fosse la prima volta. Sta lì, in silenzio. Aspetta.
Ricorda il nonno. Nitidamente, come se qualcuno avesse acceso la luce in una stanza buia della memoria. Il nonno, Pietro Giorgio, con la manica vuota infilata nella cintura, si sedeva su uno sgabello e riusciva a legarsi le scarpe con una mano sola e una forchetta rotta. Con calma, concentrazione e una smorfia di trionfo quando ci riusciva.
Vedi, Michelino, diceva, e nei suoi occhi brillava la vittoria della mente sulle avversità, Lattrezzo è sempre lì vicino a te. A volte non sembra uno strumento, sembra solo un ferro vecchio. Limportante è saper vedere negli oggetti inutili un alleato.
Da bambino gli sembravano solo chiacchiere da vecchio, favole per tirare su il morale. Il nonno era un eroe, e si sa, gli eroi possono tutto. Ma lui, Michele, era solo un uomo normale, e la sua battaglia contro la schiena e contro la solitudine non lasciava spazio a magie con gli utensili.
Ora però, fissando quella chiave, la scena riaffiora non come una favola, ma come un rimprovero silenzioso. Il nonno non aspettava aiuto. Usava quello che aveva: una forchetta rotta, ma vinceva. Non la malattia, non la perdita: vinceva limpotenza.
E lui, Michele? Si è limitato ad aspettare, passivo, il favore di qualcun altro. Il pensiero lo scuote.
Ed ecco la chiave Quel pezzo di metallo, che racchiude leco delle parole del nonno, ora sembra un comando silenzioso. Si alza, con il solito lamento delle ossa a vergognarsi anche da solo. Fa due passi trascinati, si stira. Le articolazioni scricchiolano come vetro rotto. Afferra la chiave. Prova a raddrizzarsi una fitta tagliente lo colpisce in fondo alla schiena. Rimane fermo, i denti serrati, aspettando che la morsa si allenti. Però, invece di arrendersi e tornare nel letto, lentamente e con cautela, si avvicina al muro.
Non pensa, non ragiona: si lascia guidare dal desiderio. Si gira con le spalle contro la parete. Premendo il lato arrotondato della chiave contro la tappezzeria, allaltezza del punto dolente, comincia a spingere con delicatezza, usando tutto il suo peso.
Non vuole massaggiare o sciogliere; non è una terapia medica. È un atto di pressione, duro e profondo, che mette la realtà contro la realtà, il dolore contro il dolore.
Trova un punto dove la pressione porta uno strano sollievo come se qualcosa dentro di lui per un attimo si sciogliesse. Sposta la chiave più in alto, poi più in basso. Ripete il gesto.
Ogni movimento è lento, attento, come un dialogo con il suo corpo. Non è una cura. Sono trattative. E lo strumento su quella trattativa non è un sofisticato apparecchio medico, ma una chiave vecchia.
È assurdo. Una chiave non è una panacea. La sera dopo, quando il dolore ritorna, lo ripete. E ancora. Individua i punti, dove quella pressione non fa male ma porta sollievo, quasi come se riuscisse ad allentare la morsa dallinterno.
Poi comincia a usare lo stipite della porta per fare leggere trazioni. Un bicchiere dacqua sul comodino lo richiama: Bevi. Solo acqua, gratis.
Michele smette di aspettare a mani giunte. Comincia a usare ciò che ha: la chiave, lo stipite, il pavimento per i piccoli esercizi, la sua stessa volontà. Prende un quadernino, non per annotare il dolore, ma le vittorie della chiave: Oggi sono rimasto ai fornelli cinque minuti in più.
Sulla finestra mette tre lattine vuote di pelati che aveva pensato di buttare. Ci versa della terra presa nel piccolo giardino del portone, pianta qualche bulbo di cipolla. Non è un orto. Sono tre barattoli di vita di cui ora si sente responsabile.
Passa un mese. Alla visita il medico, guardando le nuove lastre, alza un sopracciglio, stupito.
Ci sono cambiamenti. Ha fatto esercizio?
Sì, risponde Michele semplicemente. Ho usato quello che avevo in casa.
Non racconta della chiave. Non capirebbero. Ma Michele lo sa. La salvezza non è arrivata su uno yacht. Era lì, sul pavimento, mentre lui fissava il muro aspettando che qualcuno accendesse la luce al posto suo.
Un mercoledì, quando Valeria compare con la zuppa, rimane inchiodata sulluscio. Sul davanzale, dalle lattine, cresce un verde di cipolla giovane. Nellaria non cè odore di stantio o di medicine, ma qualcosa di diverso, che porta speranza.
Ma che cosè? è tutto ciò che riesce a dire, guardando Michele, in piedi, sicuro, vicino alla finestra.
Michele, che proprio in quel momento sta innaffiando le sue piantine con una tazza, si volta.
Lorto, dice semplicemente. E, dopo una pausa: Ne vuoi un po per la tua zuppa? Fresco, coltivato da me.
Quella sera lei si trattiene più a lungo del solito. Bevono il tè, e lui, senza lamentarsi della salute, racconta della scala del palazzo che ora riesce a salire, ogni giorno, di un piano in più.
La salvezza non è apparsa con le sembianze del dottor Balanzone e una pozione magica. Si è nascosta in una chiave, uno stipite, una lattina vuota, una scala qualsiasi.
Non ha cancellato dolore, né lutto, né vecchiaia. Ma gli ha messo in mano degli strumenti non per vincere la guerra, ma per combattere ogni giorno le sue piccole battaglie.
E così, quando smetti di aspettare la scala doro dal cielo e ti accorgi di quella di cemento sotto i piedi, scopri che salire, piano piano, è già vivere. Lentamente, in equilibrio, un gradino dopo laltro, ma sempre in su.
E sul davanzale, in tre barattoli di latta, cresce una cipolla rigogliosa. Lorto più bello del mondo.