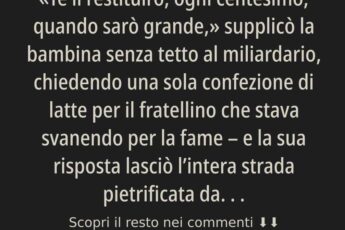Panchina per due
La neve si era già sciolta, ma la terra nel parchetto restava scura e umida, e sui vialetti cerano strisce sottili di sabbia. Giulia Sereni avanzava piano, stringendo la borsa della spesa, e guardava i propri piedi. Da anni aveva preso labitudine di memorizzare ogni buca, ogni sasso. Non era tanto per eccessiva prudenza, ma dopo una frattura al braccio, tre anni prima, la paura di cadere si era annidata nel petto e non laveva più lasciata.
Viveva sola in un bilocale al piano terra, una casa che una volta era piena di voci, profumi di sugo, porte che sbattevano. Ora cera silenzio. La televisione borbottava di sottofondo, ma spesso si rendeva conto che non ascoltava: guardava solo i titoli che scorrevano. Il figlio la chiamava su WhatsApp la domenica di fretta, tra una cosa e laltra, ma chiamava. Il nipote ogni tanto compariva nello schermo, la salutava con la mano, mostrava dei pupazzi. Lei si rallegrava, ma appena riattaccava sentiva laria della casa diventare di nuovo immobile.
Aveva una routine: ginnastica, pillole, caffelatte e biscotti al mattino. Poi una breve passeggiata fino al parco, per riattivare la circolazione, come diceva la dottoressa. Dopo, cucinare qualcosa, guardare il telegiornale, ogni tanto un cruciverba. La sera serie TV e uncinetto. Non era nulla di speciale, ma le consentiva di restare in forma così ripeteva sempre alla vicina sulle scale.
Oggi il vento era tagliente, ma secco. Giulia Sereni arrivò alla sua panchina accanto alla piccola area giochi e si sedette con cautela sullestremità. Poggiò la borsa accanto a sé, verificò che fosse chiusa. Due bambini giocavano a rincorrersi nelle tute colorate, le madri chiacchieravano ignorando i passanti. Decise che sarebbe rimasta solo qualche minuto, poi sarebbe tornata a casa.
Dallaltro lato del parco, Andrea Rinaldi stava andando verso la fermata dellautobus, contando i passi. Fino alledicola erano settantatré; alla farmacia centoquindici; al capolinea novantaquattro. Contare i passi era meglio che pensare al fatto che nessuno lo aspettava a casa.
Un tempo faceva loperaio in fabbrica, partiva per i cantieri, litigava coi capi e rideva con i colleghi in pausa sigaretta. Da tempo la fabbrica aveva chiuso. Degli amici, ne vedeva sempre meno: qualcuno era andato dai figli, qualcuno ormai al cimitero. Il figlio viveva a Milano, veniva una volta lanno per tre giorni, sempre di corsa. La figlia abitava nel quartiere accanto, ma lavorava e aveva due figli piccoli, il mutuo sulle spalle. Non se la prendeva o almeno così si diceva. Ma la sera, quando era già buio e il termosifone sibilava, si scopriva in ascolto: forse un giorno la serratura scatterà.
Oggi era uscito per comprare il pane e, già che cera, sarebbe passato in farmacia a prendere altre pastiglie per la pressione. La dottoressa aveva raccomandato di non restare mai senza. Teneva in tasca la lista scritta in caratteri grandi, le dita tremavano un poco mentre la tirava fuori per controllare di non aver scordato nulla.
Arrivato alla fermata, vide che lautobus era appena partito. Gente che si disperdeva. Su una panchina, una donna con un piumino grigio chiaro e un berretto azzurro di lana. Accanto a lei, la borsa. Non guardava la strada, ma il parchetto.
Andrea esitò. Stare in piedi era scomodo, la schiena faceva male. La panchina era a metà libera, ma aveva sempre pudore a sedersi accanto a donne sconosciute. Chissà cosa pensano. Però il vento gli entrava nelle ossa, così prese coraggio.
Posso sedermi? chiese, chinando la testa.
La donna si voltò. Aveva occhi chiari, le rughette agli angoli.
Certo, si accomodi rispose, spostando un po la borsa.
Si sedette, appoggiando le mani ai lati della panchina. Silenzio. Una macchina passò lasciando odore di scarico.
Gli autobus vanno come capita, di questi tempi commentò lui, rompendo la quiete. Ti distrai un attimo e se ne vanno.
Eh già annuì lei . Ieri ho aspettato mezzora. Almeno non cera pioggia.
Lui la guardò meglio. Il viso non gli diceva nulla, ma nel quartiere ormai cerano troppe facce nuove.
Abita qui vicino? domandò con cautela.
Lì, di fronte disse lei indicando i palazzi bassi oltre la strada. Primo ingresso, sopra lalimentari. E lei?
Dallaltro lato del parco, nel palazzone alto rispose Andrea. Anche io sono della zona.
Tacquero di nuovo. Giulia pensava che i dialoghi alla fermata fossero la norma: due parole, ognuno per la sua strada. Ma lui appariva stanco, un po smarrito, anche se faceva il burbero.
Va in farmacia? chiese lei guardando il suo sacchetto.
Sì, dovevo prendere le pastiglie disse lui alzando il sacchetto . La pressione fa i capricci. E lei?
In alimentari rispose . Due cosine. E poi bisogna camminare, altrimenti si resta troppo in casa.
Appena pronunciata quella parola, casa, sentì una fitta amara. Suonava vuota.
Lautobus comparve dallincrocio. La gente si avvicinò al marciapiede. Andrea si alzò, indugiò un attimo.
Io sono Andrea, fra laltro disse tutto dun fiato. Andrea Rinaldi.
Giulia Sereni rispose lei alzandosi a sua volta. Piacere.
Saliti sullautobus, la calca li separò. Giulia si tenne al corrimano, sentendo i sobbalzi sulle buche. Tra la gente intravide ancora Andrea, che le fece un cenno. Lei rispose di rimando.
Qualche giorno dopo si incontrarono di nuovo, di nuovo nel parco. Giulia era alla sua panchina quando lo riconobbe. Andrea avanzava appoggiato a un bastone: prima non laveva. Sembrava avesse deciso di prevenire brutte cadute.
Ecco la mia vicina di fermata sorrise lui . Posso fermarmi?
Certo disse lei, e ne fu quasi contenta.
Andrea si accomodò, mettendo il bastone accanto a sé.
Qui si sta bene disse guardandosi attorno . Alberi, bambini che giocano. Casa a volte sembra di soffocare fra i muri.
Vive da solo? chiese lei, ormai convinta fosse una domanda naturale.
Solo fece lui con un cenno. La moglie è mancata sette anni fa. I figli per conto loro. E lei?
Anchio sola rispose lei . Mio marito è morto ventanni fa. Mio figlio con la sua famiglia a Torino. Mi chiamano, certo, ma
Alzò le spalle. Lui annuì comprensivo.
Le chiamate vanno bene disse . Ma la sera il telefono resta zitto.
Quelle parole, così semplici, la scaldarono.
Parlarono un po di prezzi, del tempo, del fatto che alla mutua avevano cambiato ancora medico. Poi si salutarono e il giorno dopo, senza accordarsi, entrambi uscirono alla stessa ora.
Così cominciarono i loro incontri regolari. Prima alla fermata e al parco, poi davanti al negozio, infine pure allingresso della mutua. Giulia si accorse di regolare i suoi orari per incontrare Andrea. Non lo ammetteva nemmeno a se stessa: solo una cottura anticipata, oppure una partenza più lenta.
Andavano insieme alla mutua, commentando quali esami servivano a chi, criticando la burocrazia digitale a cui Giulia non si adattava.
Deve farlo con lo SPID spiegava la giovane impiegata. Ci si iscrive online.
Che online, io ho il telefonino vecchio che quasi non prende brontolava Giulia uscendo nel corridoio.
Andrea ascoltava, scuotendo la testa.
Si vuole che la aiuti io? propose un giorno. Ho un tablet che i miei figli mi hanno regalato. Ci dovrebbe essere laccesso lì. Vediamo insieme, magari.
Allinizio Giulia rifiutò, poi accettò. Si sedettero su una panchina davanti al poliambulatorio, e lui, strizzando gli occhi sullo schermo, cercava la sezione giusta, a volte sbagliando e sbuffando sommessamente. Lei rideva, e la sua risata le usciva naturale.
Ecco disse lui alla fine , si può scegliere orario e dottore. Basta ricordarsi la password.
Me la segno rispose Giulia convinta. Tengo un quadernetto per queste cose.
Una volta fu lei ad aiutarlo con le bollette. Andrea le portò una pila di fatture recuperate dalla buca delle lettere.
Una volta era facile sospirava . Andavi alla Posta, pagavi. Ora ci sono codici, scontrini, bancomat da impazzire.
Gliele ordino io diceva Giulia paziente : questa è per la luce, questa per lacqua. Basta non confondersi.
Sedevano in cucina da Giulia, davanti a un tè caldo. Lei tirava fuori la marmellata di prugne, lui portava le ciambelline. Dalla finestra si vedeva il cortile coi bambini in bicicletta. Le piaceva vedere Andrea che ordinava i fogli, chiedeva consigli, ogni tanto si incaponiva.
Non serve che paghi lei, protestò un giorno quando lei proponeva di usare il POS visto che lui faticava . Faccio da solo.
Ma mi dà i contanti, mica anticipo io lo rimbeccava lei. Non faccia il bambino.
Lui si vergognava un po, ma accettava. Dentro si agitava un sentimento strano, un misto di gratitudine e imbarazzo. Non amava dover nulla a nessuno.
Ogni tanto litigavano, mai a voce alta ma risentiti. Un giorno uscendo dal negozio parlarono dei figli.
Mio figlio vuole che vendo la casa e vado da lui raccontava Andrea . Ma alla loro età? Vivrei sul divano qui invece ho le mie cose.
Anche mio figlio vorrebbe che mi trasferissi sospirò Giulia . Hanno tanto spazio, ma rimando sempre. Qui ho le tombe, le amiche. Forse dovrei, ma ho paura.
Ma lì non servono a nessuno disse di scatto lui . Tra lavoro, scuola, nessuno ha tempo. Qui almeno cè la tua roba, i tuoi ritmi.
E qui, a chi servo? replicò lei tranquilla.
Lui tacque. Quella parola qui lo punse. Gli parve che si riferisse anche a lui. Savvilì, sentendo salire lirritazione.
Scusa borbottò . Pensavo che ormai fossimo
Non finì la frase. Amici gli sembrava troppo. Lei lo intuì.
Non parlavo di lei disse composta . Parlo in generale. Ho paura che andandomene qui tutto sparisca. Questo sì.
Lui annuì, fecero il resto della strada in silenzio. Al portone lui salutò un po brusco, e quella notte faticò a dormire, rimuginando di aver rovinato tutto.
Per alcuni giorni non si videro. Il tempo peggiorò, arrivò una pioggia fredda e nevischio. Giulia comunque uscì per una breve passeggiata, ma Andrea niente.
Il quarto giorno, tornando dal supermercato, trovò nella buca delle lettere un foglio: Per Giulia Sereni. Sono allospedale. Andrea R. Nessun indirizzo, né stanza, solo quello.
Le mani le tremavano. Entrò in casa, poggiò la borsa, si sedette fissando il foglio. Mille pensieri: che era successo? Infarto? Aiuto? Chi laveva soccorso?
Le tornò in mente quella volta che Andrea citava il reparto di cardiologia in ospedale: cercò sul cellulare il numero della segreteria che aveva appuntato. Chiamò, attese, venne passata da un interno allaltro. Alla fine le diedero il numero di stanza e lorario visite.
Le ospedali lavevano sempre fatta rabbrividire, quellodore di alcool e disinfettante. Ma il giorno dopo, allapertura visite, era già lì. Aveva portato mele e biscotti. Sperava non fossero troppo dolci per lui.
Passò davanti alle stanze: nella terza trovò Andrea, schienato tra i cuscini a leggere il giornale. Vedendola, allinizio sembrò imbarazzato, poi il sollievo lo illuminò.
Giulia Sereni! posò il giornale. Come mi ha trovata?
Un po dastuzia rispose lei, appoggiando la spesa . Che cosè successo?
Il cuore sospirò lui . Di notte, lambulanza mha portato qui. Qualche giorno qui, poi torno.
Giulia lo osservò bene. Più pallido, occhiaie. Ma negli occhi, la solita luce.
I figli sanno? domandò.
La figlia è venuta, ha portato il brodo. Al figlio non dico nulla: non voglio preoccuparlo.
Lo disse pacato, ma la voce tradiva una tensione. Poi aggiunse piano:
Mia figlia mha chiesto di lei. Chi è questa signora della lettera? Ho detto che aiuta con le pratiche, che siamo vicini.
Giulia sentì un colpo interno. Vicini che aiutano sembrava poco, quasi estraneo. Si accomodò sulla sedia.
Ma è la verità disse, cercando il tono fermo . A volte le pratiche si fanno insieme.
Andrea la fissò e capì che aveva parlato male. Si vergognò.
Non volevo dir così affrettò . Lei mha chiesto in modo diffidente. Se le dico che è unamica, parte subito: Papà, mica hai diciotto anni!. Temono che impazziamo.
In effetti non abbiamo più diciotto anni rise lei . Ma sempre persone restiamo.
Lui annuì. In corsia tornò il silenzio. Il vicino di letto fece finta di dormire.
Sa disse Andrea : sdraiato qui di notte, mi sono accorto che il peggio non è la morte, ma il pensiero che se succede qualcosa, nessuno lo sa. I figli lavorano, hanno la loro vita Poi ho ricordato lei. Mi sono sentito meglio. Se non altro qualcuno sa dove sono.
A Giulia venne un nodo in gola. Distolse lo sguardo dalla finestra, dove su un davanzale cera una piantina mezza secca.
Anchio ho paura confessò. Faccio sempre la forte: col figlio, coi vicini. Ma di sera, sola, conto quante pastiglie mi restano. Fa ridere, eh?
Non fa ridere rispose lui . Anchio conto.
Si guardarono e sorrisero di intesa: un piccolo riconoscimento umano.
In quel momento entrò una donna sui quarantanni, borsetta della spesa in mano. Somigliava ad Andrea: stesso sguardo deciso.
Papà disse posando il sacchetto . Ho portato il minestrone. E lei chi è?
Guardò Giulia, a metà tra il curioso e il cortese.
Giulia Sereni rispose calma Andrea . Una cara conoscente. Facciamo le cose insieme, lei mi aiuta con le pratiche e le ricevute.
Buongiorno disse la donna educata . Grazie dellaiuto. Sa, è testardo, vuol far tutto da solo.
Buongiorno ricambiò Giulia. Ogni tanto si passeggia insieme.
La donna annuì, ma rimase guardinga. Si occupò di sistemare la stanza, fece domande al padre. Giulia si sentì di troppo e salutò.
Passerò ancora disse sulla porta.
Venga rispose lui. Se non le pesa.
Mi fa solo piacere replicò uscendo.
A casa, rimuginò sulle parole udite. Cara conoscente suonava modesto, ma forse era così che andava. A quelletà, parole grosse stonavano. Importava che lavesse cercata, quando era spaventato.
Andrea restò in ospedale due settimane. Giulia andava a trovarlo un giorno sì e uno no, portava frutta, calze pulite, dei quotidiani. Spesso stavano zitti, ascoltando il tintinnar dei carrelli in corridoio. Talvolta evocavano storie: la fabbrica, la scuola, la casa di campagna ormai venduta.
La figlia di Andrea finì per accettare la sua presenza. Un giorno, accompagnandola allascensore, le disse:
Grazie. Lavoro, non posso passare spesso. Importante che papà abbia qualcuno con cui parlare. Ma non prenda tutto sulle sue spalle, eh. Se è serio, chiami me.
Non mi prendo tutto rispose Giulia pacata . Lei ha la sua vita, io la mia. Se posso dare una mano, lo faccio volentieri.
Andrea fu dimesso a fine aprile. Il medico raccomandò camminate, poco stress, pillole regolari. La figlia lo accompagnò in auto, lo aiutò a sistemarsi. Il mattino seguente, con il bastone, scese in cortile diretto al parco.
Giulia era già lì, sulla panchina. Appena lo vide si alzò.
Allora? domandò scrutando il volto.
Sopravvissuto ghignò lui . E va già bene.
Si sedettero insieme, in silenzio, ascoltando i rumori del cortile. Poi Andrea disse:
Ho pensato tanto, in ospedale. Non voglio esserle di peso. Mi fa piacere che sia venuta, ma ho anche una certa vergogna come se lavessi disturbata.
Quali impegni dovrei lasciare? sospirò lei . Il supermercato, la mutua, i telefilm non esageri.
Comunque, insistette non vorrei che si sentisse obbligata a badare a me. Sono adulto, non un bambino.
Lo guardò a lungo.
Crede che a me piaccia pensare di pesare su qualcuno? Anchio temo quello, e perciò faccio sempre tutto da sola. Ma ho capito una cosa. Si può restare chiusi in casa a temere di disturbare, oppure si può mettersi daccordo. Non bisogna promettere miracoli, solo esserci, secondo le possibilità.
Lui ci pensò su.
E cioè? domandò.
Vuol dire spiegò contando sulle dita : lei non mi chiama di notte solo perché ha linsonnia. Non sono il pronto soccorso. Ma se ha bisogno di andare alla mutua e le mette ansia, mi telefoni. Se cè da ordinare le bollette, venga pure da me. Ma per la spesa, se è in grado va da solo, non sono una portinaia.
Andrea si mise a ridere.
È dura.
È onesto replicò lei. Però vale anche per me. Se sto male, la chiamo. Ma non pretendo che lasci tutto e venga di corsa. Lei ha i figli, io mio figlio. Rispetto.
I ruoli ora erano chiari, e Andrea si sentì sollevato.
Daccordo concluse . Aiuto reciproco, però niente crocerossini.
Esatto sorrise lei.
Da allora la loro amicizia divenne più serena. Continuavano a vedersi al parco, ad andare insieme alla mutua, ogni tanto a bere il tè a casa. Ora però ognuno conosceva i confini.
Quando a Giulia si ruppe il rubinetto, telefonò ad Andrea.
Potrebbe dare unocchiata? Ho paura che salti tutto.
Posso vedere rispose . Ma se è grave, chiamiamo lidraulico, non sono più quello di una volta.
Lui venne, diagnosticò che ci voleva la sostituzione, aiutò a chiamare il tecnico. Mentre aspettavano, chiacchieravano in cucina. Raccontava di come una volta sapesse riparare tutto, ora non più. Lei pensava che la vecchiaia fosse anche imparare a chiedere aiuto, senza vergogna.
Talvolta andavano insieme al mercato. Tra la folla, Andrea trattava sulla frutta, Giulia sceglieva il pollo. Tornando, si lamentavano dei prezzi, ma entrambi sapevano che senza quella uscita, le giornate sarebbero state più vuote.
I figli reagivano a modo loro. Un giorno il figlio di Giulia la chiamò, sospettoso:
Mamma, parli spesso di questo Andrea Rinaldi. Chi è?
Un vicino rispose . Andiamo a camminare, mi aiuta col tablet, io con le bollette.
Guardati da chi metti in mano soldi e carte, mi raccomando.
Lei rise.
So ancora badare a me, stai tranquillo.
Anche la figlia di Andrea ogni tanto indagava.
Papà, occhio a non esagerare con questa signora. Non è mica una badante. Ognuno la sua vita.
Abbiamo un patto rispondeva lui . Non ci sfruttiamo.
Che patto?
Quello dei vecchietti scherzava lui.
Lestate arrivò piano. Le foglie si aprirono, le panchine del parco si riempirono. Giovani mamme, adolescenti con le cuffie, altri pensionati. Ma Andrea e Giulia avevano la loro panchina prenotata: sempre lo stesso posto, quasi a trattenere lordine nel mondo.
Una sera, col sole basso, guardavano i bambini giocare a pallone. Il vento aveva odore di polvere e prato. Andrea aggiustò il bastone vicino alla panchina.
Sa cosa ho capito disse fissando i ragazzi in campo . Pensavo che la vecchiaia fosse la fine di tutto: lavoro, amicizie, persino il piacere di leggere. Restano solo medicine e TV. Ora vedo che qualcosa può anche cominciare, in modo diverso.
Sta parlando di noi? chiese lei, sorridendo.
Anche di noi annuì lui . Non so che nome dargli: amicizia, alleanza, compagnia da file e ricette. Ma con lei sto più tranquillo. Ho meno paura.
Lei guardò le sue mani, nodose e segnate. Poi le proprie: si somigliavano, mani che avevano vissuto tanto.
Anchio disse . Prima di dormire, pensavo: se domani non mi sveglio, chi si accorge? Ora so che almeno una persona si chiederebbe perché non sono scesa al parco.
Andrea sorrise.
Non solo mi chiederei: muovo tutto il condominio!
E fa bene accennò lei.
Sedettero ancora un poco, poi si alzarono, camminando lenti, ognuno dal suo lato del sentiero. Al bivio si fermarono.
Domattina alla mutua? chiese lui.
Sì confermò lei . Devo fare gli esami del sangue. Mi accompagna?
Fino alla porta dellambulatorio rise lui . O mi succhierò tutto il sangue a parole!
Lei ridacchiò.
Perfetto.
Si salutarono e andarono ciascuno al proprio portone. Giulia salì le scale, entrò, posò la borsa, andò in cucina ad accendere il bollitore. Mentre lacqua scaldava, si affacciò alla finestra.
In fondo, Andrea armeggiava con la serratura. Alzò la testa come se sentisse il suo sguardo, la salutò con la mano. Lei rispose allo stesso modo.
La teiera fischiò. Giulia versò il tè, prese una fetta di pane. Davanti a lei, sulla sedia, cera la sua sciarpa alluncinetto. Vi posò la mano e si rese conto che in quel silenzio cera qualcosa di nuovo. Non era più mutismo profondo, ma uno spazio popolato. Qualcuno la aspettava, domani sarebbero andati insieme dal medico, sarebbero rimasti seduti in corridoio, avrebbero brontolato sui dottori, si sarebbero domandati a vicenda come va.
La vecchiaia restava, certo: dolori, farmaci, prezzi alti. Ma adesso cera un piccolo appoggio. Nessun miracolo, nessuna salvezza. Solo una panchina in più dove fermarsi e riprendere fiato in due, per continuare ognuno col proprio passo, ma insieme.