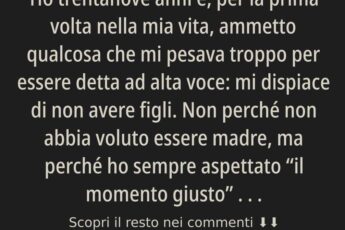«So che sono miei figli,» mormorò lui, senza alzare gli occhi. «Ma… non so spiegare perché, tra noi non cè alcun legame.»
«Guarda lei! Che bella che è!» esclamai io, stringendo a me il corpicino caldo della nostra figlia appena nata. Ginevrina riposava avvolta in una coperta soffice, raggomitolata come un piccolo gomitolo di vita, e respirava piano. Non riuscivo a distogliere lo sguardo. In quel momento, il mondo si era ridotto a un solo viso, un solo respiro, un solo pensiero: «È mia. Ce labbiamo.»
Accanto a me stava Alessandro. Guardava la bambina, ma nel suo sguardo cera una miscela di tenerezza e… qualcosaltro. Qualcosa di indefinito, quasi spaventato. Tese una mano, sfiorando delicatamente con un dito la guancia della piccola.
«Somiglia a te,» disse a bassa voce, quasi un sussurro. Ma nel tono mancava quellesaltazione luminosa che mi aspettavo. Non cera la gioia che avrebbe dovuto traboccare. Allora non ci feci caso. E va bene, somiglia a mee allora? Limportante era che la nostra famiglia fosse cresciuta, che la bambina fosse sana, e che ora fossimo davvero genitori.
Ma gli anni passarono, e quando nacque la seconda figliaBeatricecominciai a notare ciò che prima non avevo voluto vedere. Entrambe le bambine erano straordinariamente simili luna allaltra. Quegli occhi grandi e castani, il nasino delicato, la fronte alta, i capelli scuri e foltiera come se fossero stati copiati dal ritratto di mio padre. Sembravano uscite dalla stessa cornice che lo immortalava da bambino. Nessun tratto di Alessandro. Non i suoi occhi azzurri, non le fossette sulle guance, nemmeno quellespressione tipica del suo viso. Diventò un problema. Serio e doloroso.
Ero seduta al tavolo della cucina, mescolando meccanicamente un tè ormai freddo. Dietro di me, il respiro regolare delle bambine addormentate, e davanti, con unespressione strana, mia suoceraValentina Rossi. Era «passata a fare un saluto», come diceva sempre. Ma sapevo: quelle visite non erano mai casuali. Soprattutto negli ultimi mesi, quando tra noi si erano accumulate reticenze, silenzi e una fredda ostilità.
«Vittoria,» cominciò lei, scegliendo le parole con cautela, come se temesse di ferire, «le bambine sono bellissime, certo. Ma… sei sicura che siano di Sandro? Sono proprio uguali a tuo padre. Come due gocce. È incredibile, no?»
Il cucchiaino nella mia mano tintinnò contro la tazza. Mi bloccai. Quelle parole le avevo già sentitein battute, allusioni, sussurri. Ma da lei, dalla donna che mi chiamava «figlia», suonava ancora più doloroso. Come un pugno nello stomaco.
«Valentina, che cosa sta dicendo?» La mia voce tremava. «Certo che sono di Sandro! Lo sa bene! Le abbiamo aspettate tanto, io le ho partorite, lui le ha prese in braccio in ospedale! Come può dubitarne?»
Lei si strinse nelle spalle, come a dire: «Chi lo sa». E in quel gestotutta la sua convinzione che il dubbio avesse diritto di esistere. Sentivo lamarezza stringermi dentro, ma anche lansia. Perché la cosa più terribile non erano quelle parole. La cosa più terribile era che anche mio marito aveva cominciato ad allontanarsi dalle nostre figlie.
«Sandro, perché non sei andato a prendere Ginevrina allasilo?» chiesi quando tornò a casa tardi, quasi allalba. Ginevrina dormiva già, Beatrice sonnecchiava sul divano. E io, stanca dopo un doppio turno, le faccende di casa e le preoccupazioni costanti, reggevo a malapena la stanchezza.
«Mi è scappato di mente, scusa,» disse lui, gettando indifferentemente la giacca su una sedia, senza neanche guardarmi. «Avevo da fare.»
«Sei sempre occupato,» cedetti alla frustrazione. «Ma quandè che passi del tempo con loro? Quandè lultima volta che hai giocato con Beatrice? O almeno letto una storia a Ginevrina?»
Rimase in silenzio. Un silenzio lungo, pesante, che poi si spezzò con la sua vocebassa, ma piena di peso:
«Non mi attirano, Vittoria. Non so perché. Loro… mi sembrano estranee. Ci provo, ma non sento che siano mie.»
Le lacrime mi salirono in gola. Come poteva dire una cosa simile delle sue figlie? Di quelle stesse bambine che aveva desiderato, sognato? Ma a un certo punto capiiera sincero. Sandro aveva davvero voluto una figlia che gli somigliasse. Aveva immaginato di giocarci, di essere orgoglioso quando avrebbe ereditato i suoi tratti. Voleva vedersi in lei. Invecedue bambine che ricordavano mio padre. Come se le avessi partorite da sola.
Cominciai a cercare su internet, a leggere di genetica, eredità, leggi dei geni dominanti e recessivi. Scoprii che poteva succedere. A volte laspetto di un bambino assomiglia più ai nonni che ai genitori. Mio padre aveva geni molto fortiocchi castani, fronte alta, capelli scuri. Ed entrambe le mie figlie li avevano ereditati. Ma come spiegarlo a Sandro e alla sua famiglia, se avevano già tratto le loro conclusioni?
Proposi un test del DNA. Non perché avessi dubbi, ma per chiudere la questione una volta per tutte. Lui rifiutò.
«So che sono mie figlie,» disse, fissando il pavimento. «È solo che… non riesco a spiegarlo. Non sento un legame con loro.»
«Ma ci hai provato?» Quasi urlai. «Hai provato a stare con loro, a giocare, a parlare, a essere un padre? O aspetti che diventino tue da sole?»
Tacque di nuovo. E in quel silenzio sentivo la nostra famiglia sgretolarsi, il vuoto tra noi allargarsi.
Peggio ancora erano i suoi parenti. Mia suocera e la cognata si comportavano come se Ginevrina e Beatrice non fossero sangue loro. Venivano di rado, e quando lo facevano, si limitavano a far notare quanto «non somigliassero a Sandro». Una volta mia cognata, Elena, rise e disse:
«Vittoria, non è che le hai fatte con tuo nonno?» e rise, come se fosse divertente.
Non ce la feci più:
«Elena, non è più uno scherzo. Sono le mie figlie, e sono di tuo fratello. Se non vi piacciono, non venite.»
Si offese, ovviamente. Ma che altro potevo fare? Ero io a occuparmi delle bambine, mentre Sandro «non sentiva il legame», e i suoi parenti non facevano che aumentare il dolore. I miei genitori vivevano lontani, e poi erano ormai anziani. Mai mi ero sentita così sola.
Una sera, quando le bambine dormivano, decisi di affrontare la questione. Sapevo che non potevamo andare avanti così. O trovavamo una soluzione, o la nostra famiglia sarebbe crollata del tutto.
«Sandro,» cominciai, cercando di mantenere la calma, «so che sei turbato. Anche io sognavo una figlia che ti somigliasse. Ma sono le nostre bambine. Non è colpa loro se hanno ereditato i miei geni. E non è colpa mia. Mi fa male vederti allontanarti da loro.»
Restò in silenzio a lungo, poi sospirò profondamente:
«Mi odio per questo. Ma ogni volta che le guardo, vedo tuo padre. E mi sento fuori