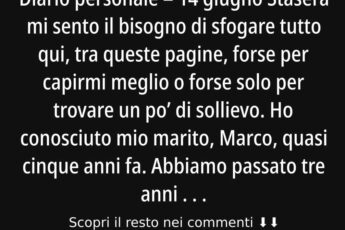10 aprile 2025
Oggi mi è bastata una frase di Eleonora: «Non ne posso più, Massimo, voglio divorziare». Lha detta con la stessa leggerezza con cui al mattino ordino un caffè. Non avrei immaginato che tutti quegli anni di notti insonni, di scuse inventate per giustificare i suoi ritardi, si sarebbero compressi in due semplici frasi.
Lho guardata perplesso, con quel sopracciglio alzato che di solito mette in dubbio tutto. «Sul serio? Perché?», le ho chiesto, quasi a ridere.
«Perché», ha risposto con un sorriso, «per lodore di profumo di altre donne sulle tue camicie, per i messaggi che ho visto per caso, per come mi guardi come se fossi solo un mobile da buttare via quando ti viene la voglia, per la collega, per la vicina di sopra, per la cameriera del bar dove abbiamo festeggiato il nostro anniversario».
«Per tutto», ha sbattuto le spalle. «Sono stanca».
Il processo di separazione si è allungato per mesi, trasformandosi in una spirale di udienze, documenti e atti che mi hanno fatto dimenticare persino di mangiare. Eleonora appariva al tribunale con il vestito di un tempo, quello che indossava prima della gravidanza; il tessuto tirava sui fianchi, la cerniera restava chiusa a metà e lei si copriva con un cardigan liscio, lunica cosa decente senza pelucchi.
Io, al contrario, sedevo di fronte a lei in un completo nuovo di zecca, giacca sagomata, cravatta a righe bizzarre, lultimo grido della moda milanese. Guardavo quella cravatta e cercavo di ricordare lultima volta che avevo comprato qualcosa per me. Due giorni fa ho lottato per trovare cento euro per delle scarpe invernali per Arturo, il nostro figlio. Erano quasi nuove, costavano cinquecento euro, vendute da un negoziante di periferia. In autobus, affollato, pensavo a quanto gli servissero ancora pantaloni per lestate, una giacca, un cappello.
Il nostro avvocato ha poi steso sul tavolo le stampe bancarie.
«Secondo l estratto conto», ha detto con voce professionale, «negli ultimi diciotto mesi il convenuto ha speso nei ristoranti e nei locali di svago lequivalente del budget annuale della famiglia».
Eleonora ha fissato quei numeri, incapace di ricostruirli in unimmagine coerente. Ristoranti, discoteche, un negozio di fiori (che lui non le ha mai regalato), gioielleria (orecchini, ciondoli, anelli) tutto denaro che non le era destinato.
Nel frattempo lei contava se potesse permettersi una banana per Arturo, non un grappolo; tagliava mele a fette sottili per farle durare più a lungo, faceva la colazione a base di acqua perché il latte era diventato troppo caro, e sorseggiava tè senza zucchero convinta che fosse meglio per la linea.
Io ho tossito, sistemato la cravatta.
«Sono soldi miei. Li ho guadagnati», ho risposto.
Dopo ludienza mi ha raggiunta nel parcheggio, mi ha afferrato il gomito e mi ha girato verso di me.
«Pensi di riuscire a farmi pagare?», mi ha sputato nella voce, «ti porto via Arturo. Lo prendi, lo porti via».
Mi ha guardato in silenzio, la donna con cui avevo condiviso cinque anni, il bambino che avevo generato, il periodo di congedo maternità che laveva svuotata di lavoro, di identità, di tutto tranne lamore per la famiglia.
«Sei una donna inutile», ha continuato, trionfante, «non sai fare nulla. Che cosa puoi dargli? Povertà? Io lo farò diventare un uomo, non un nulla. E sarai tu a pagare gli alimenti, non io!»
Quelle parole di «inutile» le aveva già sussurrate più volte, con la stessa monotonia di un campanile che suona ogni ora.
«Sei una donna inutile, non capisci le cose più semplici. Sei una donna inutile, hai dimenticato di nuovo. Sei una donna inutile, che cosa ti toglierò». E io lho accettata, perché lamavo, perché era la famiglia, perché dovevo.
Il suo exmarito non ha smesso di chiamare. Pretendeva che le dessi Arturo, così da non contaminarlo con la sua influenza, così da non sprecare gli alimenti in cose incomprensibili.
Una notte, al telefono, non ho più retto.
«Va bene», ho detto. «Prendilo».
Il silenzio è rimasto sospeso dallaltra parte.
«Cosa?», ha chiesto. «Ho detto va bene. Porto Arturo domani».
E lo ho fatto.
Arturo è entrato nella casa mia a Roma, piccolo, con lo zaino a forma di dinosauro e una borsa contenente il pigiama preferito, un libro di astronomia, e un coniglietto di peluche con lorecchio strappato. Lho guardato come se fosse uscito dal nulla.
«Bene», ho messo la borsa a terra. «Crescilo». Il suo piccolo ha chiesto «Mamma?», la voce tremante.
Lho preso in braccio, lo ho stretto, ho inspirato il profumo del suo shampoo e del sole di primavera.
«Stai con papà per un po, ok? È unavventura. Io ti chiamerò tutti i giorni».
Sono uscito senza voltarmi, mi sono appoggiato al muro di un vicolo e ho pianto, spinto da una rabbia che non riuscivo più a contenere. Le chiamate di Eleonora mi stancavano, la sua voce, le sue lamentele.
Unora dopo, Massimo cioè io ho sentito il telefono squillare.
«Eleonora, a che ora porti Arturo allasilo? Domani o?», ho balbettato.
«Allasilo?», ho replicato, confuso. «Va in asilo tutti i giorni, dalle otto del mattino. Te lo sei dimenticata?»
«Come posso sapere», ho risposto, «scioglierò la questione».
Ho portato Arturo da Valentina Bianchi, la madre di Eleonora, quella stessa sera, dicendo che avrei risolto i conti «in due ore». Poi sparii.
Il quarto giorno, il telefono della suocera ha squillato. Valentina, con la voce spezzata, mi ha accusato: «Hai perso la coscienza? Hai lasciato il bambino e ti diverti! Sono già sessantanni, la pressione!».
«Lho portato al papà», ho detto placido, «quello che doveva crescere un vero uomo, che minaccia di portarmi in tribunale».
«Lui è occupato!», ha insistito, «e io? Ho anchio una vita da gestire!».
«Allora, quando?», ho replicato, «anche io lavoro, tutti i giorni, da solo».
La conversazione è terminata in un silenzio carico di tensione, seguito da un breve squillo.
Due giorni dopo, Valentina ha richiamato: «Vieni a prendere Arturo, non ce la faccio più». Sono arrivato la sera, Arturo è corso verso di me, mi ha avvolto le braccia e ha gridato «Mamma, mamma, mamma» come un incantesimo. Lho cullato, gli ho detto: «Basta avventure, torniamo a casa».
Valentina è rimasta sulla soglia, incrociando le braccia, con unespressione di fastidio più che di rimorso. Lunica sorpresa è che la nuora non è così inutile come credevano.
Massimo è scomparso. Non ha più chiamato, né scritto, né bussato con minacce. I suoi genitori sono venuti una volta, dopo qualche anno. Arturo, ormai di undici anni, frequenta la seconda elementare, nuota e costruisce set LEGO con passione.
Un giorno, mentre apriva la porta, ha chiesto a due sconosciuti: «Chi siete?». Valentina, esultando, ha risposto: «Siamo la nonna e il nonno!». Arturo, però, ha sbuffato: «Mamma, ci sono delle persone qui».
Il dialogo è stato breve e teso. Valentina era furiosa per il mancato riconoscimento, Nikolai, il nonno, scuoteva la testa, parlando di genitorialità moderna. Hanno lasciato la casa con una frase finale: «Quel ragazzino è terribile e maleducato, proprio come sua madre». Ho chiuso la porta e ho riso, chiedendomi davvero cosa si aspettassero.
Il tempo è volato. Arturo è ormai un ragazzo alto, con il mento deciso di sua madre e lo sguardo tagliente di suo padre. Non chiede del padre, forse un giorno lo farà; allora gli darò una risposta onesta, senza addolcire né ferire. Per ora, noi due ce la caviamo.
Unamica, Caterina, è venuta piangere in cucina, le lacrime hanno macchiato il trucco.
«Mi minaccia di portare via Sergio», singhiozzava. «Assume avvocati, raccoglie documenti non so cosa fare!»
Le ho versato il tè, spostato la zuccheriera. «Caterina, vuoi un consiglio?». Ho sorriso. «Porta via il bambino da solo. Prendi le tue cose, porta Sergio dal papà e dillo: cresci il bambino. E vattene. Tre giorni, forse meno. Così il problema sparirà».
«Sei seria?», ha chiesto, stupita. «Assolutamente. Lho provato su me stesso». Il suo sguardo ha mostrato confusione, ma anche una flebile speranza.
«E poi?», ha chiesto. Ho sorseggiato il tè, appoggiato la schiena sulla sedia. «Poi vivrai la tua vita senza chi ti usa solo per riempire il famiglia dei social».
Pensavo ancora a Eleonora, ai suoi genitori, a tutti gli episodi ormai superati. Ho capito una lezione che mi porto dentro: la dignità non può essere comprata né concessa; si difende con decisione, anche quando il costo è il dolore più profondo.
Mi chiudo qui, con la certezza che, nonostante le ferite, ho imparato a non sacrificare me stesso per chi non sa più riconoscere il valore di quello che ha.