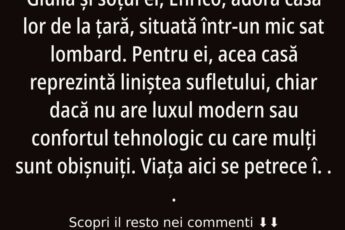Da ormai tre anni, vivo come in un incubo che non accenna a finire. Tutto cominciò il giorno in cui mio figlio, Matteo, un uomo di trentacinque anni, portò nella nostra casa di due stanze a Milano la sua nuova moglie, una certa Giada, con i suoi due figli di un matrimonio precedente. All’inizio disse che sarebbe stato temporaneo. Temporaneo… Quante volte noi donne crediamo a questa parola…
Sono passati tre anni, e nella nostra casa non abita più una famiglia, ma un esercito: io, mio figlio, sua moglie, i suoi due figli e… adesso è di nuovo incinta. Dio, nella mia vecchiaia, non mi ha concesso né pace né conforto, né un attimo di respiro. Forse mi sta punendo per qualcosa.
Giada non è disabile né malata, ha poco più di trent’anni, ma lavorare non vuole. Dice di essere «occupata con i bambini». Peccato che i bambini vadano all’asilo ogni mattina. Lei, invece, no. Non va a lavorare, va a passeggiare. O da un’amica. O a farsi le unghie. Dove esattamente, non lo so.
Matteo all’inizio mi rassicurava: avrebbero sistemato i documenti, trovato un lavoro, affittato una casa o preso un mutuo. Io ho creduto. Sono una madre, ho sempre sperato. Ma un anno è passato, poi un altro, e ora il terzo. Nulla è cambiato. Solo la pancia di Giada è cresciuta.
Non posso dire che sia sgarbata con me. Non è maleducata, parla con gentilezza. Ma in casa non fa nulla. Non lava i pavimenti, non sparecchia, non cucina. Nemmeno si occupa davvero dei suoi figli: accende i cartoni animati, gli mette qualcosa in mano e se ne sta al telefono. La sera, solo silenzio da lei e urla dai bambini.
Tutto il lavoro di casa ricade su di me. Mi alzo alle quattro del mattino. Faccio la donna delle pulizie in due uffici, lavo i pavimenti, torno a casa per le otto, e prima ancora di bere un caffè devo già pulire, fare il bucato, cucinare. Mentre tutti sono fuori, lavoro da sola in cucina per togliere il grasso, lavo i vestiti, preparo il pranzo. Perché a mezzogiorno tornano mio figlio e sua moglie, e devono mangiare. Poi di nuovo lavoro, cena, e solo dopo le nove di sera posso finalmente sedermi. A volte resto in piedi in cucina e piango. Di stanchezza.
La mia pensione va nelle bollette e nella spesa. Lo stipendio di Matteo non basta per tutta questa folla. E Giada, ovviamente, è «in maternità». Anche prima di esserci andata ufficialmente.
Recentemente ho provato a parlare con mio figlio. Gli ho detto che la casa è piccola, siamo troppi, che è troppo pesante per me, la salute mi abbandona. Sono finita in ospedale—la pressione è schizzata alle stelle mentre cucinavo. Il medico mi ha vietato ogni sforzo. Lui ha solo scrollato le spalle e ha detto:
“Mamma, non vivi qui da sola. La casa è anche mia. Non andremo da nessuna parte. Non ci sono soldi. Quindi devi sopportare.”
Ecco tutta la conversazione.
Ecco tutta la gratitudine.
Ecco tutto mio figlio.
Penso di andarmene. Di farmi prestare dei soldi, indebitarmi, ma trovare un angolo per me. Anche se più piccolo, anche se senza ristrutturare. Basta che ci sia silenzio. Basta che non ci sia nessuno. Perché non ce la faccio più. Non sopporterò un altro bambino in questa casa. Qui non si vive più, si sopravvive.
Io non vivo più. Io servo. Sono una schiava. Nella mia stessa casa. Nella mia vecchiaia. E la cosa più terribile è che nessuno, nessuno di loro si chiede mai come mi senta. Loro semplicemente vivono. E aspettano che io cucini, pulisca, stia zitta.
Vorrei gridare, ma stringo le labbra. Non ce la faccio più, eppure continuo. Perché, altrimenti, sarebbe tutto sporco, vuoto e freddo. Perché sono una madre. Perché sono una nonna. Perché sono sola.