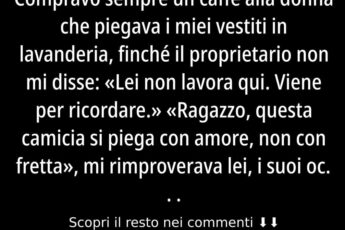Quel giorno una donna venne da me, una che non vedevo sulla mia soglia da almeno cinque anni. Tamara Nardini. A Monteluce tutti la chiamavano “la Baronessa” dietro le spalle. Non per il marito, che era solo un modesto impiegato, ma per quel suo portamento altero, quello sguardo tagliente più affilato di un bisturi, e quell’orgoglio che avrebbe potuto circondare il nostro paesino tre volte come un fossato. Camminava sempre a schiena dritta, il mento sollevato, come se non calpestasse il fango delle nostre strade ma i marmi di un palazzo. E con nessuno era davvero amica, al massimo un cenno con la testa – e la conversazione finiva lì.
Eppure eccola lì, sulla soglia del mio ambulatorio. Irriconoscibile. La schiena ancora dritta per abitudine, ma negli occhi una tristezza braccata. Si era tirata il foulard colorato fin sopra le sopracciglia, come per nascondersi. Esitava, non osava varcare la soglia.
“Entra pure, Nardini,” le dico gentilmente. “Che fai, vuoi far entrare tutto il freddo? Vedo che non sei venuta per un’aspirina.”
Entrò, si sedette sullo sgabello vicino alla stufa, le mani appoggiate sulle ginocchia. Mani che erano sempre state curate, ma ora le vedevo secche, screpolate, le dita che tremavano leggermente. Taceva. E io non la pressai. Le versai del mio tè, alla menta e tiglio. Glielo posi davanti.
“Bevi,” le dissi. “Ti scalderà l’anima.”
Prese la tazza, e negli occhi le brillarono lacrime. Non le lasciò scendere, no, l’orgoglio glielo impediva, ma rimasero lì, come acqua in un pozzo.
“Sono tutta sola, Adele,” sospirò finalmente, e la voce le si spezzò. “Non ce la faccio più. Mi sono slogata un polso, niente di rotto per fortuna, ma quel maledetto dolore… non posso nemmeno portare la legna o l’acqua. E la schiena mi duole così che non riesco nemmeno a respirare.”
E la sua lamentela sgorgò come un ruscello primaverile, torbido e amaro. Io ascoltavo, annuivo, ma non vedevo la sua attuale disgrazia – vedevo ciò che era accaduto cinque anni prima. Ricordavo come nella sua casa, la più ordinata del paese, si sentivano risate. Suo figlio unico, Matteo, bel ragazzo e gran lavoratore, si era portato a casa una fidanzata. Livia.
Una ragazza – un angelo silenzioso. Matteo l’aveva portata dalla città. Occhi limpidi, fiduciosi. Capelli biondi raccolti in una spessa treccia. Mani abituate a ogni lavoro, sebbene delicate. Perché piacesse a Matteo era chiaro. Ma perché non piacesse a Tamara – questo nessuno nel paese riusciva a capirlo.
Eppure non le andava bene, punto. Dal primo giorno Tamara la divorava viva. Non sedeva come si deve, non guardava come si deve. Il minestrone non era abbastanza rosso, i pavimenti non abbastanza puliti. Preparava la composta – “troppo zucchero, sprecona”. Zappava l’orto – “hai strappato tutta l’ortica per la minestra, incapace”.
Matteo all’inizio la difendeva, poi si arrese. Era un mammone, cresciuto sempre sotto la sua ala. Oscillava tra loro come una foglia di pioppo al vento. E Livia taceva. Solo dimagrava e impallidiva giorno dopo giorno. Una volta la incontrai al pozzo, e vidi che aveva gli occhi lucidi.
“Perché sopporti, piccola?” le chiesi.
E lei mi sorrise amaramente:
“Dove potrei andare, zia Adele? Lo amo. Forse si abituerà a me, avrà pietà…”
Non ebbe pietà. L’ultima goccia fu una tovaglia ricamata a mano, fatta dalla madre di Tamara. Livia l’aveva lavata con poca cura, e i colori erano sbiaditi. Oh, che scenata… Si sentì in tutta la via.
Quella stessa notte Livia se ne andò. Senza far rumore. Matteo la mattina dopo impazzì, la cercò dappertutto, poi andò dalla madre, gli occhi secchi, spaventosi.
“Sei stata tu, mamma,” disse solo. “Tu hai ucciso la mia felicità.”
E se ne andò anche lui. Si sparse la voce che trovò la sua Livia in città, si sposarono, ebbero una bambina. Ma alla madre – neanche un passo. Né lettere, né chiamate. Come se l’avesse tagliata via.
Tamara all’inizio fece la dura. “E meno male,” diceva alle vicine. “Non mi serve una nuora del genere, e mio figlio, a quanto pare, non è più mio figlio se ha scambiato sua madre per una gonnella.” Ma invecchiò all’improvviso, si rinchiuse. Nella sua casa perfetta, pulita come una sala operatoria, rimase sola. E ora eccola davanti a me, e tutto il suo orgoglio, tutta la sua alterigia da baronessa, era caduta come la buccia da una cipolla. Restava solo una donna anziana, malata, sola. Il boomerang, sai, non vola per cattiveria, semplicemente gira in tondo e torna da dove è partito.
“Non servo a nessuno, Adele,” sussurra, e una prima, avara lacrima le scivola sulla guancia. “Mi converrebbe impiccarmi.”
“Che peccato dire certe cose, Nardini,” rispondo severa, ma la pietà mi strozza. “La vita è per viverla, non per appenderti. Dai, ti faccio un’iniezione, la schiena ti passerà. Poi vedremo.”
Le feci l’iniezione, le strofinai la schiena con un unguento profumato. Sembrò rianimarsi un po’, raddrizzò le spalle.
“Grazie, Adele,” disse. “Non credevo che qualcuno potesse ancora essere gentile con me.”
Se ne andò, e il mio cuore si appesantì. Curo, sì, ma ci sono malattie per cui non esistono medicine né iniezioni. Questa malattia si chiama solitudine. E si cura solo con un’altra persona.
Per due giorni ci pensai, mi tormentai. Il cuore non era in pace. Poi presi e trovai, tramite conoscenti a Poggibonsi, il numero di Matteo. Le mani mi tremavano mentre componevo. Cosa gli avrei detto? Come iniziare? E lui rispose, voce riconoscibile, ma più matura, un po’ roca.
“Matteo, buongiorno,” dico. “Sono Adele di Monteluce. Ti disturbo?”
Rimase in silenzio per mezzo minuto. Pensavo avesse riattaccato.
“Buongiorno, zia Adele,” rispose alla fine. “È successo qualcosa?”
“È successo, figliolo,” sospiro. “Tua madre è tutta sola. Sta cedendo. Soffre, ma non lo mostra. Orgogliosa come sempre…”
Di nuovo silenzio. Sento sua moglie, Livia, chiedergli qualcosa a bassa voce. Poi la sua voce, sempre dolce, ma ora forte, sicura:
“Dammi, parlo io.”
“Buongiorno, zia Adele! Come sta? Sta molto male?”
E le raccontai tutto. Senza nascondere nulla. Del polso, della schiena, delle lacrime che non volevano cadere. Livia ascoltò, senza interrompere.
“Grazie per aver chiamato,” disse decisa. “Verremo. Sabato aspettateci. Solo… non diteglielo, per favore. Sarà una sorpresa.”
Ecco, pensai, che cuore ha questa ragazza. L’avevano cacciata di casa, l’avevano riempita di fango, e in lei non era rimasto nemmeno un briciolo di rancore