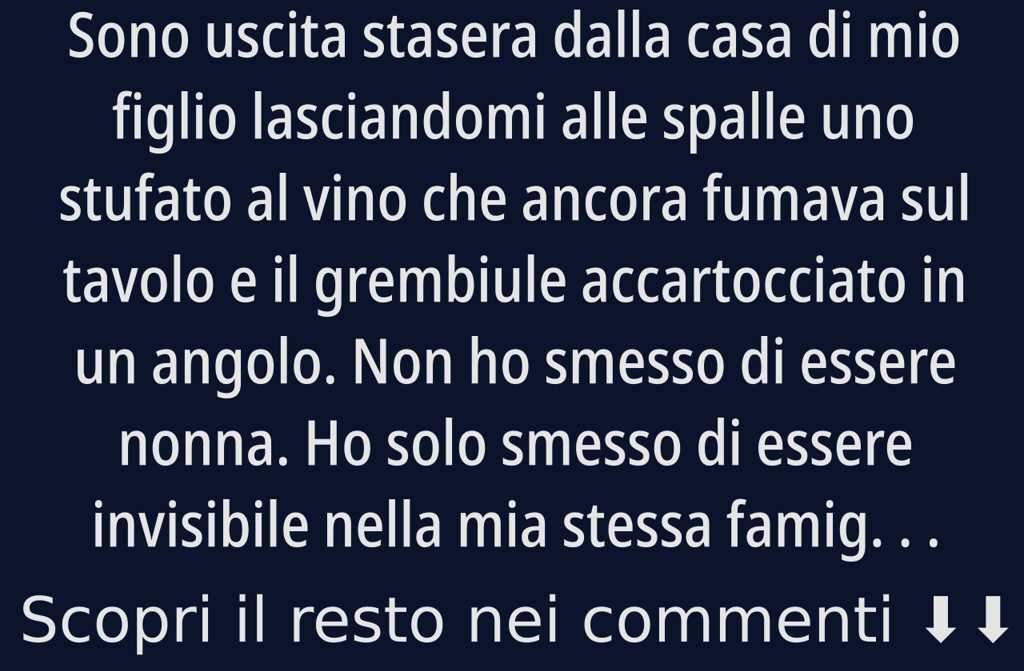Sono uscita stasera dalla casa di mio figlio lasciandomi alle spalle uno stufato al vino che ancora fumava sul tavolo e il grembiule accartocciato in un angolo. Non ho smesso di essere nonna. Ho solo smesso di essere invisibile nella mia stessa famiglia.
Mi chiamo Giovanna. Ho sessantotto anni, e negli ultimi tre anni ho gestito la casa di mio figlio Marco senza uno stipendio, senza complimenti e senza nemmeno una pausa caffè decente. Sono quel famoso paese che tutti evocano con nostalgia, ma in questi tempi pare che i vecchi del villaggio debbano solo portare il peso in silenzio e non fiatare mai.
Vengo da unepoca in cui qualche ginocchio sbucciato era normale e larrivo del buio era il segnale per rientrare a casa. Quando ho cresciuto Marco, si cenava alle diciannove in punto: o mangiavi quello che cera o niente fino a colazione. Niente laboratori emotivi: responsabilità e basta. Non era perfetto, ma così venivano su figli che sopportavano i no, rispettavano la fatica e stavano in piedi da soli.
Mia nuora, Caterina, non è cattiva. Anzi, è una madre devota che adora il suo piccolo Leonardo. Ma vive nellansia: ha paura delle etichette sugli alimenti, di sbagliare, di soffocare la sua individualità, di essere giudicata da qualche sconosciuto su Instagram.
E così, mio nipote di otto anni gestisce la casa.
Leonardo è sveglio e gentile quando gli conviene. Non ha mai sentito la parola no senza che diventasse una trattativa infinita.
Stasera era martedì il giorno più lungo per me. Sono arrivata prima della luce per preparare Leonardo alla scuola, visto che i suoi fanno i manager e pagano un mutuo da capogiro per una casa dove giusto dormono. Ho lavato, portato a spasso il cane Argo, sistemato la dispensa dove snack bio costosissimi convivono con biscotti del supermercato comprati con la mia pensione.
Volevo una serata calda. Ho passato quattro ore a cucinare uno stufato alla piemontese manzo, patate, carote, rosmarino la cena che profuma la casa e il cuore.
Marco e Caterina sono rientrati tardi, incollati ai cellulari, parlando di scadenze e riunioni. Leonardo era steso sul divano, illuminato dalla luce del tablet, intento a guardare qualcuno urlare per un videogioco.
La cena è pronta, ho annunciato, posando il vassoio.
Marco si è seduto senza distogliere lo sguardo dallo schermo. Caterina ha storto il naso.
Stiamo cercando di limitare la carne rossa, ha sussurrato. E le carote sono bio? Lo sai che Leonardo è delicato.
È cena, ho risposto. Cibo vero.
Marco ha chiamato Leonardo. Risposta dal divano.
No! Sono impegnato!
Ai miei tempi, lo schermo sarebbe sparito in un nanosecondo. Stavolta, niente.
Caterina è andata a trattare. Ho sentito promesse, premi, abbracci terapeutici.
Leonardo si è presentato col tablet in mano, ha guardato lo stufato e ha spinto via il piatto.
Fa schifo, ha detto. Voglio le crocchette.
Marco zitto. Caterina già verso il freezer per le crocchette.
Qualcosa dentro di me si è rotto. Non era rabbia, ma tristezza.
Sedetevi, ho detto.
Caterina si è bloccata.
Mangerà quello che cè o si alza da tavola, ho detto pacata.
Marco finalmente ha alzato gli occhi. Non ricominciare, siamo distrutti. Non vale la pena traumatizzarlo.
Trauma? ho ribattuto. Pensate che negare una crocchetta sia un trauma? Gli state insegnando che il mondo gira secondo i suoi capricci. Che la fatica altrui non conta.
Noi facciamo genitorialità dolce, ha ribattuto fredda Caterina.
Questa non è dolcezza. È resa. Siete così spaventati dalla sua infelicità che lavete messo al centro delluniverso. Io non sono più nonna qui: sono una colf.
Leonardo ha urlato e tirato la forchetta. Caterina a rincorrerlo per consolarlo.
La nonna è solo un po agitata, ha detto.
È stato il mio basta.
Ho sciolto il grembiule, lho piegato, e posato accanto allo stufato intonso.
Hai ragione, ho detto, sono proprio agitata. Vedere mio figlio fare lo spettatore nella sua casa, un bambino crescere senza confini, e non sentirmi rispettata sì, fatico.
Ho preso la borsa.
Vai via? ha chiesto Marco. Domani devi stare con lui.
No, ho detto.
Non puoi uscire così.
Posso eccome.
Sono uscita nella strada silenziosa.
Ci servi, ha gridato Caterina. La famiglia si aiuta.
Il paese si fonda sul rispetto, ho risposto. Questo non è un paese, è uno sportello ed è chiuso.
Ho guidato fino al parco. Ho spento il motore, abbassato il finestrino, lasciando entrare odore derba tagliata e pioggia.
E poi eccole: piccole luci gialle nellerba alta. Lucciole.
Le prendevo con Marco da piccolo. Le guardavamo brillare e poi le lasciavamo libere. Gli insegnavamo che le cose belle non si possono controllare.
Sono rimasta lì, a guardarle danzare.
Il cellulare vibra in continuazione. Scuse, accuse, sensi di colpa.
Non rispondo.
Abbiamo confuso il dare tutto ai figli con il darci per intero. Scegliamo la presenza virtuale e la disciplina facile. Temiamo di non piacere e così, perdiamo la forza di farli crescere davvero forti.
Amo abbastanza mio nipote per lasciarlo faticare.
Amo abbastanza mio figlio per lasciargli imparare.
E per la prima volta da anni, amo anche me abbastanza per tornare a casa, cenare in pace e lasciare le lucciole libere.
Il paese è chiuso per lavori.
Quando riaprirà, il biglietto dingresso sarà il rispetto.