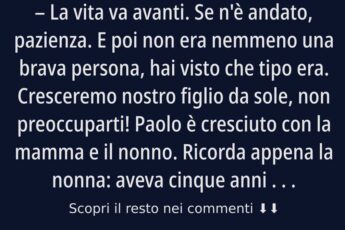Diario, 12 ottobre
Quella sera arrivò nel mio ambulatorio il più silenzioso e paziente degli uomini del nostro paese, Stefano Moretti. Conoscete quel tipo di persone? Gente che sembra fatta di ferro, con la schiena dritta, mani grandi come badili, segnate dal lavoro duro, ma negli occhi una calma antica, simile a quella di un lago di montagna. Stefano non dice mai una parola di troppo, non si lamenta mai. Se c’è da aggiustare una porta, aiutare una vicina, portare legna a una vedova, lui c’è. Fa tutto senza un lamento, annuisce e se ne va, lasciando dietro di sé una scia di silenziosa affidabilità.
Ma quella sera ancora lo vedo davanti a me. La porta si è aperta piano, come se non fosse una persona a entrare, ma una corrente di vento dautunno. Sullo stipite, lui armeggiava nervosamente col cappello di lana tra le mani, occhi bassi e spalle curve. Il cappotto era fradicio per via della bruma, gli stivali sporchi di fango. Mai lavevo visto così: piegato, quasi spezzato, e mi si stringeva il cuore a guardarlo.
Vieni dentro, Stefano, perché resti lì impalato? gli ho detto con dolcezza mentre già mettevo il bollitore sul fornello. Si sa, certo malessere non si cura con pillole, ma con un buon tè caldo e un po di timo.
Si è seduto alla punta della brandina, la testa ancora china, silenzioso. Lo spazio era pieno solo del ticchettio dellorologio sul muro, che scandiva i secondi del suo mutismo. Un silenzio pesante, peggiore di qualsiasi urlo; riempiva la stanza, la rendeva cupa. Gli ho posato in mano un bicchiere di tè caldo, pregando che almeno il calore gli scuotesse le dita gelate.
Ha stretto il bicchiere, lha portato alle labbra, ma le mani tremavano e il tè rischiava di cadere. E poi lho vista: una lacrima, sola, decisa e spaventosa come piombo fuso, gli è scivolata sulla guancia non rasata. Non piangeva rumorosamente, non singhiozzava, semplicemente piangeva. Le lacrime scorrevano mute tra la barba, disperse nella penombra.
Me ne vado, signora Agnese ha sussurrato. Basta. Non ce la faccio più. Le forze mi hanno abbandonato.
Mi sono seduta accanto a lui e gli ho poggiato la mano ruvida sulla sua. Ha tremato, ma non si è sottratto.
Da chi stai scappando, Stefano?
Dalle mie donne voce roca, quasi spenta. Da mia moglie, da Olga da mia suocera. Mi stanno distruggendo, Agnese. Come due falchi. Qualsiasi cosa faccia: cucino la zuppa quando Olga è in campagna troppo salata, le patate sono tagliate male. Aggiusto una mensola storta, tutti gli altri mariti sono meglio. Zappo lorto poco profondo, hai lasciato le erbacce. Così ogni giorno, ogni anno. Niente una parola gentile, niente uno sguardo. Solo punture, come se fossi ortica.
Si è fermato e ha bevuto un sorso.
Non sono mica un signore, Agnese. Capisco quanta fatica cè. Olga lavora tutto il giorno nei campi, si stanca, si arrabbia. Mia suocera, Rosa Bertelli, ha le gambe rovinate, non si muove quasi più, e la sua rabbia per la sofferenza la scarica sul mondo. Capisco tutto, sopporto. Mi alzo prima di tutti, accendo la stufa, porto lacqua, do da mangiare agli animali, e poi a lavorare. Torno la sera mai una cosa che vada bene. Appena rispondi, urlano tre giorni, se taci, peggio: Perché non parli? Cosa stai pensando? Il cuore, Agnese, non è di pietra. Si consuma anche quello.
Guardava il piccolo fuoco nella stufa e parlava, parlava sembrava un fiume rotto che esonda. Raccontava di settimane in cui nessuno gli rivolgeva parola, di sussurri alle sue spalle. Di quella volta in cui nascosero la marmellata migliore per sé, senza lasciargliene. Di quando per il compleanno di Olga le comprò uno scialle con la gratifica del lavoro, e lei lo buttò nel baule: Era meglio se ti compravi degli stivali, mendicante che non sei altro. Guardavo quelluomo, così forte che avrebbe potuto abbracciare un toro, ma adesso, davanti a me, sembrava un cucciolo abbandonato sotto la pioggia. Sentii una tristezza profonda, una malinconia nera per lui.
Questa casa lho costruita io, con le mie mani sussurrò. Ricordo ogni trave. Speravo di fare un nido, invece è una gabbia. E dentro, uccelli che ringhiano. Stamattina la suocera di nuovo: La porta cigola, non fai mai nulla per bene. Sei inutile. Ho preso la scure volevo sistemare la porta. Ma poi fissavo quel ramo di melo una voce brutta mi ha attraversato la mente. Per poco non cedevo. Ho fatto lo zaino alla buona, un po di pane, e sono venuto qui. Dormirò dove capita, domani prendo il treno e via. Chissà, magari quando non ci sarò più, una parola gentile la diranno forse troppo tardi.
Fu lì che compresi: non era solo stanchezza, era la sua anima, appesa a un filo. Non potevo lasciarlo andare.
Senti, Moretti dissi decisa, con la voce che uso solo nei casi più seri. Asciugati la faccia, va bene? Non è roba da uomini, piangersi addosso così. Vuoi andartene? Ma hai pensato a loro? Olga riuscirà a tirare avanti da sola? Rosa Bertelli, con quelle gambe? Sei tu a prenderti cura di loro.
E chi si prenderà cura di me, Agnese? rispose lui amaro. Chi pensa mai a me?
Io ci penso replicai, ferma. E ti curerò io. Hai una malattia seria: si chiama usura dellanima. Terapia? Ne esiste solo una. Ora ascolta: torni a casa, senza fiatare. A qualunque protesta, rispondi col silenzio. Niente occhi a nessuno, ti stendi sul letto e guardi il muro. E domani mattina vengo io da voi. E tu non lasci il paese, hai capito?
Mi guardò dubbioso, accese negli occhi una fievole speranza. Bevve il suo tè fino in fondo, annuì silenziosamente, si alzò e sparì senza voltarsi. Rimasi lungo tempo davanti al fuoco, chiedendomi che medico sono se la vera medicina, la più efficace, è una parola gentile che spesso ci neghiamo a vicenda.
Appena spuntò il sole lindomani, stavo già bussando al loro cancello. Mi aprì Olga, viso tirato e stanco.
Che cè, Agnese, così presto?
Sono venuta a vedere Stefano, dissi senza lasciarmi intimidire, entrando in cucina.
In casa faceva freddo, laria era triste. Rosa era seduta sulla panca con la sciarpa sulle spalle, occhio torvo. Stefano, sdraiato a letto, guardava il muro, come gli avevo detto.
Che vuole da lui, è sano come un toro, sta lì a fare nulla! sibilò la suocera. Lavorare dovrebbe.
Mi avvicinai a Stefano, gli tastai la fronte per finta, lo ascoltai col fonendoscopio anche se sapevo già tutto. Gli guardai negli occhi: tranquillo come un topo, ma con i muscoli della mascella che tremavano.
Mi raddrizzai e mi rivolsi a loro senza sorriso.
Vi dico la verità, signore mie. Stefano qui è allo stremo delle forze. Il cuore come una corda tirata troppo. Ancora un po e si spezza. Allora resterete sole.
Si scambiarono uno sguardo preoccupato. Olga sembrava scossa, in Rosa leggevo diffidenza.
Macché, Agnese, ma che dici? Ieri spaccava la legna come sempre!
Quello era ieri tagliai corto. Oggi non regge più. Lo avete sfiancato, col vostro continuo lamentarvi, col criticare. Lo credete fatto di marmo? Ha un cuore. E ora gli fa male più del dovuto. Io gli prescrivo riposo totale, niente lavori domestici. Pieno silenzio, basta urla o rimproveri. Solo cura e tenerezza, come fosse cristallo fragile. Se succede ancora qualcosa, io vi spedisco in ospedale e da lì non si sa mai chi torna.
Avevo appena finito di parlare, quando vidi il terrore vero nei loro occhi. Nonostante le lamentele, su Stefano si poggiavano tutte. Lui era la loro roccia, silenziosa ma affidabile. Pensare di perderlo le paralizzava. Olga andò vicino al marito, pose una mano sulla sua spalla. Rosa restò muta, ma i suoi occhi cercavano una via di fuga nella stanza.
Me ne andai, lasciandole sole coi loro pensieri e con la loro paura. Attesi.
I primi giorni, Stefano me li raccontò sottovoce dopo: in casa regnava un silenzio incredibile. Camminavano sulle punte, parlavano solo a bassa voce. Olga gli portava il brodo, lo poggiava sul comodino e scappava via. Rosa, passando, faceva il segno della croce sulla sua schiena. Era tutto imbarazzato, strano, ma almeno niente più urla.
Poi il ghiaccio cominciò a sciogliersi. Una mattina Stefano fu svegliato dal profumo di mele cotte al forno. Le sue preferite, con la cannella, proprio come gliele preparava sua mamma. Olga era lì, seduta vicino al suo letto a sbucciare una mela. Quando notò che lui era sveglio, trasalì.
Mangia, Stefano sussurrò. Sono calde.
E per la prima volta in anni gli occhi di lei non erano pieni di rabbia, ma affetto. Impacciato, inesperto, sincero.
Due giorni dopo Rosa gli portò le calze di lana, fatte da lei.
Tieni i piedi al caldo borbottò. Cè corrente dal vetro.
Stefano fissava il soffitto, ma quella volta si sentì visto. Non solo come braccia forti, ma come una persona che vale. Che hanno paura di perdere.
Dopo una settimana tornai. La scena era irriconoscibile: dentro cera calore, profumo di pane fresco. Stefano sedeva a tavola, ancora pallido, ma con lo sguardo più vivo. Olga gli versava del latte, Rosa disponeva la focaccia nel vassoio. Non erano una famiglia perfetta, ma laria era diversa, più leggera. Lo sguardo grato che Stefano mi rivolse era quasi una benedizione. Accennò un sorriso e tutta la casa si rischiarò. Anche Olga ricambiò timidamente. Rosa si voltò, asciugandosi gli occhi con lorlo del fazzoletto.
Non servì più che li curassi. Avevano imparato a essere medicina luno per laltro. No, non erano diventati la famiglia ideale da romanzo: Rosa brontolava ancora, Olga ogni tanto sbuffava. Ma dopo si rimboccavano le maniche per accomodare il dannoun tè caldo con lamponi per lui, una carezza sulla spalla dopo lo scatto nervoso. Avevano finalmente smesso di vedere solo gli errori: sotto gli sbagli cera una persona, stanca, fragile, amata.
Passando davanti casa loro, ora spesso li vedo tutti e tre la sera, seduti sulla panchina: Stefano che lavora con un pezzo di legno, le donne che chiacchierano a voce bassa mentre sgranano fagioli. E sento dentro un calore profondo, quella pace che solo un paese può dare. Si capisce, guardandoli, che la felicità non sta nei regali costosi o nelle parole gridate. Sta nel profumo di torta di mele, nel calore di calze fatte a mano, nella sensazione che sei a casa. E che qualcuno ha bisogno di te.
Chissà, miei cari, se serve davvero una paura così grande per imparare a voler bene davvero quello che abbiamo. Forse sì. E allora, la medicina più potente resta sempre una parola buona sussurrata nel momento giusto. Tu che ne pensi?